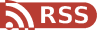|
ETTERA
APOSTOLICA
DIES
DOMINI
DEL SANTO PADRE
GIOVANNI PAOLO II
ALL'EPISCOPATO, AL CLERO E AI FEDELI
SULLA SANTIFICAZIONE DELLA DOMENICA
Venerati Fratelli
nell'episcopato e nel sacerdozio,
Carissimi Fratelli e Sorelle!
1. Il giorno del Signore
— come fu definita la domenica fin dai tempi apostolici (1)
— ha avuto sempre, nella storia della Chiesa, una
considerazione privilegiata per la sua stretta connessione col
nucleo stesso del mistero cristiano. La domenica infatti
richiama, nella scansione settimanale del tempo, il giorno
della risurrezione di Cristo. È la Pasqua della settimana,
in cui si celebra la vittoria di Cristo sul peccato e sulla
morte, il compimento in lui della prima creazione, e l'inizio
della « nuova creazione » (cfr 2 Cor 5, 17). È il
giorno dell'evocazione adorante e grata del primo giorno del
mondo, ed insieme la prefigurazione, nella speranza operosa,
dell'« ultimo giorno », quando Cristo verrà nella gloria (cfr
At 1, 11; 1 Ts 4, 13-17) e saranno fatte «
nuove tutte le cose » (cfr Ap 21, 5).
Alla domenica, pertanto,
ben s'addice l'esclamazione del Salmista: « Questo è il
giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo in
esso » (Sal 118 [117], 24). Questo invito alla gioia,
che la liturgia di Pasqua fa proprio, porta il segno dello
stupore da cui furono investite le donne che avevano assistito
alla crocifissione di Cristo quando, recatesi al sepolcro «
di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato » (Mc
16, 2), lo trovarono vuoto. È invito a rivivere, in qualche
modo, l'esperienza dei due discepoli di Emmaus, che sentirono
« ardere il cuore nel petto » mentre il Risorto si
affiancava a loro lungo il cammino, spiegando le Scritture e
rivelandosi nello « spezzare il pane » (cfr Lc 24,
32.35). È l'eco della gioia, prima esitante e poi
travolgente, che gli Apostoli provarono la sera di quello
stesso giorno, quando furono visitati da Gesù risorto e
ricevettero il dono della sua pace e del suo Spirito (cfr Gv
20, 19-23).
2. La risurrezione di Gesù
è il dato originario su cui poggia la fede cristiana (cfr 1
Cor 15, 14): stupenda realtà, colta pienamente nella luce
della fede, ma storicamente attestata da coloro che ebbero il
privilegio di vedere il Signore risorto; evento mirabile che
non solo si distingue in modo assolutamente singolare nella
storia degli uomini, ma si colloca al centro del mistero
del tempo. A Cristo, infatti, come ricorda, nella
suggestiva liturgia della notte di Pasqua, il rito di
preparazione del cero pasquale, « appartengono il tempo e i
secoli ». Per questo, commemorando non solo una volta
all'anno, ma ogni domenica, il giorno della risurrezione di
Cristo, la Chiesa intende additare ad ogni generazione ciò
che costituisce l'asse portante della storia, al quale si
riconducono il mistero delle origini e quello del destino
finale del mondo.
C'è ragione dunque per
dire, come suggerisce l'omelia di un autore del IV secolo, che
il « giorno del Signore » è il « signore dei giorni ».(2)
Quanti hanno ricevuto la grazia di credere nel Signore risorto
non possono non cogliere il significato di questo giorno
settimanale con l'emozione vibrante che faceva dire a san
Girolamo: « La domenica è il giorno della risurrezione, è
il giorno dei cristiani, è il nostro giorno ».(3) Essa è in
effetti per i cristiani la « festa primordiale »,(4) posta
non solo a scandire il succedersi del tempo, ma a rivelarne il
senso profondo.
3. La sua importanza
fondamentale, sempre riconosciuta in duemila anni di storia,
è stata ribadita con forza dal Concilio Vaticano II: «
Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dal giorno
stesso della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il
mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama
giustamente giorno del Signore o domenica ».(5) Paolo VI ha
sottolineato nuovamente tale importanza nell'approvare il
nuovo Calendario romano generale e le Norme universali che
regolano l'ordinamento dell'Anno liturgico.(6) L'imminenza del
terzo millennio, sollecitando i credenti a riflettere, alla
luce di Cristo, sul cammino della storia, li invita a
riscoprire con nuovo vigore il senso della domenica: il suo «
mistero », il valore della sua celebrazione, il suo
significato per l'esistenza cristiana ed umana.
Prendo atto volentieri dei
molteplici interventi magisteriali e delle iniziative
pastorali che, in questi anni del post-Concilio, voi, venerati
Fratelli nell'episcopato, sia come singoli sia congiuntamente
— ben coadiuvati dal vostro clero —, avete sviluppato su
questo importante tema. Alle soglie del Grande Giubileo
dell'anno 2000, ho voluto offrirvi questa Lettera apostolica
per sostenere il vostro impegno pastorale in un settore tanto
vitale. Ma insieme desidero rivolgermi a voi tutti, carissimi
fedeli, quasi rendendomi presente spiritualmente nelle singole
comunità dove ogni domenica vi raccogliete coi vostri Pastori
per celebrare l'Eucaristia e il « giorno del Signore ».
Molte delle riflessioni e dei sentimenti che animano questa
Lettera apostolica sono maturati durante il mio servizio
episcopale a Cracovia e poi, dopo l'assunzione del ministero
di Vescovo di Roma e Successore di Pietro, nelle visite alle
parrocchie romane, effettuate regolarmente proprio nelle
domeniche dei diversi periodi dell'anno liturgico. In questa
Lettera mi sembra così di continuare il dialogo vivo che amo
intrattenere con i fedeli, riflettendo con voi sul senso della
domenica, e sottolineando le ragioni per viverla come vero «
giorno del Signore » anche nelle nuove circostanze del nostro
tempo.
4. A nessuno sfugge
infatti che, fino ad un passato relativamente recente, la «
santificazione » della domenica era facilitata, nei Paesi di
tradizione cristiana, da una larga partecipazione popolare e
quasi dall'organizzazione stessa della società civile, che
prevedeva il riposo domenicale come punto fermo nella
normativa concernente le varie attività lavorative. Ma oggi,
negli stessi Paesi in cui le leggi sanciscono il carattere
festivo di questo giorno, l'evoluzione delle condizioni
socio-economiche ha finito spesso per modificare profondamente
i comportamenti collettivi e conseguentemente la fisionomia
della domenica. Si è affermata largamente la pratica del «
week-end », inteso come tempo settimanale di sollievo, da
trascorrere magari lontano dalla dimora abituale, e spesso
caratterizzato dalla partecipazione ad attività culturali,
politiche, sportive, il cui svolgimento coincide in genere
proprio coi giorni festivi. Si tratta di un fenomeno sociale e
culturale che non manca certo di elementi positivi nella
misura in cui può contribuire, nel rispetto di valori
autentici, allo sviluppo umano e al progresso della vita
sociale nel suo insieme. Esso risponde non solo alla necessità
del riposo, ma anche all'esigenza di « far festa » che è
insita nell'essere umano. Purtroppo, quando la domenica perde
il significato originario e si riduce a puro « fine settimana
», può capitare che l'uomo rimanga chiuso in un orizzonte
tanto ristretto che non gli consente più di vedere il «
cielo ». Allora, per quanto vestito a festa, diventa
intimamente incapace di « far festa ».(7)
Ai discepoli di Cristo è
comunque chiesto di non confondere la celebrazione della
domenica, che dev'essere una vera santificazione del giorno
del Signore, col « fine settimana », inteso fondamentalmente
come tempo di semplice riposo o di evasione. È urgente a tal
proposito un'autentica maturità spirituale, che aiuti i
cristiani ad « essere se stessi », in piena coerenza con il
dono della fede, sempre pronti a rendere conto della speranza
che è in loro (cfr 1 Pt 3, 15). Ciò non può non
comportare anche una comprensione più profonda della
domenica, per poterla vivere, pure in situazioni difficili,
con piena docilità allo Spirito Santo.
5. La situazione, da
questo punto di vista, si presenta piuttosto variegata. C'è,
da una parte, l'esempio di alcune giovani Chiese, le quali
mostrano con quanto fervore si possa animare la celebrazione
domenicale, sia nelle città che nei villaggi più dispersi.
Al contrario, in altre regioni, a causa delle menzionate
difficoltà sociologiche, e forse della mancanza di forti
motivazioni di fede, si registra una percentuale singolarmente
bassa di partecipanti alla liturgia domenicale. Nella
coscienza di molti fedeli sembra attenuarsi non soltanto il
senso della centralità dell'Eucaristia, ma persino quello del
dovere di rendere grazie al Signore, pregandolo insieme con
gli altri in seno alla comunità ecclesiale.
A tutto ciò si aggiunge
che, non solo nei Paesi di missione, ma anche in quelli di
antica evangelizzazione, per l'insufficienza dei sacerdoti non
si può talvolta assicurare la celebrazione eucaristica
domenicale nelle singole comunità.
6. Di fronte a questo
scenario di nuove situazioni e conseguenti interrogativi,
sembra più che mai necessario ricuperare le motivazioni
dottrinali profonde che stanno alla base del precetto
ecclesiale, perché a tutti i fedeli risulti ben chiaro il
valore irrinunciabile della domenica nella vita cristiana. Così
facendo, ci muoviamo sulle tracce della perenne tradizione
della Chiesa, vigorosamente richiamata dal Concilio Vaticano
II quando ha insegnato che, nel giorno della domenica, « i
fedeli devono riunirsi in assemblea perché, ascoltando la
parola di Dio e partecipando all'Eucaristia, facciano memoria
della passione, della risurrezione e della gloria del Signore
Gesù e rendano grazie a Dio che li ha rigenerati per una
speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai
morti (cfr 1 Pt 1, 3) ».(8)
7. In effetti, il dovere
di santificare la domenica, soprattutto con la partecipazione
all'Eucaristia e con un riposo ricco di gioia cristiana e di
fraternità, ben si comprende se si considerano le molteplici
dimensioni di questa giornata, a cui porteremo attenzione
nella presente Lettera.
Essa è un giorno che sta
nel cuore stesso della vita cristiana. Se, fin dall'inizio del
mio Pontificato, non mi sono stancato di ripetere: « Non
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! »,(9)
in questa stessa linea vorrei oggi invitare tutti con forza a
riscoprire la domenica: Non abbiate paura di dare il vostro
tempo a Cristo! Sì, apriamo a Cristo il nostro tempo,
perché egli lo possa illuminare e indirizzare. Egli è Colui
che conosce il segreto del tempo e il segreto dell'eterno, e
ci consegna il « suo giorno » come un dono sempre nuovo del
suo amore. La riscoperta di questo giorno è grazia da
implorare, non solo per vivere in pienezza le esigenze proprie
della fede, ma anche per dare concreta risposta ad aneliti
intimi e veri che sono in ogni essere umano. Il tempo donato a
Cristo non è mai tempo perduto, ma piuttosto tempo guadagnato
per l'umanizzazione profonda dei nostri rapporti e della
nostra vita.
CAPITOLO
PRIMO
DIES
DOMINI
La
celebrazione
dell'opera del Creatore
« Tutto è stato
fatto per mezzo di lui »
(Gv 1, 3)
8. Nell'esperienza
cristiana, la domenica è prima di tutto una festa pasquale,
totalmente illuminata dalla gloria del Cristo risorto. È la
celebrazione della « nuova creazione ». Ma proprio questo
suo carattere, se compreso in profondità, appare inscindibile
dal messaggio che la Scrittura, fin dalle prime sue pagine, ci
offre sul disegno di Dio nella creazione del mondo. Se è
vero, infatti, che il Verbo si è fatto carne nella «
pienezza del tempo » (Gal 4, 4), non è meno vero che,
in forza del suo stesso mistero di Figlio eterno del Padre,
egli è origine e fine dell'universo. Lo afferma Giovanni, nel
prologo del suo Vangelo: « Tutto è stato fatto per mezzo di
lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste » (1, 3). Lo sottolinea ugualmente Paolo scrivendo ai
Colossesi: « Per mezzo di lui sono state create tutte le
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e
quelle invisibili [...]. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui » (1, 16). Questa presenza
attiva del Figlio nell'opera creatrice di Dio si è rivelata
pienamente nel mistero pasquale, in cui Cristo, risorgendo
come « primizia di coloro che sono morti » (1 Cor 15,
20), ha inaugurato la nuova creazione ed ha avviato il
processo che egli stesso porterà a compimento al momento del
suo ritorno glorioso, « quando consegnerà il regno a Dio
Padre [...], perché Dio sia tutto in tutti » (1 Cor
15, 24.28).
Già nel mattino della
creazione, quindi, il progetto di Dio implicava questo «
compito cosmico » di Cristo. Questa prospettiva
cristocentrica, proiettata su tutto l'arco del tempo, era
presente nello sguardo compiaciuto di Dio quando, cessando da
ogni suo lavoro, « benedisse il settimo giorno e lo santificò
» (Gn 2, 3). Nasceva allora — secondo l'autore
sacerdotale del primo racconto biblico della creazione — il
« sabato », che tanto caratterizza la prima Alleanza, ed in
qualche modo preannuncia il giorno sacro della nuova e
definitiva Alleanza. Lo stesso tema del « riposo di Dio » (cfr
Gn 2, 2) e del riposo da lui offerto al popolo
dell'Esodo con l'ingresso nella terra promessa (cfr Es
33, 14; Dt 3, 20; 12, 9; Gs 21, 44; Sal 95
[94], 11) è riletto nel Nuovo Testamento in una luce nuova,
quella del definitivo « riposo sabbatico » (Eb 4, 9)
in cui Cristo stesso è entrato con la sua risurrezione e in
cui è chiamato ad entrare il popolo di Dio, perseverando
sulle orme della sua obbedienza filiale (cfr Eb 4,
3-16). È necessario pertanto rileggere la grande pagina della
creazione e approfondire la teologia del « sabato », per
introdursi alla piena comprensione della domenica.
« In principio Dio
creò il cielo e la terra »
(Gn 1, 1)
9. Lo stile poetico del
racconto genesiaco della creazione rende bene lo stupore che
l'uomo avverte di fronte all'immensità del creato e il
sentimento di adorazione che ne deriva verso Colui che ha
tratto dal nulla tutte le cose. È una pagina di intenso
significato religioso, un inno al Creatore dell'universo,
additato come l'unico Signore di fronte alle ricorrenti
tentazioni di divinizzare il mondo stesso. È insieme un inno
alla bontà del creato, tutto plasmato dalla mano potente e
misericordiosa di Dio.
« Dio vide che era cosa
buona » (Gn 1, 10.12, ecc.). Questo ritornello che
scandisce il racconto proietta una luce positiva su ogni
elemento dell'universo, lasciando al tempo stesso
intravedere il segreto per la sua appropriata comprensione e
per la sua possibile rigenerazione: il mondo è buono nella
misura in cui rimane ancorato alla sua origine e, dopo che il
peccato lo ha deturpato, ridiventa buono, se torna, con
l'aiuto della grazia, a Colui che lo ha fatto. Questa
dialettica, ovviamente, non riguarda direttamente le cose
inanimate e gli animali, ma gli esseri umani, ai quali è
stato concesso il dono incomparabile, ma anche il rischio,
della libertà. La Bibbia, subito dopo i racconti della
creazione, mette appunto in evidenza il drammatico contrasto
tra la grandezza dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza
di Dio, e la sua caduta, che apre nel mondo l'oscuro scenario
del peccato e della morte (cfr Gn 3).
10. Uscito com'è dalle
mani di Dio, il cosmo porta l'impronta della sua bontà. È un
mondo bello, degno di essere ammirato e goduto, ma destinato
anche ad essere coltivato e sviluppato. Il « completamento »
dell'opera di Dio apre il mondo al lavoro dell'uomo. « Allora
Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva
fatto » (Gn 2, 2). Attraverso questa evocazione
antropomorfica del « lavoro » divino, la Bibbia non soltanto
ci apre uno spiraglio sul misterioso rapporto tra il Creatore
e il mondo creato, ma proietta luce anche sul compito che
l'uomo ha verso il cosmo. Il « lavoro » di Dio è in qualche
modo esemplare per l'uomo. Questi infatti non è solo chiamato
ad abitare, ma anche a « costruire » il mondo, facendosi così
« collaboratore » di Dio. I primi capitoli della Genesi,
come scrivevo nell'Enciclica Laborem exercens,
costituiscono in certo senso il primo « vangelo del lavoro ».(10)
È una verità sottolineata anche dal Concilio Vaticano II: «
L'uomo, creato a immagine di Dio, ha ricevuto il comando di
sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene, e
di governare il mondo nella giustizia e nella santità, e così
pure di riportare a Dio se stesso e l'universo intero,
riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose, in modo che,
nella subordinazione di tutte le realtà all'uomo sia
glorificato il nome di Dio su tutta la terra ».(11)
La vicenda esaltante dello
sviluppo della scienza, della tecnica, della cultura nelle
loro varie espressioni — sviluppo sempre più rapido, ed
oggi addirittura vertiginoso — è il frutto, nella storia
del mondo, della missione con la quale Dio ha affidato
all'uomo e alla donna il compito e la responsabilità di
riempire la terra e di soggiogarla attraverso il lavoro,
nell'osservanza della sua Legge.
Lo « shabbat »: il
gioioso riposo del Creatore
11. Se è esemplare per
l'uomo, nella prima pagina della Genesi, il « lavoro » di
Dio, altrettanto lo è il suo « riposo »: « Cessò nel
settimo giorno da ogni suo lavoro« (Gn 2, 2).
Anche qui siamo di fronte ad un antropomorfismo ricco di un
fecondo messaggio.
Il « riposo » di Dio non
può essere banalmente interpretato come una sorta di «
inattività » di Dio. L'atto creatore che è a fondamento del
mondo è infatti di sua natura permanente e Dio non cessa mai
di operare, come Gesù stesso si preoccupa di ricordare
proprio in riferimento al precetto del sabato: « Il Padre mio
opera sempre e anch'io opero » (Gv 5, 17). Il riposo
divino del settimo giorno non allude a un Dio inoperoso, ma
sottolinea la pienezza della realizzazione compiuta e quasi
esprime la sosta di Dio di fronte all'opera « molto buona »
(Gn 1, 31) uscita dalle sue mani, per volgere ad essa uno
sguardo colmo di gioioso compiacimento: uno sguardo «
contemplativo », che non mira più a nuove realizzazioni, ma
piuttosto a godere la bellezza di quanto è stato compiuto;
uno sguardo portato su tutte le cose, ma in modo particolare
sull'uomo, vertice della creazione. È uno sguardo in cui si
può in qualche modo già intuire la dinamica « sponsale »
del rapporto che Dio vuole stabilire con la creatura fatta a
sua immagine, chiamandola ad impegnarsi in un patto di amore.
È ciò che egli realizzerà progressivamente, nella
prospettiva della salvezza offerta all'intera umanità,
mediante l'alleanza salvifica stabilita con Israele e
culminata poi in Cristo: sarà proprio il Verbo incarnato,
attraverso il dono escatologico dello Spirito Santo e la
costituzione della Chiesa come suo corpo e sua sposa, ad
estendere l'offerta di misericordia e la proposta dell'amore
del Padre all'intera umanità.
12. Nel disegno del
Creatore c'è una distinzione, ma anche un intimo nesso tra
l'ordine della creazione e l'ordine della salvezza. Già
l'Antico Testamento lo sottolinea, quando pone il comandamento
concernente lo « shabbat » in rapporto non soltanto col
misterioso « riposo » di Dio dopo i giorni dell'attività
creatrice (cfr Es 20, 8-11), ma anche con la salvezza
da lui offerta ad Israele nella liberazione dalla schiavitù
dell'Egitto (cfr Dt 5, 12-15). Il Dio che riposa il
settimo giorno rallegrandosi per la sua creazione, è lo
stesso che mostra la sua gloria liberando i suoi figli
dall'oppressione del faraone. Nell'uno e nell'altro caso si
potrebbe dire, secondo un'immagine cara ai profeti, che egli
si manifesta come lo sposo di fronte alla sposa (cfr Os
2, 16-24; Ger 2, 2; Is 54, 4-8).
Per andare infatti al
cuore dello « shabbat », del « riposo » di Dio, come
alcuni elementi della stessa tradizione ebraica
suggeriscono,(12) occorre cogliere l'intensità sponsale che
caratterizza, dall'Antico al Nuovo Testamento, il rapporto di
Dio con il suo popolo. Così la esprime, ad esempio, questa
meravigliosa pagina di Osea: « In quel tempo farò per loro
un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo
e con i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò
dal paese; e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa
per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto,
nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella
fedeltà e tu conoscerai il Signore » (2, 20-22).
« Dio benedisse il
settimo giorno e lo santificò » (Gn 2, 3)
13. Il precetto del
sabato, che nella prima Alleanza prepara la domenica della
nuova ed eterna Alleanza, si radica dunque nella profondità
del disegno di Dio. Proprio per questo esso non è collocato
accanto ad ordinamenti semplicemente cultuali, come è il caso
di tanti altri precetti, ma all'interno del Decalogo, le «
dieci parole » che delineano i pilastri della vita morale,
inscritta universalmente nel cuore dell'uomo. Cogliendo questo
comandamento nell'orizzonte delle strutture fondamentali
dell'etica, Israele e poi la Chiesa mostrano di non
considerarlo una semplice disposizione di disciplina religiosa
comunitaria, ma un'espressione qualificante e
irrinunciabile del rapporto con Dio annunciato e proposto
dalla rivelazione biblica. È in questa prospettiva che tale
precetto va anche oggi riscoperto da parte dei cristiani. Se
esso ha pure una naturale convergenza con il bisogno umano del
riposo, è tuttavia alla fede che bisogna far capo per
coglierne il senso profondo, e non rischiare di banalizzarlo e
tradirlo.
14. Il giorno del riposo
è dunque tale innanzitutto perché è il giorno « benedetto
» da Dio e da lui « santificato », ossia separato dagli
altri giorni per essere, tra tutti, il « giorno del Signore
».
Per comprendere appieno il
senso di questa « santificazione » del sabato nel primo
racconto biblico della creazione, occorre guardare all'insieme
del testo, dal quale emerge con chiarezza come ogni realtà,
senza eccezioni, vada ricondotta a Dio. Il tempo e lo spazio
gli appartengono. Egli non è il Dio di un solo giorno, ma il
Dio di tutti i giorni dell'uomo.
Se dunque egli «
santifica » il settimo giorno con una speciale benedizione e
ne fa il « suo giorno » per eccellenza, ciò va inteso
proprio nella dinamica profonda del dialogo di alleanza, anzi
del dialogo « sponsale ». È un dialogo di amore che non
conosce interruzioni, e che tuttavia non è monocorde: si
svolge infatti adoperando i diversi registri dell'amore, dalle
manifestazioni ordinarie e indirette a quelle più intense che
le parole della Scrittura e poi le testimonianze di tanti
mistici non temono di descrivere con immagini tratte
dall'esperienza dell'amore nuziale.
15. In realtà, tutta la
vita dell'uomo e tutto il tempo dell'uomo, devono essere
vissuti come lode e ringraziamento nei confronti del Creatore.
Ma il rapporto dell'uomo con Dio ha bisogno anche di
momenti di esplicita preghiera, in cui il rapporto si fa
dialogo intenso, coinvolgente ogni dimensione della persona.
Il « giorno del Signore » è, per eccellenza, il giorno di
questo rapporto, in cui l'uomo eleva a Dio il suo canto,
facendosi voce dell'intera creazione.
Proprio per questo è
anche il giorno del riposo: l'interruzione del ritmo
spesso opprimente delle occupazioni esprime, con il linguaggio
plastico della « novità » e del « distacco », il
riconoscimento della dipendenza propria e del cosmo da Dio. Tutto
è di Dio! Il giorno del Signore torna continuamente ad
affermare questo principio. Il « sabato » è stato perciò
suggestivamente interpretato come un elemento qualificante in
quella sorta di « architettura sacra » del tempo che
caratterizza la rivelazione biblica.(13) Esso sta a ricordare
che a Dio appartengono il cosmo e la storia, e l'uomo
non può dedicarsi alla sua opera di collaboratore del
Creatore nel mondo, senza prendere costantemente coscienza di
questa verità.
« Ricordare » per
« santificare »
16. Il comandamento del
Decalogo con cui Dio impone l'osservanza del sabato ha, nel
Libro dell'Esodo, una formulazione caratteristica: «
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo » (20, 8). E
più oltre il testo ispirato ne dà la motivazione richiamando
l'opera di Dio: « perché in sei giorni il Signore ha fatto
il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è
riposato il giorno settimo. Perché il Signore ha benedetto il
giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro » (v. 11). Prima di
imporre qualcosa da fare, il comandamento segnala
qualcosa da ricordare. Invita a risvegliare la memoria
di quella grande e fondamentale opera di Dio che è la
creazione. E memoria che deve animare tutta la vita religiosa
dell'uomo, per confluire poi nel giorno in cui l'uomo è
chiamato a riposare. Il riposo assume così una tipica
valenza sacra: il fedele è invitato a riposare non solo come
Dio ha riposato, ma a riposare nel Signore, riportando
a lui tutta la creazione, nella lode, nel rendimento di
grazie, nell'intimità filiale e nell'amicizia sponsale.
17. Il tema del « ricordo
» delle meraviglie compiute da Dio, in rapporto al riposo
sabbatico, emerge anche nel testo del Deuteronomio (5, 12-15),
dove il fondamento del precetto è colto non tanto nell'opera
della creazione, quanto in quella della liberazione operata da
Dio nell'Esodo: « Ricordati che sei stato schiavo nel paese
d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là
con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti
ordina di osservare il giorno di sabato » (Dt 5, 15).
Questa formulazione appare
complementare alla precedente: considerate insieme, esse
svelano il senso del « giorno del Signore » all'interno di
una prospettiva unitaria di teologia della creazione e della
salvezza. Il contenuto del precetto non è dunque
primariamente una qualunque interruzione del lavoro, ma
la celebrazione delle meraviglie operate da Dio.
Nella misura in cui questo
« ricordo », colmo di gratitudine e di lode verso Dio,
è vivo, il riposo dell'uomo, nel giorno del Signore, assume
il suo pieno significato. Con esso, l'uomo entra nella
dimensione del « riposo » di Dio e ne partecipa
profondamente, diventando così capace di provare un fremito
di quella gioia che il Creatore stesso provò dopo la
creazione, vedendo che tutto quello che aveva fatto « era
cosa molto buona » (Gn 1, 31).
Dal sabato alla
domenica
18. Per questa essenziale
dipendenza del terzo comandamento dalla memoria delle opere
salvifiche di Dio, i cristiani, percependo l'originalità del
tempo nuovo e definitivo inaugurato da Cristo, hanno assunto
come festivo il primo giorno dopo il sabato, perché in esso
è avvenuta la risurrezione del Signore. Il mistero pasquale
di Cristo costituisce, infatti, la rivelazione piena del
mistero delle origini, il vertice della storia della salvezza
e l'anticipazione del compimento escatologico del mondo. Ciò
che Dio ha operato nella creazione e ciò che ha attuato per
il suo popolo nell'Esodo ha trovato nella morte e risurrezione
di Cristo il suo compimento, anche se questo avrà la sua
espressione definitiva solo nella parusia, con la
venuta gloriosa di Cristo. In lui si realizza pienamente il
senso « spirituale » del sabato, come sottolinea san
Gregorio Magno: « Noi consideriamo vero sabato la persona del
nostro Redentore, il Signore nostro Gesù Cristo ».(14) Per
questo la gioia con cui Dio, nel primo sabato dell'umanità,
contempla la creazione tratta dal nulla è ormai espressa da
quella gioia con cui Cristo, nella domenica di Pasqua è
apparso ai suoi, portando il dono della pace e dello Spirito (cfr
Gv 20, 19-23). Nel mistero pasquale, infatti, la
condizione umana, e con essa l'intera creazione, « che geme e
soffre fino ad oggi nelle doglie del parto » (Rm 8,
22), ha conosciuto il suo nuovo « esodo » verso la libertà
dei figli di Dio che possono gridare, con Cristo, « Abbà,
Padre » (Rm 8, 15; Gal 4, 6). Alla luce di
questo mistero, il senso del precetto antico-testamentario sul
giorno del Signore viene ricuperato, integrato e pienamente
svelato nella gloria che rifulge sul volto di Cristo Risorto (cfr
2 Cor 4, 6). Dal « sabato » si passa al « primo
giorno dopo il sabato », dal settimo giorno al primo giorno:
il dies Domini diventa il dies Christi !
CAPITOLO
SECONDO
DIES
CHRISTI
Il
giorno del Signore risorto
e del dono dello Spirito
La Pasqua
settimanale
19. « Noi celebriamo la
domenica a causa della venerabile risurrezione del nostro
Signore Gesù Cristo, non soltanto a Pasqua, ma anche a ogni
ciclo settimanale »: così scriveva, agli inizi del V°
secolo, Papa Innocenzo I,(15) testimoniando una prassi ormai
consolidata, che era andata sviluppandosi a partire già dai
primi anni successivi alla risurrezione del Signore. San
Basilio parla della « santa domenica, onorata dalla
risurrezione del Signore, primizia di tutti gli altri giorni
».(16) Sant'Agostino chiama la domenica « sacramento della
Pasqua ».(17)
Questo intimo legame della
domenica con la risurrezione del Signore è sottolineato
fortemente da tutte le Chiese, in Occidente come in Oriente.
Nella tradizione delle Chiese orientali, in particolare, ogni
domenica è la anastàsimos hemèra, il giorno della
risurrezione,(18) e proprio per questo suo carattere è il
centro di tutto il culto.
Alla luce di questa
ininterrotta ed universale tradizione, si vede chiaramente
che, per quanto il giorno del Signore affondi le radici, come
s'è detto, nell'opera stessa della creazione, e più
direttamente nel mistero del biblico « riposo » di Dio, è
tuttavia alla risurrezione di Cristo che bisogna far specifico
riferimento per coglierne appieno il significato. È quanto
avviene nella domenica cristiana, la quale ripropone ogni
settimana alla considerazione e alla vita dei fedeli l'evento
pasquale, da cui sgorga la salvezza del mondo.
20. Secondo la concorde
testimonianza evangelica, la risurrezione di Gesù Cristo dai
morti avvenne nel « primo giorno dopo il sabato » (Mc
16, 2.9; Lc 24, 1; Gv 20, 1). In quello stesso
giorno, il Risorto si manifestò ai due discepoli di Emmaus (cfr
Lc 24, 13-35) ed apparve agli undici Apostoli riuniti
insieme (cfr Lc 24, 36; Gv 20, 19). Otto giorni
dopo — come testimonia il Vangelo di Giovanni (cfr 20, 26)
— i discepoli si trovavano nuovamente riuniti, quando Gesù
apparve loro e si fece riconoscere da Tommaso, mostrando i
segni della sua passione. Era domenica il giorno della
Pentecoste, primo giorno dell'ottava settimana dopo la pasqua
giudaica (cfr At 2, 1), quando con l'effusione dello
Spirito Santo si realizzò la promessa fatta da Gesù agli
Apostoli dopo la risurrezione (cfr Lc 24, 49; At
1, 4-5). Fu quello il giorno del primo annuncio e dei primi
battesimi: Pietro proclamò alla folla riunita che il Cristo
era risuscitato e « quelli che accolsero la sua parola furono
battezzati » (At 2, 41). Fu l'epifania della Chiesa,
manifestata come popolo nel quale confluiscono in unità, al
di là di tutte le diversità, i figli di Dio dispersi.
Il primo giorno
della settimana
21. È su questa base che,
fin dai tempi apostolici, « il primo giorno dopo il sabato »,
primo della settimana, cominciò a caratterizzare il ritmo
stesso della vita dei discepoli di Cristo (cfr 1 Cor
16, 2). « Primo giorno dopo il sabato » era anche quello in
cui i fedeli di Troade si trovavano riuniti « per la frazione
del pane », quando Paolo rivolse loro il discorso di addio e
compì un miracolo per rianimare il giovane Eutico (cfr At
20, 7-12). Il Libro dell'Apocalisse testimonia l'uso di dare a
questo primo giorno della settimana il nome di « giorno del
Signore » (1, 10). Ormai ciò sarà una delle caratteristiche
che distingueranno i cristiani dal mondo circostante. Lo
notava, fin dall'inizio del secondo secolo, il governatore
della Bitinia, Plinio il Giovane, constatando l'abitudine dei
cristiani « di riunirsi a giorno fisso prima della levata del
sole e di cantare tra di loro un inno a Cristo come a un dio
».(19) E, in effetti, quando i cristiani dicevano « giorno
del Signore », lo facevano dando a questo termine la pienezza
di senso derivante dal messaggio pasquale: « Gesù Cristo è
Signore » (Fil 2, 11; cfr At 2, 36; 1 Cor
12, 3). Si riconosceva con ciò a Cristo lo stesso titolo col
quale i Settanta traducevano, nella rivelazione dell'Antico
Testamento, il nome proprio di Dio, JHWH, che non era lecito
pronunciare.
22. In questi primi tempi
della Chiesa, il ritmo settimanale dei giorni non era
generalmente conosciuto nelle regioni in cui il Vangelo si
diffondeva e i giorni festivi dei calendari greco e romano non
coincidevano con la domenica cristiana. Ciò comportava per i
cristiani una notevole difficoltà a osservare il giorno del
Signore col suo carattere fisso settimanale. Si spiega così
perché i fedeli fossero costretti a riunirsi prima del
sorgere del sole.(20) La fedeltà al ritmo settimanale
tuttavia si imponeva, in quanto fondata sul Nuovo Testamento e
legata alla rivelazione dell'Antico Testamento. Lo
sottolineano volentieri gli Apologisti ed i Padri della Chiesa
nei loro scritti e nella loro predicazione. Il mistero
pasquale veniva illustrato attraverso quei testi della
Scrittura che, secondo la testimonianza di san Luca (cfr 24,
27.44-47), il Cristo risorto stesso doveva aver spiegato ai
discepoli. Alla luce di tali testi, la celebrazione del giorno
della risurrezione acquistava un valore dottrinale e simbolico
capace di esprimere tutta la novità del mistero cristiano.
Progressiva
distinzione dal sabato
23. È proprio su questa
novità che insiste la catechesi dei primi secoli, impegnata a
caratterizzare la domenica rispetto al sabato ebraico. Di
sabato cadeva per gli ebrei il dovere della riunione nella
sinagoga e andava praticato il riposo prescritto dalla Legge.
Gli Apostoli, e in particolare san Paolo, continuarono
dapprima a frequentare la sinagoga per potervi annunciare Gesù
Cristo commentando « le parole dei profeti che si leggono
ogni sabato » (At 13, 27). In alcune comunità si
poteva registrare la coesistenza dell'osservanza del sabato
con la celebrazione domenicale. Ben presto, però, si iniziò
a distinguere i due giorni in modo sempre più netto,
soprattutto per reagire alle insistenze di quei cristiani che,
provenendo dal giudaismo, erano inclini a conservare l'obbligo
dell'antica Legge. Sant'Ignazio di Antiochia scrive: « Se
coloro che vivevano nell'antico ordine di cose sono venuti a
una nuova speranza, non osservando più il sabato ma vivendo
secondo il giorno del Signore, giorno in cui la nostra vita è
sorta attraverso lui e la sua morte [...], mistero dal quale
abbiamo ricevuto la fede e nel quale perseveriamo per essere
trovati discepoli di Cristo, nostro solo Maestro, come
potremmo vivere senza di lui, che anche i profeti attendevano
come maestro, essendo suoi discepoli nello Spirito? ».(21) E
sant'Agostino a sua volta osserva: « Perciò anche il Signore
ha impresso il suo sigillo al suo giorno, che è il terzo dopo
la passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è l'ottavo
dopo il settimo cioè dopo il sabato, e il primo della
settimana ».(22) La distinzione della domenica dal sabato
ebraico si consolida sempre più nella coscienza ecclesiale,
ma in certi periodi della storia, per l'enfasi data
all'obbligo del riposo festivo, si registrerà una certa
tendenza alla « sabbatizzazione » del giorno del Signore.
Non sono mancati inoltre settori della cristianità in cui il
sabato e la domenica sono stati osservati come « due giorni
fratelli ».(23)
Il giorno della
nuova creazione
24. Il confronto della
domenica cristiana con la prospettiva sabbatica, propria
dell'Antico Testamento, suscitò anche approfondimenti
teologici di grande interesse. In particolare, fu posta in
luce la singolare connessione esistente tra la risurrezione e
la creazione. Fu infatti spontaneo per la riflessione
cristiana collegare la risurrezione avvenuta « il primo
giorno della settimana » con il primo giorno di quella
settimana cosmica (cfr Gn 1, 1-2.4) secondo cui il
libro della Genesi scandisce l'evento della creazione: il
giorno della creazione della luce (cfr 1, 3-5). Tale nesso
invitava a comprendere la risurrezione come l'inizio di una
nuova creazione, della quale il Cristo glorioso costituisce la
primizia, essendo egli, « generato prima di ogni creatura »
(Col 1, 15), anche « il primogenito di coloro che
risuscitano dai morti » (Col 1, 18).
25. La domenica è, in
effetti, il giorno in cui, più che in ogni altro, il
cristiano è chiamato a ricordare la salvezza che gli è stata
offerta nel battesimo e che lo ha reso uomo nuovo in Cristo.
« Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo,
in lui siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella
potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti » (Col
2, 12; cfr Rm 6, 4-6). La liturgia sottolinea questa
dimensione battesimale della domenica, sia esortando a
celebrare i battesimi, oltre che nella Veglia pasquale, anche
in questo giorno settimanale « in cui la Chiesa commemora la
risurrezione del Signore »,(24) sia suggerendo, quale
opportuno rito penitenziale all'inizio della Messa,
l'aspersione con l'acqua benedetta, che richiama appunto
l'evento battesimale in cui nasce ogni esistenza
cristiana.(25)
L'ottavo giorno,
figura dell'eternità
26. D'altra parte, il
fatto che il sabato risulti settimo giorno della settimana
fece considerare il giorno del Signore alla luce di un
simbolismo complementare, molto caro ai Padri: la domenica,
oltre che primo giorno, è anche « giorno ottavo », posto
cioè, rispetto alla successione settenaria dei giorni, in una
posizione unica e trascendente, evocatrice non solo
dell'inizio del tempo, ma anche della sua fine nel « secolo
futuro ». San Basilio spiega che la domenica significa il
giorno veramente unico che seguirà il tempo attuale, il
giorno senza termine che non conoscerà né sera né mattino,
il secolo imperituro che non potrà invecchiare; la domnenica
è il preannuncio incessante della vita senza fine, che
rianima la speranza dei cristiani e li incoraggia nel loro
cammino.(26) Nella prospettiva del giorno ultimo, che invera
pienamente il simbolismo anticipatore del sabato, sant'Agostino
conclude le Confessioni parlando dell'eschaton come «
pace del riposo, pace del sabato, pace senza sera ».(27) La
celebrazione della domenica, giorno « primo » e insieme «
ottavo », proietta il cristiano verso il traguardo della vita
eterna.(28)
Il giorno di
Cristo-luce
27. In questa prospettiva
cristocentrica, si comprende un'altra valenza simbolica che la
riflessione credente e la pratica pastorale attribuirono al
giorno del Signore. Un'accorta intuizione pastorale, infatti,
suggerì alla Chiesa di cristianizzare, per la domenica, la
connotazione di « giorno del sole », espressione con cui i
romani denominavano questo giorno e che ancora emerge in
alcune lingue contemporanee,(29) sottraendo i fedeli alle
seduzioni di culti che divinizzavano il sole e indirizzando la
celebrazione di questo giorno a Cristo, vero « sole »
dell'umanità. San Giustino, scrivendo ai pagani, utilizza la
terminologia corrente per annotare che i cristiani facevano la
loro adunanza « nel giorno detto del sole »,(30) ma il
riferimento a questa espressione assume ormai per i credenti
un senso nuovo, perfettamente evangelico.(31) Cristo è
infatti la luce del mondo (cfr Gv 9, 5; cfr anche 1,
4-5.9), e il giorno commemorativo della sua risurrezione è il
riflesso perenne, nella scansione settimanale del tempo, di
questa epifania della sua gloria. Il tema della domenica come
giorno illuminato dal trionfo di Cristo risorto trova spazio
nella Liturgia delle Ore (32) ed ha una particolare enfasi
nella veglia notturna che, nelle liturgie orientali, prepara e
introduce la domenica. Radunandosi in questo giorno, la Chiesa
fa suo, di generazione in generazione, lo stupore di Zaccaria,
quando volge lo sguardo verso Cristo annunciandolo come «
sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte » (Lc 1, 78-79), e vibra in
sintonia con la gioia provata da Simeone nel prendere tra le
braccia il Bimbo divino venuto come « luce per illuminare le
genti » (Lc 2, 32).
Il giorno del dono
dello Spirito
28. Giorno di luce, la
domenica potrebbe dirsi anche, in riferimento allo Spirito
Santo, giorno del « fuoco ». La luce di Cristo, infatti, è
intimamente connessa col « fuoco » dello Spirito, e ambedue
le immagini indicano il senso della domenica cristiana.(33)
Apparendo agli Apostoli la sera di Pasqua, Gesù alitò su di
loro e disse: « Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete
i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi » (Gv 20, 22-23). L'effusione
dello Spirito fu il grande dono del Risorto ai suoi discepoli
la domenica di Pasqua. Era ancora domenica, quando, cinquanta
giorni dopo la risurrezione, lo Spirito scese con potenza,
come « vento gagliardo » e « fuoco » (At 2, 23)
sugli Apostoli riuniti con Maria. La Pentecoste non è solo
evento originario, ma mistero che anima permanentemente la
Chiesa.(34) Se tale evento ha il suo tempo liturgico forte
nella celebrazione annuale con cui si chiude la « grande
domenica »,(35) esso rimane inscritto, proprio per la sua
intima connessione col mistero pasquale, anche nel senso
profondo di ogni domenica. La « Pasqua della settimana » si
fa così, in qualche modo, « Pentecoste della settimana »,
nella quale i cristiani rivivono l'esperienza gioiosa
dell'incontro degli Apostoli col Risorto, lasciandosi
vivificare dal soffio del suo Spirito.
Il giorno della fede
29. Per tutte queste
dimensioni che la contraddistinguono, la domenica appare il
giorno della fede per eccellenza. In esso lo Spirito Santo, «
memoria » viva della Chiesa (cfr Gv 14, 26), fa della
prima manifestazione del Risorto un evento che si rinnova
nell'« oggi » di ciascuno dei discepoli di Cristo. Posti
davanti a lui, nell'assemblea domenicale, i credenti si
sentono interpellati come l'apostolo Tommaso: « Metti qua il
tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e mettila
nel mio costato; e non essere più incredulo, ma credente! »
(Gv 20, 27). Sì, la domenica è il giorno della fede.
Lo sottolinea il fatto che la liturgia eucaristica domenicale,
come peraltro quella delle solennità liturgiche, prevede la
professione di fede. Il « Credo », recitato o cantato,
evidenzia il carattere battesimale e pasquale della domenica,
facendone il giorno in cui, a titolo speciale, il battezzato
rinnova la propria adesione a Cristo ed al suo Vangelo nella
ravvivata consapevolezza delle promesse battesimali.
Accogliendo la Parola e ricevendo il Corpo del Signore, egli
contempla Gesù risorto presente nei « santi segni » e
confessa con l'apostolo Tommaso: « Mio Signore e mio Dio! »
(Gv 20, 28).
Un giorno
irrinunciabile!
30. Si comprende allora
perché, anche nel contesto delle difficoltà del nostro
tempo, l'identità di questo giorno debba essere salvaguardata
e soprattutto profondamente vissuta. Un autore orientale
dell'inizio del III secolo riferisce che in ogni regione i
fedeli già allora santificavano regolarmente la domenica.(36)
La prassi spontanea è divenuta poi norma giuridicamente
sancita: il giorno del Signore ha scandito la storia
bimillenaria della Chiesa. Come potrebbe pensarsi che esso non
continui a segnare il suo futuro? I problemi che, nel nostro
tempo, possono rendere più difficile la pratica del dovere
domenicale non mancano di trovare la Chiesa sensibile e
maternamente attenta alle condizioni dei singoli suoi figli.
In particolare, essa si sente chiamata ad un nuovo impegno
catechetico e pastorale, perché nessuno di essi, nelle
normali condizioni di vita, resti privo dell'abbondante flusso
di grazia che la celebrazione del giorno del Signore porta con
sé. Nello stesso spirito, prendendo posizione su ipotesi di
riforma del calendario ecclesiale in rapporto a variazioni dei
sistemi di calendario civile, il Concilio Ecumenico Vaticano
II ha dichiarato che la Chiesa « non si oppone a quelli
soltanto che conservano e tutelano la settimana di sette
giorni con la domenica ».(37) Alle soglie del terzo
millennio, la celebrazione della domenica cristiana, per i
significati che evoca e le dimensioni che implica, in rapporto
ai fondamenti stessi della fede, rimane un elemento
qualificante dell'identità cristiana.
CAPITOLO
TERZO
DIES
ECCLESIAE
L'assemblea
eucaristica
cuore della domenica
La presenza del
Risorto
31. « Io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 28,
20). Questa promessa di Cristo continua a risuonare nella
Chiesa, che in essa coglie il segreto fecondo della sua vita e
la sorgente della sua speranza. Se la domenica è il giorno
della risurrezione, essa non è solo la memoria di un evento
passato: è celebrazione della viva presenza del Risorto in
mezzo ai suoi.
Perché tale presenza sia
annunciata e vissuta in modo adeguato, non basta che i
discepoli di Cristo preghino individualmente e ricordino
interiormente, nel segreto del cuore, la morte e la
risurrezione di Cristo. Quanti infatti hanno ricevuto la
grazia del battesimo, non sono stati salvati solo a titolo
individuale, ma come membra del Corpo mistico, entrati a far
parte del Popolo di Dio.(38) È importante perciò che si
radunino, per esprimere pienamente l'identità stessa della
Chiesa, la ekklesía, l'assemblea convocata dal Signore
risorto, il quale ha offerto la sua vita « per riunire
insieme i figli di Dio che erano dispersi » (Gv 11,
52). Essi sono diventati « uno » in Cristo (cfr Gal
3, 28), attraverso il dono dello Spirito. Questa unità si
manifesta esteriormente quando i cristiani si riuniscono:
prendono allora viva coscienza e testimoniano al mondo di
essere il popolo dei redenti composto da « uomini di ogni
tribù, lingua, popolo, nazione » (Ap 5, 9).
Nell'assemblea dei discepoli di Cristo si perpetua nel tempo
l'immagine della prima comunità cristiana disegnata con
intento esemplare da Luca negli Atti degli Apostoli, quando
riferisce che i primi battezzati « erano assidui
nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere » (2,
42).
L'assemblea
eucaristica
32. Questa realtà della
vita ecclesiale ha nell'Eucaristia non solo una particolare
intensità espressiva, ma in certo senso il suo luogo «
sorgivo ».(39) L'Eucaristia nutre e plasma la Chiesa: «
Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un
corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane » (1
Cor 10, 17). Per tale suo rapporto vitale con il
sacramento del Corpo e del Sangue del Signore, il mistero
della Chiesa è in modo supremo annunciato, gustato e vissuto
nell'Eucaristia.(40)
L'intrinseca dimensione
ecclesiale dell'Eucaristia si realizza ogni volta che essa
viene celebrata. Ma a maggior ragione si esprime nel giorno in
cui tutta la comunità è convocata per fare memoria della
risurrezione del Signore. Significativamente il Catechismo
della Chiesa Cattolica insegna che « la celebrazione
domenicale del Giorno e dell'Eucaristia del Signore sta al
centro della vita della Chiesa ».(41)
33. È proprio nella Messa
domenicale, infatti, che i cristiani rivivono in modo
particolarmente intenso l'esperienza fatta dagli Apostoli la
sera di Pasqua, quando il Risorto si manifestò ad essi
riuniti insieme (cfr Gv 20, 19). In quel piccolo nucleo
di discepoli, primizia della Chiesa, era in qualche modo
presente il Popolo di Dio di tutti i tempi. Attraverso la loro
testimonianza, rimbalza su ogni generazione di credenti il
saluto di Cristo, ricco del dono messianico della pace,
acquistata col suo sangue e offerta insieme col suo Spirito:
« Pace a voi! ». Nel ritorno di Cristo tra loro « otto
giorni dopo » (Gv 20, 26) può vedersi raffigurato in
radice l'uso della comunità cristiana di riunirsi ogni ottavo
giorno, nel « giorno del Signore » o domenica, a professare
la fede nella sua risurrezione ed a raccogliere i frutti della
beatitudine da lui promessa: « Beati quelli che pur non
avendo visto crederanno! » (Gv 20, 29). Quest'intima
connessione tra la manifestazione del Risorto e l'Eucaristia
è adombrata dal Vangelo di Luca nella narrazione riguardante
i due discepoli di Emmaus, ai quali Cristo stesso si accompagnò,
guidandoli alla comprensione della Parola e sedendosi infine a
mensa con loro. Essi lo riconobbero quando egli « prese il
pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro » (24,
30). I gesti di Gesù in questo racconto sono i medesimi da
lui compiuti nell'Ultima Cena, con la chiara allusione alla «
frazione del pane », come è denominata l'Eucaristia nella
prima generazione cristiana.
L'Eucaristia
domenicale
34. Certo, l'Eucaristia
domenicale non ha, in sé, uno statuto diverso da quella
celebrata in ogni altro giorno, né è separabile dall'intera
vita liturgica e sacramentale. Questa è per sua natura una
epifania della Chiesa,(42) che trova il suo momento più
significativo quando la comunità diocesana si raduna in
preghiera col proprio Pastore: « La principale manifestazione
della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di
tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni
liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla
medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo
circondato dal suo presbiterio e dai ministri ».(43) Il
rapporto col Vescovo e con l'intera comunità ecclesiale è
insito in ogni celebrazione eucaristica, anche non presieduta
dal Vescovo, in qualunque giorno della settimana essa venga
celebrata. Ne è espressione la menzione del Vescovo nella
preghiera eucaristica.
L'Eucaristia domenicale,
tuttavia, con l'obbligo della presenza comunitaria e la
speciale solennità che la contraddistinguono proprio perché
celebrata « nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci
ha resi partecipi della sua vita immortale »,(44) manifesta
con un'ulteriore enfasi la propria dimensione ecclesiale,
ponendosi come paradigmatica rispetto alle altre celebrazioni
eucaristiche. Ogni comunità, radunando tutti i suoi membri
per la « frazione del pane », si sperimenta quale luogo in
cui il mistero della Chiesa concretamente si attua. Nella
stessa celebrazione la comunità si apre alla comunione con la
Chiesa universale,(45) implorando il Padre perché si ricordi
« della Chiesa diffusa su tutta la terra », e la faccia
crescere, nell'unità di tutti i fedeli col Papa e coi Pastori
delle singole Chiese, fino alla perfezione dell'amore.
Il giorno della
Chiesa
35. Il dies Domini si
rivela così anche dies Ecclesiae. Si comprende allora
perché la dimensione comunitaria della celebrazione
domenicale debba essere, sul piano pastorale, particolarmente
sottolineata. Come ho avuto modo, in altra occasione, di
ricordare, tra le numerose attività che una parrocchia
svolge, « nessuna è tanto vitale o formativa della comunità
quanto la celebrazione domenicale del giorno del Signore e
della sua Eucaristia ».(46) In questo senso il Concilio
Vaticano II ha richiamato la necessità di adoperarsi perché
« il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto
nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale ».(47)
Nella stessa linea si pongono i successivi orientamenti
liturgici, chiedendo che, nella domenica e nei giorni festivi,
le celebrazioni eucaristiche fatte normalmente in altre chiese
ed oratori siano coordinate con la celebrazione della chiesa
parrocchiale, e ciò proprio per « fomentare il senso della
comunità ecclesiale, che è alimentato ed espresso in modo
speciale nella celebrazione comunitaria della domenica, sia
intorno al Vescovo, soprattutto nella cattedrale, sia
nell'assemblea parrocchiale, il cui pastore fa le veci del
Vescovo ».(48)
36. L'assemblea domenicale
è luogo privilegiato di unità: vi si celebra infatti il sacramentum
unitatis che caratterizza profondamente la Chiesa, popolo
adunato « dalla » e « nella » unità del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.(49) In essa le famiglie cristiane
vivono una delle espressioni più qualificate della loro
identità e del loro « ministero » di « chiese domestiche
», quando i genitori partecipano con i loro figli all'unica
mensa della Parola e del Pane di vita.(50) Va ricordato a tal
proposito che spetta innanzitutto ai genitori educare i loro
figli alla partecipazione alla Messa domenicale, aiutati in ciò
dai catechisti, che devono preoccuparsi di inserire
l'iniziazione alla Messa nel cammino formativo dei ragazzi
loro affidati, illustrando il motivo profondo
dell'obbligatorietà del precetto. A questo contribuirà
anche, quando le circostanze lo consiglino, la celebrazione di
Messe per fanciulli, secondo le varie modalità previste dalle
norme liturgiche.(51)
Nelle Messe domenicali
della parrocchia, in quanto « comunità eucaristica »,(52)
è normale poi che si ritrovino i vari gruppi, movimenti,
associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa
presenti. Questo consente loro di fare esperienza di ciò che
è ad essi più profondamente comune, al di là delle
specifiche vie spirituali che legittimamente li
caratterizzano, in obbedienza al discernimento dell'autorità
ecclesiale.(53) È per questo che di domenica, giorno
dell'assemblea, le Messe dei piccoli gruppi non sono da
incoraggiare: non si tratta solo di evitare che le assemblee
parrocchiali manchino del necessario ministero dei sacerdoti,
ma anche di fare in modo che la vita e l'unità della comunità
ecclesiale vengano pienamente salvaguardate e promosse.(54)
Spetta all'oculato discernimento dei Pastori delle Chiese
particolari autorizzare eventuali e ben circoscritte deroghe a
questo orientamento, in considerazione di specifiche esigenze
formative e pastorali, tenendo conto del bene di singoli o di
gruppi, e specialmente dei frutti che possono derivarne
all'intera comunità cristiana.
Popolo pellegrinante
37. Nella prospettiva poi
del cammino della Chiesa nel tempo, il riferimento alla
risurrezione di Cristo e la scadenza settimanale di tale
solenne memoria aiutano a ricordare il carattere pellegrinante
e la dimensione escatologica del Popolo di Dio. Di domenica in
domenica, infatti, la Chiesa procede verso l'ultimo « giorno
del Signore », la domenica senza fine. In realtà, l'attesa
della venuta di Cristo è inscritta nel mistero stesso della
Chiesa (55) ed emerge in ogni celebrazione eucaristica. Ma il
giorno del Signore, con la sua specifica memoria della gloria
del Cristo risorto, richiama con maggior intensità anche la
gloria futura del suo « ritorno ». Ciò fa della domenica il
giorno in cui la Chiesa, manifestando più chiaramente il suo
carattere « sponsale », anticipa in qualche modo la realtà
escatologica della Gerusalemme celeste. Raccogliendo i suoi
figli nell'assemblea eucaristica ed educandoli all'attesa
dello « Sposo divino », essa fa come un « esercizio del
desiderio »,(56) in cui pregusta la gioia dei cieli nuovi e
della terra nuova, quando la città santa, la nuova
Gerusalemme, scenderà dal cielo, da Dio, « pronta come una
sposa adorna per il suo sposo » (Ap 21, 2).
Giorno della
speranza
38. Da questo angolo
visuale, se la domenica è il giorno della fede, essa non è
meno il giorno della speranza cristiana. La partecipazione
alla « cena del Signore » è infatti anticipazione del
banchetto escatologico per le « nozze dell'Agnello » (Ap
19, 9). Celebrando il memoriale di Cristo, risorto e asceso al
cielo, la comunità cristiana si pone « nell'attesa che si
compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù
Cristo ».(57) Vissuta e alimentata con questo intenso ritmo
settimanale, la speranza cristiana si fa lievito e luce della
stessa speranza umana. Per questo, nella preghiera «
universale », si raccolgono i bisogni non della sola comunità
cristiana, ma dell'intera umanità; la Chiesa, radunata per la
Celebrazione eucaristica, testimonia in questo modo al mondo
di far sue « le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono ».(58) Coronando poi con l'offerta
eucaristica domenicale la testimonianza che, in tutti i giorni
della settimana, i suoi figli, immersi nel lavoro e nei vari
impegni della vita, si sforzano di offrire con l'annuncio del
Vangelo e la pratica della carità, la Chiesa manifesta in
modo più evidente il suo essere « come sacramento, ossia
segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di
tutto il genere umano ».(59)
La mensa della
Parola
39. Nell'assemblea
domenicale, come del resto in ogni Celebrazione eucaristica,
l'incontro col Risorto avviene mediante la partecipazione alla
duplice mensa della Parola e del Pane di vita. La prima
continua a dare quell'intelligenza della storia della salvezza
e, in particolare, del mistero pasquale che lo stesso Gesù
risorto procurò ai discepoli: è lui che parla, presente com'è
nella sua parola « quando nella Chiesa si legge la Sacra
Scrittura ».(60) Nella seconda si attua la reale, sostanziale
e duratura presenza del Signore risorto attraverso il
memoriale della sua passione e della sua risurrezione, e viene
offerto quel pane di vita che è pegno della gloria futura. Il
Concilio Vaticano II ha ricordato che « la liturgia della
parola e la liturgia eucaristica sono congiunte tra di loro
così strettamente da formare un solo atto di culto ».(61) Lo
stesso Concilio ha anche stabilito che « la mensa della
parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza,
aprendo più largamente i tesori della Bibbia ».(62) Ha poi
ordinato che nelle Messe della domenica, come in quelle delle
feste di precetto, l'omelia non sia omessa se non per grave
causa.(63) Queste felici disposizioni hanno trovato fedele
espressione nella riforma liturgica, a proposito della quale
Paolo VI, commentando la più abbondante offerta di letture
bibliche nelle domeniche e nei giorni festivi, scriveva: «
Tutto ciò è stato ordinato in modo da far aumentare sempre
più nei fedeli "quella fame di ascoltare la parola del
Signore" (Am 8, 11) che, sotto la guida dello
Spirito Santo, spinga il popolo della nuova alleanza alla
perfetta unità della Chiesa ».(64)
40. A distanza di oltre
trent'anni dal Concilio, mentre riflettiamo sull'Eucaristia
domenicale, è necessario verificare come la Parola di Dio
venga proclamata, nonché l'effettiva crescita, nel Popolo di
Dio, della conoscenza e dell'amore della Sacra Scrittura.(65)
L'uno e l'altro aspetto, quello della celebrazione e
quello dell'esperienza vissuta, stanno in intima
relazione. Da una parte, la possibilità offerta dal Concilio
di proclamare la Parola di Dio nella lingua propria della
comunità partecipante deve portarci a sentire una « nuova
responsabilità » verso di essa, facendo risplendere, « fin
dal modo stesso di leggere o di cantare, il carattere
peculiare del testo sacro ».(66) Dall'altra, occorre che
l'ascolto della Parola di Dio proclamata sia ben preparato
nell'animo dei fedeli da una conoscenza appropriata della
Scrittura e, ove pastoralmente possibile, da specifiche
iniziative di approfondimento dei brani biblici, specie di
quelli delle Messe festive. Se infatti la lettura del testo
sacro, compiuta in spirito di preghiera e in docilità
all'interpretazione ecclesiale,(67) non anima abitualmente la
vita dei singoli e delle famiglie cristiane, è difficile che
la sola proclamazione liturgica della Parola di Dio possa
portare i frutti sperati. Sono dunque molto lodevoli quelle
iniziative con cui le comunità parrocchiali, attraverso il
coinvolgimento di quanti partecipano all'Eucaristia —
sacerdote, ministri e fedeli — (68) preparano la liturgia
domenicale già nel corso della settimana, riflettendo in
anticipo sulla Parola di Dio che sarà proclamata. L'obiettivo
a cui tendere è che tutta la celebrazione, in quanto
preghiera, ascolto, canto, e non solo l'omelia, esprima in
qualche modo il messaggio della liturgia domenicale, così che
esso possa incidere più efficacemente su quanti vi prendono
parte. Ovviamente molto è affidato alla responsabilità di
coloro che esercitano il ministero della Parola. Ad essi
incombe il dovere di preparare con particolare cura, nello
studio del testo sacro e nella preghiera, il commento alla
parola del Signore, esprimendone fedelmente i contenuti e
attualizzandoli in rapporto agli interrogativi e alla vita
degli uomini del nostro tempo.
41. Occorre peraltro non
dimenticare che la proclamazione liturgica della Parola di
Dio, soprattutto nel contesto dell'assemblea eucaristica,
non è tanto un momento di meditazione e di catechesi, ma è
il dialogo di Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono
proclamate le meraviglie della salvezza e continuamente
riproposte le esigenze dell'Alleanza. Da parte sua, il Popolo
di Dio si sente chiamato a rispondere a questo dialogo di
amore ringraziando e lodando, ma al tempo stesso verificando
la propria fedeltà nello sforzo di una continua «
conversione ». L'assemblea domenicale si impegna così
all'interiore rinnovamento delle promesse battesimali, che
sono in qualche modo implicite nella recita del Credo, e che
la liturgia espressamente prevede nella celebrazione della
veglia pasquale o quando viene amministrato il battesimo
durante la Messa. In questo quadro, la proclamazione della
Parola nella Celebrazione eucaristica della domenica acquista
il tono solenne che già l'Antico Testamento prevedeva per i
momenti di rinnovamento dell'Alleanza, quando veniva
proclamata la Legge e la comunità di Israele era chiamata,
come il popolo del deserto ai piedi del Sinai (cfr Es
19, 7-8; 24, 3.7), a ribadire il suo « sì », rinnovando la
scelta di fedeltà a Dio e di adesione ai suoi precetti. Dio
infatti, nel comunicare la sua Parola, attende la nostra
risposta: risposta che Cristo ha già dato per noi con il suo
« Amen » (cfr 2 Cor 1, 20-22), e che lo Spirito Santo
fa risuonare in noi in modo che ciò che si è udito coinvolga
profondamente la nostra vita.(69)
La mensa del Corpo
di Cristo
42. La mensa della Parola
sfocia naturalmente nella mensa del Pane eucaristico e prepara
la comunità a viverne le molteplici dimensioni, che assumono
nell'Eucaristia domenicale un carattere particolarmente
solenne. Nel tono festoso del convenire di tutta la comunità
nel « giorno del Signore », l'Eucaristia si propone in modo
più visibile che negli altri giorni come la grande « azione
di grazie », con cui la Chiesa, colma dello Spirito, si
rivolge al Padre, unendosi a Cristo e facendosi voce
dell'intera umanità. La scansione settimanale suggerisce di
raccogliere in grata memoria gli eventi dei giorni appena
trascorsi, per rileggerli alla luce di Dio, e rendergli grazie
per i suoi innumerevoli doni, glorificandolo « per Cristo,
con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo ». La
comunità cristiana prende così rinnovata coscienza del fatto
che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo (cfr Col
1, 16; Gv 1, 3) e in lui, venuto in forma di servo a
condividere e redimere la nostra condizione umana, esse sono
state ricapitolate (cfr Ef 1, 10), per essere offerte a
Dio Padre, dal quale ogni cosa prende origine e vita. Aderendo
infine con il suo « Amen » alla dossologia eucaristica, il
Popolo di Dio si proietta nella fede e nella speranza verso il
traguardo escatologico, quando Cristo « consegnerà il regno
a Dio Padre [...] perché Dio sia tutto in tutti » (1 Cor
15, 24.28).
43. Questo movimento «
ascendente » è insito in ogni celebrazione eucaristica e ne
fa un evento gioioso, intriso di riconoscenza e di speranza,
ma è particolarmente sottolineato, nella Messa domenicale,
dalla sua speciale connessione con la memoria della
risurrezione. D'altra parte, la gioia « eucaristica » che
porta « in alto i nostri cuori » è frutto del « movimento
discendente » che Dio ha operato verso di noi, e che resta
perennemente inscritto nell'essenza sacrificale
dell'Eucaristia, suprema espressione e celebrazione del
mistero della kénosis, ossia dell'abbassamento
mediante il quale Cristo « umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla morte di croce » (Fil
2, 8).
La Messa infatti è viva
ripresentazione del sacrificio della Croce. Sotto le
specie del pane e del vino, su cui è stata invocata
l'effusione dello Spirito, operante con efficacia del tutto
singolare nelle parole della consacrazione, Cristo si offre al
Padre nel medesimo gesto di immolazione con cui si offrì
sulla croce. « In questo divino sacrificio che si compie
nella Messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo
stesso Cristo, che si offrì una sola volta in modo cruento
sull'altare della croce ».(70) Al suo sacrificio Cristo
unisce quello della Chiesa: « Nell'Eucaristia il sacrificio
di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo
corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza,
la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di
Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano
un valore nuovo ».(71) Questa partecipazione dell'intera
comunità assume una particolare evidenza nel convenire
domenicale, che consente di portare all'altare la settimana
trascorsa con l'intero carico umano che l'ha segnata.
Convito pasquale e
incontro fraterno
44. Questa coralità
s'esprime poi specialmente nel carattere di convito pasquale
che è proprio dell'Eucaristia, nella quale Cristo stesso si
fa nutrimento. Infatti « a questo scopo Cristo affidò alla
Chiesa questo sacrificio: perché i fedeli partecipassero ad
esso, sia spiritualmente, con la fede e la carità, sia
sacramentalmente, con il banchetto della santa comunione. La
partecipazione alla cena del Signore è sempre comunione con
il Cristo, che si offre per noi in sacrificio al Padre ».(72)
Per questo la Chiesa raccomanda ai fedeli di fare la comunione
quando partecipano all'Eucaristia, purché siano nelle debite
disposizioni e, se consapevoli di peccati gravi, abbiano
ricevuto il perdono di Dio nel sacramento della
Riconciliazione,(73) nello spirito di quanto san Paolo
ricordava alla comunità di Corinto (cfr 1 Cor 11,
27-32). L'invito alla comunione eucaristica si fa
particolarmente insistente, com'è ovvio, in occasione della
Messa in giorno di domenica e negli altri giorni festivi.
È importante inoltre che
si prenda coscienza viva di quanto la comunione con Cristo sia
profondamente legata alla comunione con i fratelli.
L'assemblea eucaristica domenicale è un evento di
fraternità, che la celebrazione deve mettere bene in
evidenza, pur nel rispetto dello stile proprio dell'azione
liturgica. A ciò contribuiscono il servizio dell'accoglienza
e il tono della preghiera, attenta ai bisogni dell'intera
comunità. Lo scambio del segno della pace, significativamente
posto nel Rito romano prima della comunione eucaristica, è un
gesto particolarmente espressivo, che i fedeli sono invitati a
fare come manifestazione del consenso dato dal popolo di Dio a
tutto ciò che si è compiuto nella celebrazione (74) e
dell'impegno di vicendevole amore che si assume partecipando
all'unico pane, nel ricordo dell'esigente parola di Cristo: «
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il
tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il
tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono » (Mt
5, 23-24).
Dalla Messa alla «
missione »
45. Ricevendo il Pane di
vita, i discepoli di Cristo si dispongono ad affrontare, con
la forza del Risorto e del suo Spirito, i compiti che li
attendono nella loro vita ordinaria. In effetti, per il fedele
che ha compreso il senso di ciò che ha compiuto, la
celebrazione eucaristica non può esaurirsi all'interno del
tempio. Come i primi testimoni della risurrezione, i cristiani
convocati ogni domenica per vivere e confessare la presenza
del Risorto sono chiamati a farsi nella loro vita quotidiana evangelizzatori
e testimoni. L'orazione dopo la comunione e il rito di
conclusione — benedizione e congedo — vanno, sotto questo
profilo, riscoperti e meglio valorizzati, perché quanti hanno
partecipato all'Eucaristia sentano più profondamente la
responsabilità ad essi affidata. Dopo lo scioglimento
dell'assemblea, il discepolo di Cristo torna nel suo ambiente
abituale con l'impegno di fare di tutta la sua vita un dono,
un sacrificio spirituale gradito a Dio (cfr Rm 12, 1).
Egli si sente debitore verso i fratelli di ciò che nella
celebrazione ha ricevuto, non diversamente dai discepoli di
Emmaus i quali, dopo aver riconosciuto « alla frazione del
pane » il Cristo risuscitato (cfr Lc 24, 30-32),
avvertirono l'esigenza di andare subito a condividere con i
loro fratelli la gioia dell'incontro con il Signore (cfr Lc
24, 33-35).
Il precetto
domenicale
46. Essendo l'Eucaristia
il vero cuore della domenica, si comprende perché, fin dai
primi secoli, i Pastori non abbiano cessato di ricordare ai
loro fedeli la necessità di partecipare all'assemblea
liturgica. « Lasciate tutto nel giorno del Signore —
dichiara per esempio il trattato del III° secolo intitolato Didascalia
degli Apostoli — e correte con diligenza alla vostra
assemblea, perché è la vostra lode verso Dio. Altrimenti,
quale scusa avranno presso Dio quelli che non si riuniscono
nel giorno del Signore per ascoltare la parola di vita e
nutrirsi dell'alimento divino che rimane eterno? ».(75)
L'appello dei Pastori ha generalmente incontrato nell'anima
dei fedeli un'adesione convinta e, se non sono mancati tempi e
situazioni in cui è calata la tensione ideale
nell'adempimento di questo dovere, non si può però non
ricordare l'autentico eroismo con cui sacerdoti e fedeli hanno
ottemperato a quest'obbligo in tante situazioni di pericolo e
di restrizione della libertà religiosa, come è possibile
costatare dai primi secoli della Chiesa fino al nostro tempo.
San Giustino, nella sua
prima Apologia indirizzata all'imperatore Antonino e al
Senato, poteva descrivere con fierezza la prassi cristiana
dell'assemblea domenicale, che riuniva insieme nello stesso
luogo i cristiani delle città e quelli delle campagne.(76)
Quando, durante la persecuzione di Diocleziano, le loro
assemblee furono interdette con la più grande severità,
furono molti i coraggiosi che sfidarono l'editto imperiale e
accettarono la morte pur di non mancare alla Eucaristia
domenicale. E il caso di quei martiri di Abitine, in Africa
proconsolare, che risposero ai loro accusatori: « È senza
alcun timore che abbiamo celebrato la cena del Signore, perché
non la si può tralasciare; è la nostra legge »; « Noi non
possiamo stare senza la cena del Signore ». E una delle
martiri confessò: « Sì, sono andata all'assemblea e ho
celebrato la cena del Signore con i miei fratelli, perché
sono cristiana ».(77)
47. Quest'obbligo di
coscienza, fondato in una esigenza interiore che i cristiani
dei primi secoli sentivano con tanta forza, la Chiesa non ha
cessato di affermarlo, anche se dapprima non ha ritenuto
necessario prescriverlo. Solo più tardi, davanti alla
tiepidezza o alla negligenza di alcuni, ha dovuto esplicitare
il dovere di partecipare alla Messa domenicale: il più delle
volte lo ha fatto sotto forma di esortazioni, ma talvolta ha
dovuto ricorrere anche a precise disposizioni canoniche. È
quanto ha fatto in diversi Concili particolari a partire dal
IV secolo (così nel Concilio di Elvira del 300, che non parla
di obbligo ma di conseguenze penali dopo tre assenze) (78) e
soprattutto dal VI secolo in poi (come è avvenuto nel
Concilio di Agde del 506).(79) Questi decreti di Concili
particolari sono sfociati in una consuetudine universale di
carattere obbligante, come cosa del tutto ovvia.(80)
Il Codice di Diritto
Canonico del 1917 per la prima volta raccoglieva la tradizione
in una legge universale.(81) L'attuale Codice la ribadisce,
dicendo che « la domenica e le altre feste di precetto, i
fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa ».(82)
Una tale legge è stata normalmente intesa come implicante un
obbligo grave: è quanto insegna anche il Catechismo della
Chiesa Cattolica,(83) e ben se ne comprende il motivo, se si
considera la rilevanza che la domenica ha per la vita
cristiana.
48. Oggi, come nei tempi
eroici degli inizi, in molte regioni del mondo si ripropongono
situazioni difficili per tanti che intendono vivere con
coerenza la propria fede. L'ambiente è a volte
dichiaratamente ostile, altre volte — e più spesso —
indifferente e refrattario al messaggio evangelico. Il
credente, se non vuole essere sopraffatto, deve poter contare
sul sostegno della comunità cristiana. È perciò necessario
che egli si convinca dell'importanza decisiva che per la sua
vita di fede ha il riunirsi la domenica con gli altri fratelli
per celebrare la Pasqua del Signore nel sacramento della Nuova
Alleanza. Spetta, poi, in modo particolare ai Vescovi di
adoperarsi « per far sì che la domenica venga da tutti i
fedeli riconosciuta, santificata e celebrata come vero
"giorno del Signore", nel quale la Chiesa si raduna
per rinnovare la memoria del suo mistero pasquale con
l'ascolto della parola di Dio, con l'offerta del sacrificio
del Signore, con la santificazione del giorno mediante la
preghiera, le opere di carità e l'astensione dal lavoro ».(84)
49. E dal momento che per
i fedeli partecipare alla Messa è un obbligo, a meno che non
abbiano un impedimento grave, ai Pastori s'impone il
corrispettivo dovere di offrire a tutti l'effettiva possibilità
di soddisfare al precetto. In questa linea si muovono le
disposizioni del diritto ecclesiastico, quali per esempio la
facoltà per il sacerdote, previa autorizzazione del Vescovo
diocesano, di celebrare più di una Messa di domenica e nei
giorni festivi,(85) l'istituzione delle Messe vespertine (86)
ed infine l'indicazione secondo cui il tempo utile per
l'adempimento dell'obbligo comincia già il sabato sera, in
coincidenza con i primi Vespri della domenica.(87) Dal punto
di vista liturgico, infatti, il giorno festivo ha inizio con
tali Vespri.(88) Conseguentemente la liturgia della Messa
detta talvolta « prefestiva », ma che in realtà è a tutti
gli effetti « festiva », è quella della domenica, con
l'impegno per il celebrante di tenere l'omelia e di recitare
con i fedeli la preghiera universale.
I pastori inoltre
ricorderanno ai fedeli che, in caso di assenza dalla loro
residenza abituale in giorno di domenica, essi devono
preoccuparsi di partecipare alla Messa là dove si trovano,
arricchendo così la comunità del luogo con la loro
testimonianza personale. Allo stesso tempo, bisognerà che
queste comunità esprimano un caldo senso di accoglienza per i
fratelli venuti da fuori, particolarmente nei luoghi che
attirano numerosi turisti e pellegrini, per i quali sarà
spesso necessario prevedere iniziative particolari di
assistenza religiosa.(89)
Celebrazione gioiosa
e canora
50. Dato il carattere
proprio della Messa domenicale e l'importanza che essa riveste
per la vita dei fedeli, è necessario prepararla con speciale
cura. Nelle forme suggerite dalla saggezza pastorale e dagli
usi locali in armonia con le norme liturgiche, bisogna
assicurare alla celebrazione quel carattere festoso che
s'addice al giorno commemorativo della Risurrezione del
Signore. A tale scopo è importante dedicare attenzione al
canto dell'assemblea, poiché esso è particolarmente adatto
ad esprimere la gioia del cuore, sottolinea la solennità e
favorisce la condivisione dell'unica fede e del medesimo
amore. Ci si preoccupi pertanto della sua qualità, sia per
quanto riguarda i testi che le melodie, affinché quanto si
propone oggi di nuovo e creativo sia conforme alle
disposizioni liturgiche e degno di quella tradizione
ecclesiale che vanta, in materia di musica sacra, un
patrimonio di inestimabile valore.
Celebrazione
coinvolgente e partecipata
51. È necessario inoltre
fare ogni sforzo perché tutti i presenti — ragazzi e adulti
— si sentano interessati, favorendo il loro coinvolgimento
in quelle espressioni di partecipazione che la liturgia
suggerisce e raccomanda.(90) Certo, spetta soltanto a quelli
che esercitano il sacerdozio ministeriale a servizio dei loro
fratelli di compiere il Sacrificio eucaristico e di offrirlo a
Dio a nome dell'intero popolo.(91) Ha qui il suo fondamento la
distinzione, che è ben più che disciplinare, tra il compito
proprio del celebrante e quello che è attribuito ai diaconi e
ai fedeli non ordinati.(92) I fedeli tuttavia devono essere
consapevoli che, in virtù del sacerdozio comune ricevuto nel
battesimo, « concorrono ad offrire l'Eucaristia ».(93) Pur
nella distinzione dei ruoli, essi « offrono a Dio la vittima
divina e se stessi con essa. Offrendo il sacrificio e
ricevendo la santa comunione, prendono parte attivamente
all'azione liturgica »,(94) attingendovi luce e forza per
vivere il loro sacerdozio battesimale con la testimonianza di
una vita santa.
Altri momenti della
domenica cristiana
52. Se la partecipazione
all'Eucaristia è il cuore della domenica, sarebbe tuttavia
limitativo ridurre solo ad essa il dovere di « santificarla
». Il giorno del Signore è infatti vissuto bene, se è tutto
segnato dalla memoria grata ed operosa dei gesti salvifici di
Dio. Questo impegna ciascuno dei discepoli di Cristo a dare
anche agli altri momenti della giornata, vissuti al di fuori
del contesto liturgico — vita di famiglia, relazioni
sociali, occasioni di svago — uno stile che aiuti a far
emergere la pace e la gioia del Risorto nel tessuto ordinario
della vita. Il più tranquillo ritrovarsi dei genitori e dei
figli può essere, ad esempio, occasione non solo per aprirsi
all'ascolto reciproco, ma anche per vivere insieme qualche
momento formativo e di maggior raccoglimento. E perché poi
non mettere in programma, anche nella vita laicale, quando è
possibile, speciali iniziative di preghiera — quali, in
particolare, la celebrazione solenne dei Vespri —, come pure
eventuali momenti di catechesi, che nella vigilia della
domenica o nel pomeriggio di essa preparino e completino
nell'animo cristiano il dono proprio dell'Eucaristia?
Questa forma abbastanza
tradizionale di « santificazione della domenica » è
diventata forse, in molti ambienti, più difficile; ma la
Chiesa manifesta la sua fede nella forza del Risorto e nella
potenza dello Spirito Santo mostrando, oggi più che mai, di
non accontentarsi di proposte minimali o mediocri sul piano
della fede, e aiutando i cristiani a compiere quanto è più
perfetto e gradito al Signore. Del resto, accanto alle
difficoltà, non mancano segnali positivi ed incoraggianti.
Grazie al dono dello Spirito, in molti ambienti ecclesiali si
avverte una nuova esigenza di preghiera nella molteplicità
delle sue forme. Vengono riscoperte anche espressioni antiche
della religiosità, come il pellegrinaggio, e spesso i fedeli
approfittano del riposo domenicale per recarsi in Santuari
dove vivere, magari con l'intera famiglia, qualche ora di più
intensa esperienza di fede. Sono momenti di grazia che occorre
nutrire con una adeguata evangelizzazione ed orientare con
vera sapienza pastorale.
Assemblee domenicali
in assenza del sacerdote
53. Resta il problema
delle parrocchie per le quali non è possibile godere del
ministero di un sacerdote che celebri l'Eucaristia domenicale.
Ciò avviene spesso nelle giovani Chiese, dove un solo
sacerdote ha la responsabilità pastorale di fedeli dispersi
su un vasto territorio. Situazioni di emergenza possono
verificarsi anche nei Paesi di secolare tradizione cristiana,
quando la rarefazione del clero impedisce di assicurare la
presenza del sacerdote in ogni comunità parrocchiale. La
Chiesa, considerando il caso di impossibilità della
celebrazione eucaristica, raccomanda la convocazione di
assemblee domenicali in assenza del sacerdote,(95) secondo le
indicazioni e le direttive date dalla Santa Sede e affidate,
per la loro applicazione, alle Conferenze Episcopali.(96)
Tuttavia, l'obiettivo deve rimanere la celebrazione del
sacrificio della Messa, sola vera attuazione della Pasqua del
Signore, sola realizzazione completa dell'assemblea
eucaristica che il sacerdote presiede in persona Christi,
spezzando il pane della Parola e quello dell'Eucaristia. Si
prenderanno dunque, a livello pastorale, tutte le misure
necessarie perché i fedeli che ne sono abitualmente privi
possano beneficiarne il più spesso possibile, sia favorendo
la periodica presenza di un sacerdote, sia valorizzando tutte
le opportunità per organizzare il raduno in un luogo
centrale, accessibile a diversi gruppi lontani.
Trasmissioni
radiofoniche e televisive
54. Infine, i fedeli che,
a causa di malattia, infermità o per qualche altra grave
ragione, ne sono impediti, avranno a cuore di unirsi da
lontano nel modo migliore alla celebrazione della Messa
domenicale, preferibilmente con le letture e preghiere
previste dal Messale per quel giorno, come pure attraverso il
desiderio dell'Eucaristia.(97) In molti Paesi, la televisione
e la radio offrono la possibilità di unirsi ad una
Celebrazione eucaristica nel momento in cui essa si svolge in
un luogo sacro.(98) Ovviamente questo genere di trasmissioni
non permette in sé di soddisfare al precetto domenicale, che
esige la partecipazione all'assemblea dei fratelli mediante la
riunione in un medesimo luogo e la conseguente possibilità
della comunione eucaristica. Ma per coloro che sono impediti
dal partecipare all'Eucaristia e sono perciò scusati
dall'adempiere il precetto, la trasmissione televisiva o
radiofonica costituisce un aiuto prezioso, soprattutto se
integrato dal generoso servizio dei ministri straordinari che
portano l'Eucaristia ai malati, recando ad essi il saluto e la
solidarietà dell'intera comunità. In tal modo, anche per
questi cristiani, la Messa domenicale produce abbondanti
frutti ed essi possono vivere la domenica come vero « giorno
del Signore » e « giorno della Chiesa ».
CAPITOLO
QUARTO
DIES
HOMINIS
La
domenica giorno di gioia,
riposo e solidarietà
La « gioia piena »
di Cristo
55. « Sia benedetto Colui
che ha elevato il grande giorno della domenica sopra tutti i
giorni. Il cielo e la terra, gli angeli e gli uomini
s'abbandonano alla gioia ».(99) Questi accenti della liturgia
maronita ben rappresentano le intense acclamazioni di gaudio
che da sempre, nella liturgia occidentale e in quella
orientale, hanno caratterizzato la domenica. Del resto,
storicamente, prima ancora che come giorno di riposo — oltre
tutto allora non previsto dal calendario civile — i
cristiani vissero il giorno settimanale del Signore risorto
soprattutto come giorno di gioia. « Il primo giorno della
settimana, siate tutti lieti » si legge nella Didascalia
degli Apostoli. (100) E questo era ben sottolineato anche
nella prassi liturgica, attraverso la scelta di gesti
appropriati. (101) Sant'Agostino, facendosi interprete della
diffusa coscienza ecclesiale, mette appunto in evidenza tale
carattere della Pasqua settimanale: « Si tralasciano i
digiuni e si prega stando in piedi come segno della
risurrezione; per questo inoltre tutte le domeniche si canta
l'alleluia ». (102)
56. Al di là delle
singole espressioni rituali, che possono variare nel tempo
secondo la disciplina ecclesiale, rimane il dato che la
domenica, eco settimanale della prima esperienza del Risorto,
non può non portare il segno della gioia con cui i discepoli
accolsero il Maestro: « I discepoli gioirono al vedere il
Signore » (Gv 20, 20). Si realizzava per loro, come
poi si attuerà per tutte le generazioni cristiane, la parola
detta da Gesù prima della passione: « Voi sarete afflitti,
ma la vostra afflizione si cambierà in gioia » (Gv
16, 20). Non aveva forse pregato egli stesso perché i
discepoli avessero « la pienezza della sua gioia » (cfr Gv
17, 13)? Il carattere festoso dell'Eucaristia domenicale
esprime la gioia che Cristo trasmette alla sua Chiesa
attraverso il dono dello Spirito. La gioia è appunto uno dei
frutti dello Spirito Santo (cfr Rm 14, 17; Gal
5, 22).
57. Per cogliere dunque in
pienezza il senso della domenica, occorre riscoprire questa
dimensione dell'esistenza credente. Certamente, essa deve
caratterizzare tutta la vita, e non solo un giorno della
settimana. Ma la domenica, in forza del suo significato di giorno
del Signore risorto, nel quale si celebra l'opera divina
della creazione e della « nuova creazione », è giorno di
gioia a titolo speciale, anzi giorno propizio per educarsi
alla gioia, riscoprendone i tratti autentici e le radici
profonde. Essa non va infatti confusa con fatui sentimenti di
appagamento e di piacere, che inebriano la sensibilità e
l'affettività per un momento, lasciando poi il cuore
nell'insoddisfazione e magari nell'amarezza. Cristianamente
intesa, è qualcosa di molto più duraturo e consolante; sa
resistere persino, come attestano i santi, (103) alla notte
oscura del dolore, e, in certo senso, è una « virtù » da
coltivare.
58. Non c'è tuttavia
alcuna opposizione tra la gioia cristiana e le vere gioie
umane. Queste anzi vengono esaltate e trovano il loro
fondamento ultimo proprio nella gioia di Cristo glorificato (cfr
At 2, 24-31), immagine perfetta e rivelazione dell'uomo
secondo il disegno di Dio. Come scrisse nell'Esortazione sulla
gioia cristiana il mio venerato predecessore Paolo VI, « per
essenza, la gioia cristiana è partecipazione alla gioia
insondabile, insieme divina e umana, che è nel cuore di Gesù
Cristo glorificato ». (104) E lo stesso Pontefice concludeva
la sua Esortazione chiedendo che, nel giorno del Signore, la
Chiesa testimoniasse fortemente la gioia provata dagli
Apostoli nel vedere il Signore la sera di Pasqua. Invitava
pertanto i Pastori ad insistere « sulla fedeltà dei
battezzati a celebrare nella gioia l'Eucaristia domenicale.
Come potrebbero essi trascurare questo incontro, questo
banchetto che Cristo ci prepara nel suo amore? Che la
partecipazione ad esso sia insieme degnissima e gioiosa! È il
Cristo, crocifisso e glorificato, che passa in mezzo ai suoi
discepoli, per trascinarli insieme nel rinnovamento della sua
risurrezione. È il culmine, quaggiù, dell'alleanza d'amore
tra Dio e il suo popolo: segno e sorgente di gioia cristiana,
tappa per la festa eterna ». (105) In questa prospettiva di
fede, la domenica cristiana è un autentico « far festa »,
un giorno da Dio donato all'uomo per la sua piena crescita
umana e spirituale.
Il compimento del
sabato
59. Questo aspetto della
domenica cristiana ne evidenzia in modo speciale la dimensione
di compimento del sabato veterotestamentario. Nel giorno del
Signore, che l'Antico Testamento, come s'è detto, lega
all'opera della creazione (cfr Gn 2, 1-3; Es 20,
8-11) e dell'Esodo (cfr Dt 5, 12-15), il cristiano è
chiamato ad annunciare la nuova creazione e la nuova alleanza
compiute nel mistero pasquale di Cristo. La celebrazione della
creazione, lungi dall'essere annullata, è approfondita in
prospettiva cristocentrica, ossia alla luce del disegno divino
« di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo
come quelle della terra » (Ef 1, 10). A sua volta, è
dato senso pieno anche al memoriale della liberazione compiuta
nell'Esodo, che diventa memoriale dell'universale redenzione
compiuta da Cristo morto e risorto. La domenica, pertanto, più
che una « sostituzione » del sabato, è la sua realizzazione
compiuta, e in certo senso la sua espansione e la sua piena
espressione, in ordine al cammino della storia della salvezza,
che ha il suo culmine in Cristo.
60. In quest'ottica la
teologia biblica dello « shabbat », senza recare pregiudizio
al carattere cristiano della domenica, può essere pienamente
recuperata. Essa ci riconduce sempre nuovamente e con stupore
mai attenuato a quel misterioso inizio, in cui l'eterna Parola
di Dio, con libera decisione d'amore, trasse dal nulla il
mondo. Sigillo dell'opera creatrice fu la benedizione e
consacrazione del giorno in cui Dio cessò « da ogni lavoro
che egli creando aveva fatto » (Gn 2, 3). Da questo
giorno del riposo di Dio prende senso il tempo, assumendo,
nella successione delle settimane, non soltanto un ritmo
cronologico, ma, per così dire, un respiro teologico. Il
costante ritorno dello « shabbat » sottrae infatti il tempo
al rischio del ripiegamento su di sé, perché resti aperto
all'orizzonte dell'eterno, attraverso l'accoglienza di Dio e
dei suoi kairoì, ossia dei tempi della sua grazia e
dei suoi interventi di salvezza.
61. Lo « shabbat », il
giorno settimo benedetto e consacrato da Dio, mentre chiude
l'intera opera della creazione, si lega immediatamente
all'opera del sesto giorno, in cui Dio fece l'uomo « a sua
immagine e somiglianza » (cfr Gn 1, 26). Questa
relazione più immediata tra il « giorno di Dio » e il «
giorno dell'uomo » non sfuggì ai Padri nella loro
meditazione sul racconto biblico della creazione. Dice a tal
proposito Ambrogio: « Grazie dunque al Signore Dio nostro che
fece un'opera ove egli potesse trovare riposo. Fece il cielo,
ma non leggo che ivi abbia riposato; fece le stelle, la luna,
il sole, e neppure qui leggo che abbia in essi riposato. Leggo
invece che fece l'uomo e che allora si riposò, avendo in lui
uno al quale poteva perdonare i peccati ». (106) Il « giorno
di Dio » avrà così per sempre un collegamento diretto con
il « giorno dell'uomo ». Quando il comandamento di Dio
recita: « Ricordati del giorno di sabato per santificarlo »
(Es 20, 8), la sosta comandata per onorare il giorno a
lui dedicato non è affatto, per l'uomo, un'imposizione
onerosa, ma piuttosto un aiuto perché egli avverta la sua
vitale e liberante dipendenza dal Creatore, e insieme la
vocazione a collaborare alla sua opera e ad accogliere la sua
grazia. Onorando il « riposo » di Dio, l'uomo ritrova
pienamente se stesso, e così il giorno del Signore si
manifesta profondamente segnato dalla benedizione divina (cfr Gn
2, 3) e si direbbe dotato, in forza di essa, al pari degli
animali e degli uomini (cfr Gn 1, 22.28), di una sorta
di « fecondità ». Essa si esprime soprattutto nel ravvivare
e, in certo senso, « moltiplicare » il tempo stesso,
accrescendo nell'uomo, col ricordo del Dio vivente, la gioia
di vivere e il desiderio di promuovere e donare la vita.
62. Il cristiano dovrà
allora ricordare che, se per lui sono cadute le modalità del
sabato giudaico, superate dal « compimento » domenicale,
restano validi i motivi di fondo che impongono la
santificazione del « giorno del Signore », fissati nella
solennità del Decalogo, ma da rileggere alla luce della
teologia e della spiritualità della domenica: « Osserva il
giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti
ha comandato. Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il
settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non fare
lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il
tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo
asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, che sta
entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si
riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese
d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là
con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti
ordina di osservare il giorno di sabato » (Dt 5,
12-15). L'osservanza del sabato appare qui intimamente legata
all'opera di liberazione compiuta da Dio per il suo popolo.
63. Cristo è venuto a
realizzare un nuovo « esodo », a rendere la libertà agli
oppressi. Egli ha operato molte guarigioni il giorno di sabato
(cfr Mt 12, 9-14 e paralleli), non certo per violare il
giorno del Signore, ma per realizzarne il pieno significato:
« Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il
sabato » (Mc 2, 27). Opponendosi all'interpretazione
troppo legalistica di alcuni suoi contemporanei, e sviluppando
l'autentico senso del sabato biblico, Gesù, « Signore del
sabato » (Mc 2, 28), riconduce l'osservanza di questo
giorno al suo carattere liberante, posto insieme a
salvaguardia dei diritti di Dio e dei diritti dell'uomo. Si
comprende così perché i cristiani, annunciatori della
liberazione compiuta nel sangue di Cristo, si sentissero
autorizzati a trasporre il senso del sabato nel giorno della
risurrezione. La Pasqua di Cristo ha infatti liberato l'uomo
da una schiavitù ben più radicale di quella gravante su un
popolo oppresso: la schiavitù del peccato, che allontana
l'uomo da Dio, lo allontana anche da se stesso e dagli altri,
ponendo nella storia sempre nuovi germi di cattiveria e di
violenza.
Il giorno del riposo
64. Per alcuni secoli i
cristiani vissero la domenica solo come giorno del culto,
senza potervi annettere anche il significato specifico del
riposo sabbatico. Solo nel IV secolo, la legge civile
dell'Impero Romano riconobbe il ritmo settimanale, facendo in
modo che nel « giorno del sole » i giudici, le popolazioni
delle città e le corporazioni dei vari mestieri cessassero di
lavorare. (107) I cristiani si rallegrarono di veder così
tolti gli ostacoli che fino ad allora avevano reso talvolta
eroica l'osservanza del giorno del Signore. Essi potevano
ormai dedicarsi alla preghiera comune senza impedimenti. (108)
Sarebbe quindi un errore
vedere nella legislazione rispettosa del ritmo settimanale una
semplice circostanza storica senza valore per la Chiesa e che
essa potrebbe abbandonare. I Concili non hanno cessato di
conservare, anche dopo la fine dell'Impero, le disposizioni
relative al riposo festivo. Nei Paesi poi dove i cristiani
sono in piccolo numero e dove i giorni festivi del calendario
non corrispondono alla domenica, quest'ultima rimane pur
sempre il giorno del Signore, il giorno in cui i fedeli si
riuniscono per l'assemblea eucaristica. Ciò però avviene a
prezzo di non piccoli sacrifici. Per i cristiani non è
normale che la domenica, giorno di festa e di gioia, non sia
anche giorno di riposo e resta comunque per essi difficile «
santificare » la domenica, non disponendo di un tempo libero
sufficiente.
65. D'altra parte, il
legame tra il giorno del Signore e il giorno del riposo nella
società civile ha una importanza e un significato che vanno
al di là della prospettiva propriamente cristiana.
L'alternanza infatti tra lavoro e riposo, inscritta nella
natura umana, è voluta da Dio stesso, come si rileva dal
brano della creazione nel Libro della Genesi (cfr 2, 2-3; Es
20, 8-11): il riposo è cosa « sacra », essendo per l'uomo
la condizione per sottrarsi al ciclo, talvolta eccessivamente
assorbente, degli impegni terreni e riprendere coscienza che
tutto è opera di Dio. Il potere prodigioso che Dio dà
all'uomo sulla creazione rischierebbe di fargli dimenticare
che Dio è il Creatore, dal quale tutto dipende. Tanto più
urgente è questo riconoscimento nella nostra epoca, nella
quale la scienza e la tecnica hanno incredibilmente esteso il
potere che l'uomo esercita attraverso il suo lavoro.
66. Infine, non bisogna
perdere di vista che, anche nel nostro tempo, per molti il
lavoro è una dura servitù, sia in ragione delle miserevoli
condizioni in cui si svolge e degli orari che impone, specie
nelle regioni più povere del mondo, sia perché sussistono,
nelle stesse società economicamente più evolute, troppi casi
di ingiustizia e di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.
Quando la Chiesa nel corso dei secoli ha legiferato sul riposo
domenicale, (109) ha considerato soprattutto il lavoro dei
servi e degli operai, non certo perché esso fosse un lavoro
meno dignitoso rispetto alle esigenze spirituali della pratica
domenicale, ma piuttosto perché più bisognoso di una
regolamentazione che ne alleggerisse il peso, e consentisse a
tutti di santificare il giorno del Signore. In questa chiave
il mio predecessore Leone XIII nell'Enciclica Rerum novarum
additava il riposo festivo come un diritto del lavoratore che
lo Stato deve garantire. (110)
Resta anche nel nostro
contesto storico l'obbligo di adoperarsi perché tutti possano
conoscere la libertà, il riposo e la distensione che sono
necessari alla loro dignità di uomini, con le connesse
esigenze religiose, familiari, culturali, interpersonali, che
difficilmente possono essere soddisfatte, se non viene
salvaguardato almeno un giorno settimanale in cui godere insieme
della possibilità di riposare e di far festa. Ovviamente,
questo diritto del lavoratore al riposo presuppone il suo
diritto al lavoro e, mentre riflettiamo su questa problematica
connessa con la concezione cristiana della domenica, non
possiamo non ricordare con intima partecipazione il disagio di
tanti uomini e donne che, per la mancanza di posti di lavoro,
sono costretti anche nei giorni lavorativi all'inattività.
67. Attraverso il riposo
domenicale, le preoccupazioni e i compiti quotidiani possono
ritrovare la loro giusta dimensione: le cose materiali per le
quali ci agitiamo lasciano posto ai valori dello spirito; le
persone con le quali viviamo riprendono, nell'incontro e nel
dialogo più pacato, il loro vero volto. Le stesse bellezze
della natura — troppe volte sciupate da una logica di
dominio che si ritorce contro l'uomo — possono essere
riscoperte e profondamente gustate. Giorno di pace dell'uomo
con Dio, con se stesso e con i propri simili, la domenica
diviene così anche momento in cui l'uomo è invitato a
gettare uno sguardo rigenerato sulle meraviglie della natura,
lasciandosi coinvolgere in quella stupenda e misteriosa
armonia che, al dire di sant'Ambrogio, per una « legge
inviolabile di concordia e di amore », unisce i diversi
elementi del cosmo in un « vincolo di unione e di pace ».
(111) L'uomo si fa allora più consapevole, secondo le parole
dell'Apostolo, che « tutto ciò che è stato creato da Dio è
buono e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con
rendimento di grazie, perché esso viene santificato dalla
parola di Dio e dalla preghiera » (1 Tm 4, 4-5). Se
dunque, dopo sei giorni di lavoro — ridotti in verità già
per molti a cinque — l'uomo cerca un tempo di distensione e
di migliore cura di altri aspetti della propria vita, ciò
risponde ad un bisogno autentico, in piena armonia con la
prospettiva del messaggio evangelico. Il credente è chiamato
perciò a soddisfare questa esigenza, armonizzandola con le
espressioni della sua fede personale e comunitaria,
manifestata nella celebrazione e santificazione del giorno del
Signore.
Per questo è naturale che
i cristiani si adoperino perché, anche nelle circostanze
speciali del nostro tempo, la legislazione civile tenga conto
del loro dovere di santificare la domenica. È comunque un
loro obbligo di coscienza quello di organizzare il riposo
domenicale in modo che sia loro possibile partecipare
all'Eucaristia, astenendosi dai lavori ed affari incompatibili
con la santificazione del giorno del Signore, con la sua
tipica gioia e con il necessario riposo dello spirito e del
corpo. (112)
68. Dato poi che il riposo
stesso, per non risolversi in vacuità o divenire fonte di
noia, deve portare arricchimento spirituale, più grande
libertà, possibilità di contemplazione e di comunione
fraterna, i fedeli sceglieranno, tra i mezzi della cultura e i
divertimenti che la società offre, quelli che si accordano
meglio con una vita conforme ai precetti del Vangelo. In
questa prospettiva, il riposo domenicale e festivo acquista
una dimensione « profetica », affermando non solo il primato
assoluto di Dio, ma anche il primato e la dignità della
persona rispetto alle esigenze della vita sociale ed
economica, e anticipando in certo modo i « cieli nuovi » e
la « terra nuova », dove la liberazione dalla schiavitù dei
bisogni sarà definitiva e totale. In breve, il giorno del
Signore diventa così, nel modo più autentico, anche il giorno
dell'uomo.
Giorno di solidarietà
69. La domenica deve anche
dare ai fedeli l'occasione di dedicarsi alle attività di
misericordia, di carità e di apostolato. La partecipazione
interiore alla gioia di Cristo risorto implica la condivisione
piena dell'amore che pulsa nel suo cuore: non c'è gioia senza
amore! Gesù stesso lo spiega, ponendo in rapporto il «
comandamento nuovo » con il dono della gioia: « Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia con voi e
la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che
vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati » (Gv
15, 10-12).
L'Eucaristia domenicale,
dunque, non solo non distoglie dai doveri di carità, ma al
contrario impegna maggiormente i fedeli « a tutte le opere di
carità, di pietà, di apostolato, attraverso le quali divenga
manifesto che i fedeli di Cristo non sono di questo mondo e
tuttavia sono luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi
agli uomini ». (113)
70. Di fatto, fin dai
tempi apostolici, la riunione domenicale è stata per i
cristiani un momento di condivisione fraterna nei confronti
dei più poveri. « Ogni primo giorno della settimana ciascuno
metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare » (1
Cor 16, 2). Qui si tratta della colletta organizzata da
Paolo per le Chiese povere della Giudea: nell'Eucaristia
domenicale il cuore credente si allarga alle dimensioni della
Chiesa. Ma occorre cogliere in profondità l'invito
dell'Apostolo, che lungi dal promuovere un'angusta mentalità
dell'« obolo », fa piuttosto appello a una esigente cultura
della condivisione, attuata sia tra i membri stessi della
comunità che in rapporto all'intera società. (114) Sono più
che mai da riascoltare i severi moniti che egli rivolge alla
comunità di Corinto, colpevole di aver umiliato i poveri
nell'agape fraterna che accompagnava la « cena del Signore »:
« Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un
mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando
partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno
ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case
per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla
Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? » (1 Cor
11, 20-22). Altrettanto vigorosa è la parola di Giacomo: «
Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un
anello d'oro al dito, vestito splendidamente, e entri anche un
povero con un vestito logoro. Se voi guardate a colui che è
vestito splendidamente e gli dite: "Tu siediti qui
comodamente" e al povero dite: "Tu mettiti in piedi
lì", oppure "Siediti qui ai piedi del mio
sgabello", non fate in voi stessi preferenze e non siete
giudici dai giudizi perversi? » (2, 2-4).
71. Le indicazioni degli
Apostoli trovarono pronta eco fin dai primi secoli e
suscitarono vibrati accenti nella predicazione dei Padri della
Chiesa. Parole di fuoco rivolgeva sant'Ambrogio ai ricchi che
presumevano di assolvere ai loro obblighi religiosi
frequentando la chiesa senza condividere i loro beni con i
poveri e magari opprimendoli: « Ascolti, o ricco, cosa dice
il Signore? E tu vieni in chiesa non per dare qualcosa a chi
è povero ma per prendere ». (115) Non meno esigente san
Giovanni Crisostomo: « Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non
trascurarlo quando si trova nudo. Non rendergli onore qui nel
tempio con stoffe di seta, per poi trascurarlo fuori, dove
patisce freddo e nudità. Colui che ha detto: "Questo è
il mio corpo", è il medesimo che ha detto: "Voi mi
avete visto affamato e non mi avete nutrito", e
"Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli
l'avete fatto a me" [...]. A che serve che la tavola
eucaristica sia sovraccarica di calici d'oro, quando lui muore
di fame? Comincia a saziare lui affamato, poi con quello che
resterà potrai ornare anche l'altare ». (116)
Sono parole che ricordano
efficacemente alla comunità cristiana il dovere di fare
dell'Eucaristia il luogo dove la fraternità diventi concreta
solidarietà, dove gli ultimi siano i primi nella
considerazione e nell'affetto dei fratelli, dove Cristo
stesso, attraverso il dono generoso fatto dai ricchi ai più
poveri, possa in qualche modo continuare nel tempo il miracolo
della moltiplicazione dei pani. (117)
72. L'Eucaristia è evento
e progetto di fraternità. Dalla Messa domenicale parte
un'onda di carità, destinata ad espandersi in tutta la vita
dei fedeli, iniziando ad animare il modo stesso di vivere il
resto della domenica. Se essa è giorno di gioia, occorre che
il cristiano dica con i suoi concreti atteggiamenti che non si
può essere felici « da soli ». Egli si guarda attorno, per
individuare le persone che possono aver bisogno della sua
solidarietà. Può accadere che nel suo vicinato o nel suo
raggio di conoscenze vi siano ammalati, anziani, bambini,
immigrati che proprio di domenica avvertono in modo ancora più
cocente la loro solitudine, le loro necessità, la loro
condizione di sofferenza. Certamente l'impegno per loro non può
limitarsi ad una sporadica iniziativa domenicale. Ma posto un
atteggiamento di impegno più globale, perché non dare al
giorno del Signore un maggior tono di condivisione, attivando
tutta l'inventiva di cui è capace la carità cristiana?
Invitare a tavola con sé qualche persona sola, fare visita a
degli ammalati, procurare da mangiare a qualche famiglia
bisognosa, dedicare qualche ora a specifiche iniziative di
volontariato e di solidarietà, sarebbe certamente un modo per
portare nella vita la carità di Cristo attinta alla Mensa
eucaristica.
73. Vissuta così, non
solo l'Eucaristia domenicale, ma l'intera domenica diventa una
grande scuola di carità, di giustizia e di pace. La presenza
del Risorto in mezzo ai suoi si fa progetto di solidarietà,
urgenza di rinnovamento interiore, spinta a cambiare le
strutture di peccato in cui i singoli, le comunità, talvolta
i popoli interi sono irretiti. Lungi dall'essere evasione, la
domenica cristiana è piuttosto « profezia » inscritta nel
tempo, profezia che obbliga i credenti a seguire le orme di
Colui che è venuto « per annunciare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e
predicare un anno di grazia del Signore » (Lc 4,
18-19). Mettendosi alla sua scuola, nella memoria domenicale
della Pasqua, e ricordando la sua promessa: « Vi lascio la
pace, vi dò la mia pace » (Gv 14, 27), il credente
diventa a sua volta operatore di pace.
CAPITOLO
QUINTO
DIES
DIERUM
La
domenica festa primordiale,
rivelatrice del senso del tempo
Cristo Alfa e Omega
del tempo
74. « Nel cristianesimo
il tempo ha un'importanza fondamentale. Dentro la sua
dimensione viene creato il mondo, al suo interno si svolge la
storia della salvezza, che ha il suo culmine nella
"pienezza del tempo" dell'Incarnazione e il suo
traguardo nel ritorno glorioso del Figlio di Dio alla fine dei
tempi. In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una
dimensione di Dio, che in se stesso è eterno ». (118)
Gli anni dell'esistenza
terrena di Cristo, alla luce del Nuovo Testamento,
costituiscono realmente il centro del tempo. Questo
centro ha il suo culmine nella risurrezione. Se è vero,
infatti, che egli è Dio fatto uomo fin dal primo istante del
concepimento nel grembo della Vergine Santa, è anche vero che
solo con la risurrezione la sua umanità è totalmente
trasfigurata e glorificata, rivelando così pienamente la sua
identità e gloria divina. Nel discorso tenuto nella sinagoga
di Antiochia di Pisidia (cfr At 13, 33), Paolo applica
appunto alla risurrezione di Cristo l'affermazione del Salmo
2: « Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato » (v. 7).
Proprio per questo, nella celebrazione della Veglia pasquale,
la Chiesa presenta il Cristo risorto come « Principio e Fine,
Alfa e Omega ». Queste parole, pronunciate dal celebrante
nella preparazione del cero pasquale, sul quale è incisa la
cifra dell'anno in corso, mettono in evidenza il fatto che «
Cristo è il Signore del tempo; è il suo principio e il suo
compimento; ogni anno, ogni giorno ed ogni momento vengono
abbracciati nella sua incarnazione e risurrezione, per
ritrovarsi in questo modo nella "pienezza del tempo"
». (119)
75. Essendo la domenica la
Pasqua settimanale, in cui è rievocato e reso presente il
giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti, essa è anche il
giorno che rivela il senso del tempo. Non c'è parentela con i
cicli cosmici, secondo cui la religione naturale e la cultura
umana tendono a ritmare il tempo, indulgendo magari al mito
dell'eterno ritorno. La domenica cristiana è altra cosa!
Sgorgando dalla Risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i
mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li
attraversa orientandoli al traguardo della seconda venuta di
Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della Parusía,
già in qualche modo anticipata dalla gloria di Cristo
nell'evento della Risurrezione.
In effetti, tutto quanto
avverrà, fino alla fine del mondo, non sarà che una
espansione e una esplicitazione di ciò che è avvenuto nel
giorno in cui il corpo martoriato del Crocifisso è
risuscitato per la potenza dello Spirito ed è diventato a sua
volta la sorgente dello Spirito per l'umanità. Il cristiano
sa, perciò, di non dover attendere un altro tempo di
salvezza, giacché il mondo, quale che sia la sua durata
cronologica, vive già nell'ultimo tempo. Dal Cristo
glorificato non solo la Chiesa, ma il cosmo stesso e la storia
sono continuamente retti e guidati. E questa energia di vita a
spingere la creazione, che « geme e soffre fino ad oggi nelle
doglie del parto » (Rm 8, 22), verso la meta del suo
pieno riscatto. Di questo cammino l'uomo non può avere che un
oscuro intuito; i cristiani ne hanno la cifra e la certezza, e
la santificazione della domenica è una testimonianza
significativa che essi sono chiamati a dare, perché i tempi
dell'uomo siano sempre sorretti dalla speranza.
La domenica
nell'anno liturgico
76. Se il giorno del
Signore, con la sua cadenza settimanale, è radicato nella
tradizione più antica della Chiesa ed è di vitale importanza
per il cristiano, un altro ritmo non ha tardato ad affermarsi:
il ciclo annuale. Corrisponde in effetti alla psicologia umana
celebrare gli anniversari, associando al ritorno delle date e
delle stagioni il ricordo di avvenimenti passati. Quando poi
si tratta di avvenimenti decisivi per la vita di un popolo, è
normale che la loro ricorrenza susciti un clima di festa che
viene a rompere la monotonia dei giorni.
Ora i principali eventi di
salvezza su cui poggia la vita della Chiesa furono, per
disegno di Dio, strettamente legati alla Pasqua e alla
Pentecoste, feste annuali dei giudei, e in esse profeticamente
prefigurati. Dal secondo secolo, la celebrazione da parte dei
cristiani della Pasqua annuale, aggiungendosi a quella della
Pasqua settimanale, ha permesso di dare più ampiezza alla
meditazione del mistero di Cristo morto e risorto. Preceduta
da un digiuno che la prepara, celebrata nel corso di una lunga
veglia, prolungata con i cinquanta giorni che portano alla
Pentecoste, la festa di Pasqua, « solennità delle solennità
», è divenuta il giorno per eccellenza dell'iniziazione dei
catecumeni. In effetti, se attraverso il battesimo essi
muoiono al peccato e risuscitano a una vita nuova, è perché
Gesù « è stato messo a morte per i nostri peccati ed è
stato risuscitato per la nostra giustificazione » (Rm
4, 25; cfr 6, 3-11). Intimamente connessa col mistero
pasquale, acquista rilievo speciale la solennità di
Pentecoste, in cui si celebrano la venuta dello Spirito Santo
sugli Apostoli, riuniti con Maria, e l'inizio della missione
verso tutti i popoli. (120)
77. Una simile logica
commemorativa ha presieduto alla strutturazione di tutto
l'anno liturgico. Come ricorda il Concilio Vaticano II, la
Chiesa ha voluto distribuire nel corso dell'anno « tutto il
mistero di Cristo, dall'Incarnazione e Natività fino
all'Ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della
beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in questo
modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli i tesori
di potenza e di meriti del suo Signore, così che siano resi
in qualche modo presenti in ogni tempo, perché i fedeli
possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia di
salvezza ». (121)
Celebrazione solennissima,
dopo la Pasqua e la Pentecoste, è indubbiamente la Natività
del Signore, nella quale i cristiani meditano il mistero
dell'Incarnazione e contemplano il Verbo di Dio che si degna
di assumere la nostra umanità per renderci partecipi della
sua divinità.
78. Ugualmente, « nella
celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la
santa Chiesa venera con speciale amore la beata Maria Madre di
Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del
Figlio suo ». (122) Allo stesso modo, introducendo nel ciclo
annuale, in occasione dei loro anniversari, le memorie dei
Martiri e di altri Santi, « la Chiesa predica il mistero
pasquale nei Santi che hanno sofferto con Cristo e con lui
sono glorificati ». (123) Il ricordo dei Santi, celebrato
nell'autentico spirito della liturgia, non oscura la centralità
di Cristo, ma al contrario la esalta, mostrando la potenza
della sua redenzione. Come canta san Paolino di Nola, « tutto
passa, la gloria dei Santi dura in Cristo, che tutto rinnova,
mentre egli rimane lo stesso ». (124) Questo intrinseco
rapporto della gloria dei Santi a quella di Cristo è
inscritto nello statuto stesso dell'anno liturgico, e trova
proprio nel carattere fondamentale e dominante della domenica,
quale giorno del Signore, la sua espressione più eloquente.
Seguendo i tempi dell'anno liturgico, nell'osservanza della
domenica che interamente lo scandisce, l'impegno ecclesiale e
spirituale del cristiano viene profondamente incardinato in
Cristo, nel quale trova la sua ragion d'essere e dal quale
trae alimento e stimolo.
79. La domenica appare così
il naturale modello per comprendere e celebrare quelle
solennità dell'anno liturgico, il cui valore per l'esistenza
cristiana è così grande che la Chiesa ha stabilito di
sottolinearne l'importanza facendo obbligo ai fedeli di
partecipare alla Messa e di osservare il riposo, benché
cadano in giorni variabili della settimana. (125) Il numero di
queste feste è cambiato nelle diverse epoche, tenuto conto
delle condizioni sociali ed economiche, come del loro
radicamento nella tradizione, oltre che dell'appoggio della
legislazione civile. (126)
L'attuale ordinamento
canonico-liturgico prevede la possibilità che ogni Conferenza
Episcopale, in ragione di circostanze proprie di questo o
quell'altro Paese, riduca la lista dei giorni di precetto.
L'eventuale decisione in tal senso ha bisogno di essere
confermata da una speciale approvazione della Sede Apostolica,
(127) ed in questo caso, la celebrazione di un mistero del
Signore, come l'Epifania, l'Ascensione o la solennità del
Corpo e del Sangue di Cristo, dev'essere rinviata alla
domenica, secondo le norme liturgiche, perché i fedeli non
siano privati della meditazione del mistero. (128) I Pastori
avranno altresì a cuore di incoraggiare i fedeli a
partecipare alla Messa anche in occasione delle feste di una
certa importanza che cadono nel corso della settimana. (129)
80. Uno specifico discorso
pastorale va affrontato in rapporto alle frequenti situazioni
in cui tradizioni popolari e culturali tipiche di un ambiente
rischiano di invadere la celebrazione delle domeniche e delle
altre feste liturgiche, mescolando allo spirito dell'autentica
fede cristiana elementi che le sono estranei e potrebbero
sfigurarla. Occorre in questi casi far chiarezza, con la
catechesi e opportuni interventi pastorali, respingendo quanto
è inconciliabile col Vangelo di Cristo. Non bisogna tuttavia
dimenticare che spesso tali tradizioni — ciò vale
analogamente per nuove proposte culturali della società
civile — non mancano di valori che si coniugano senza
difficoltà con le esigenze della fede. Spetta ai Pastori
operare un discernimento che salvi i valori presenti nella
cultura di un determinato contesto sociale e soprattutto nella
religiosità popolare, facendo in modo che la celebrazione
liturgica, specie quella delle domeniche e delle feste, non ne
soffra, ma piuttosto ne sia avvantaggiata. (130)
CONCLUSIONE
81. Veramente grande è la
ricchezza spirituale e pastorale della domenica, quale la
tradizione ce l'ha consegnata. Colta nella totalità dei suoi
significati e delle sue implicazioni, essa è, in qualche
modo, sintesi della vita cristiana e condizione per viverla
bene. Si comprende dunque perché l'osservanza del giorno del
Signore stia particolarmente a cuore alla Chiesa e resti un
vero e proprio obbligo all'interno della disciplina
ecclesiale. Tale osservanza, tuttavia, prima ancora che come
precetto, deve essere sentita come un'esigenza inscritta nella
profondità dell'esistenza cristiana. È davvero di capitale
importanza che ciascun fedele si convinca di non poter vivere
la sua fede, nella piena partecipazione alla vita della
comunità cristiana, senza prendere regolarmente parte
all'assemblea eucaristica domenicale. Se nell'Eucaristia si
realizza quella pienezza del culto che gli uomini devono a
Dio, e che non ha paragone con nessun'altra esperienza
religiosa, ciò si esprime con particolare efficacia proprio
nel convenire domenicale di tutta la comunità, obbediente
alla voce del Risorto che la convoca, per donarle la luce
della sua Parola e il nutrimento del suo Corpo come perenne
sorgente sacramentale di redenzione. La grazia che sgorga da
questa sorgente rinnova gli uomini, la vita, la storia.
82. È con questa forte
convinzione di fede, accompagnata dalla consapevolezza del
patrimonio di valori anche umani insiti nella pratica
domenicale, che i cristiani di oggi devono porsi di fronte
alle sollecitazioni di una cultura che ha beneficamente
acquisito le esigenze di riposo e di tempo libero, ma le vive
spesso in modo superficiale, e talvolta è sedotta da forme di
divertimento che sono moralmente discutibili. Il cristiano si
sente certo solidale con gli altri uomini nel godere il giorno
di riposo settimanale; al tempo stesso, però, egli ha viva
coscienza della novità e originalità della domenica, giorno
in cui è chiamato a celebrare la salvezza sua e dell'intera
umanità. Se essa è giorno di gioia e di riposo, ciò
scaturisce proprio dal fatto che è il « giorno del Signore
», il giorno del Signore risorto.
83. Percepita e vissuta
così, la domenica diventa in qualche modo l'anima degli altri
giorni, e in questo senso si può richiamare la riflessione di
Origene, secondo il quale il cristiano perfetto « è sempre
nel giorno del Signore, celebra sempre la domenica ». (131)
La domenica è un'autentica scuola, un itinerario permanente
di pedagogia ecclesiale. Pedagogia insostituibile, specie
nelle condizioni dell'odierna società, segnata sempre più
fortemente dalla frammentazione e dal pluralismo culturale,
che mettono continuamente alla prova la fedeltà dei singoli
cristiani alle esigenze specifiche della loro fede. In molte
parti del mondo si profila la condizione di un cristianesimo
della « diaspora », provato cioè da una situazione di
dispersione, in cui i discepoli di Cristo non riescono più a
mantenere facilmente i contatti fra loro né sono aiutati da
strutture e tradizioni proprie della cultura cristiana. In
questo contesto problematico, la possibilità di ritrovarsi la
domenica con tutti i fratelli di fede, scambiandosi i doni
della fraternità, è un aiuto irrinunciabile.
84. Posta a sostegno della
vita cristiana, la domenica acquista naturalmente anche un
valore di testimonianza e di annuncio. Giorno di preghiera, di
comunione, di gioia, essa si riverbera sulla società,
irradiando energie di vita e motivi di speranza. Essa è
l'annuncio che il tempo, abitato da Colui che è il Risorto e
il Signore della storia, non è la bara delle nostre
illusioni, ma la culla di un futuro sempre nuovo, l'opportunità
che ci viene data per trasformare i momenti fugaci di questa
vita in semi di eternità. La domenica è invito a guardare in
avanti, è il giorno in cui la comunità cristiana grida a
Cristo il suo « Marána tha: vieni, o Signore! » (1
Cor 16, 22). In questo grido di speranza e di attesa, essa
si fa compagnia e sostegno della speranza degli uomini. E di
domenica in domenica, illuminata da Cristo, cammina verso la
domenica senza fine della Gerusalemme celeste, quando sarà
compiuta in tutti i suoi lineamenti la mistica Città di Dio,
che « non ha bisogno della luce del sole, né della luce
della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua
lampada è l'Agnello » (Ap 21, 23).
85. In questa tensione
verso il traguardo la Chiesa è sostenuta e animata dallo
Spirito. Egli ne risveglia la memoria e attualizza per ogni
generazione di credenti l'evento della Risurrezione. E il dono
interiore che ci unisce al Risorto e ai fratelli nell'intimità
di un unico corpo, ravvivando la nostra fede, effondendo nel
nostro cuore la carità, rianimando la nostra speranza. Lo
Spirito è presente senza interruzione ad ogni giorno della
Chiesa, irrompendo imprevedibile e generoso con la ricchezza
dei suoi doni, ma nel raduno domenicale per la celebrazione
settimanale della Pasqua la Chiesa si mette in speciale
ascolto di lui, e si protende con lui verso Cristo, nel
desiderio ardente del suo ritorno glorioso: « Lo Spirito e la
sposa dicono: "Vieni"! » (Ap 22, 17).
Proprio in considerazione del ruolo dello Spirito ho
desiderato che questa esortazione a riscoprire il senso della
domenica cadesse in quest'anno che, nella preparazione
immediata al Giubileo, è dedicato appunto allo Spirito Santo.
86. Affido l'accoglimento
operoso di questa Lettera apostolica, da parte della comunità
cristiana, all'intercessione della Vergine Santa. Ella, senza
nulla detrarre alla centralità di Cristo e del suo Spirito,
è presente in ogni domenica della Chiesa. E lo stesso mistero
di Cristo che lo esige: come potrebbe infatti, Lei che è la Mater
Domini e la Mater Ecclesiae, non essere presente a
titolo speciale, nel giorno che è insieme dies Domini
e dies Ecclesiae?
Alla Vergine Maria
guardano i fedeli che ascoltano la Parola proclamata
nell'assemblea domenicale, imparando da lei a custodirla e
meditarla nel proprio cuore (cfr Lc 2, 19). Con Maria
essi imparano a stare ai piedi della croce, per offrire al
Padre il sacrificio di Cristo ed unire ad esso l'offerta della
propria vita. Con Maria vivono la gioia della risurrezione,
facendo proprie le parole del Magnificat che cantano
l'inesauribile dono della divina misericordia nell'inesorabile
fluire del tempo: « Di generazione in generazione la sua
misericordia si stende su quelli che lo temono » (Lc
1, 50). Di domenica in domenica, il popolo pellegrinante si
pone sulle orme di Maria, e la sua intercessione materna rende
particolarmente intensa ed efficace la preghiera che la Chiesa
eleva alla Santissima Trinità.
87. L'imminenza del
Giubileo, carissimi Fratelli e Sorelle, ci invita ad
approfondire il nostro impegno spirituale e pastorale. È
questo, infatti, il suo vero scopo. Nell'anno in cui verrà
celebrato, molte iniziative lo caratterizzeranno e daranno ad
esso il timbro singolare che non può non avere la conclusione
del secondo millennio e l'inizio del terzo dall'Incarnazione
del Verbo di Dio. Ma questo anno e questo tempo speciale
passeranno, in attesa di altri giubilei e di altre scadenze
solenni. La domenica, con la sua ordinaria « solennità »,
resterà a scandire il tempo del pellegrinaggio della Chiesa,
fino alla domenica senza tramonto.
Vi esorto, perciò, cari
Fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, ad operare
instancabilmente, insieme con i fedeli, perché il valore di
questo giorno sacro sia sempre meglio riconosciuto e vissuto.
Ciò recherà frutti alle comunità cristiane e non mancherà
di esercitare benefici influssi sull'intera società civile.
Gli uomini e le donne del
terzo millennio, incontrando la Chiesa che ogni domenica
celebra gioiosamente il mistero da cui attinge tutta la sua
vita, possano incontrare lo stesso Cristo risorto. E i suoi
discepoli, rinnovandosi costantemente nel memoriale
settimanale della Pasqua, siano annunciatori sempre più
credibili del Vangelo che salva e costruttori operosi della
civiltà dell'amore.
A tutti la mia
Benedizione!
Dal Vaticano, il 31
maggio, solennità di Pentecoste, dell'anno 1998, ventesimo di
Pontificato.
INDICE
Introduzione
Capitolo I
DIES DOMINI
La celebrazione dell'opera del Creatore
« Tutto è stato fatto
per mezzo di lui » (Gv 1, 3)
« In principio Dio creò
il cielo e la terra » (Gn 1, 1)
Lo « shabbat »: il
gioioso riposo del Creatore
« Dio benedisse il
settimo giorno e lo santificò » (Gn 2, 3)
« Ricordare » per «
santificare »
Dal sabato alla domenica
Capitolo II
DIES CHRISTI
Il giorno del Signore risorto e del dono dello Spirito
La Pasqua settimanale
Il primo giorno della
settimana
Progressiva distinzione
dal sabato
Il giorno della nuova
creazione
L'ottavo giorno, figura
dell'eternità
Il giorno di Cristo-luce
Il giorno del dono dello
Spirito
Il giorno della fede
Un giorno irrinunciabile!
Capitolo III
DIES ECCLESIAE
L'assemblea eucaristica cuore della domenica
La presenza del Risorto
L'assemblea eucaristica
L'Eucaristia domenicale
Il giorno della Chiesa
Popolo pellegrinante
Giorno della speranza
La mensa della Parola
La mensa del Corpo di
Cristo
Convito pasquale e
incontro fraterno
Dalla Messa alla «
missione »
Il precetto domenicale
Celebrazione gioiosa e
canora
Celebrazione coinvolgente
e partecipata
Altri momenti della
domenica cristiana
Assemblee domenicali in
assenza del sacerdote
Trasmissioni radiofoniche
e televisive
Capitolo IV
DIES HOMINIS
La domenica giorno di gioia, riposo e solidarietà
La « gioia piena » di
Cristo
Il compimento del sabato
Il giorno del riposo
Giorno di solidarietà
Capitolo V
DIES DIERUM
La domenica festa primordiale, rivelatrice del senso del
tempo
Cristo Alfa ed Omega del
tempo
La domenica nell'anno
liturgico
Conclusione
(1) Cfr Ap 1,10: «
Kyriake heméra »; cfr anche Didachè 14,1; s.
Ignazio di Antiochia, Ai cristiani di Magnesia 9, 1-2: SC
10, 88-89.
(2) Pseudo Eusebio di
Alessandria, Sermone 16: PG 86, 416.
(3) In die dominica
Paschae II, 52: CCL 78, 550.
(4) Conc. Ecum.
Vat. II, Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium,
106.
(5)
Ibid.
(6)
Cfr Motu proprio Mysterii paschalis (14 febbraio 1969):
AAS 61 (1969), 222-226.
(7) Cfr Nota pastorale
della Conferenza Episcopale Italiana « Il giorno del
Signore » (15 luglio 1984), 5: Ench. CEI 3, 1938.
(8) Cost. sulla sacra
liturgia Sacrosanctum Concilium, 106.
(9) Omelia per il solenne
inizio del Pontificato (22 ottobre 1978), 5: AAS 70
(1978), 947.
(10) N. 25: AAS 73
(1981), 639.
(11) Cost. past. sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 34.
(12) Il sabato è vissuto
dai nostri fratelli ebrei con una spiritualità « sponsale »,
come emerge, ad esempio, in testi di Genesi Rabbah X, 9
e XI, 8 (cfr J. Neusner, Genesis Rabbah, vol. I,
Atlanta 1985, p. 107 e p. 117). Di tonalità nuziale è pure
il canto Leka dôdi: « Sarà felice di te il tuo Dio,
come è felice lo sposo con la sposa. In mezzo ai fedeli del
tuo popolo prediletto vieni o sposa, shabbat regina »
(Preghiera serale del sabato, a cura di A. Toaff, Roma
1968-69, p. 3).
(13)
Cfr A. J. Heschel, The sabbath. Its meaning for modern man
(22a ed. 1995), pp. 3-24.
(14)
« Verum autem sabbatum ipsum redemptorem nostrum Iesum
Christum Dominum habemus »: Epist. 13,
1: CCL 140A, 992.
(15)
Epist. ad Decentium XXV, 4, 7: PL 20, 555.
(16) Homiliae in
Hexaemeron II, 8: SC 26, 184.
(17) Cfr In Io. ev.
tract. XX, 20, 2: CCL 36, 203; Epist. 55, 2:
CSEL 34, 170-171.
(18) Questo riferimento
alla risurrezione è particolarmente visibile nella lingua
russa, dove la domenica si dice appunto « risurrezione » (voskresén'e).
(19) Epist. 10, 96,
7.
(20) Cfr ibid. In
riferimento alla lettera di Plinio, anche Tertulliano ricorda
i coetus antelucani in Apologeticum 2, 6: CCL
1, 88; De corona 3, 3: CCL 2, 1043.
(21) Ai cristiani di
Magnesia 9, 1-2: SC 10, 88-89.
(22) Sermo 8 in octava
Paschalis 4: PL 46, 841. Questo carattere di «
primo giorno » della domenica è ben evidente nel calendario
liturgico latino, dove il lunedì è denominato feria
secunda, il martedì feria tertia ecc. Una simile
denominazione dei giorni della settimana si ritrova nella
lingua portoghese.
(23) S. Gregorio di Nissa,
De castigatione: PG 46, 309. Anche nella
liturgia maronita è sottolineato il nesso fra il sabato e la
domenica, a partire dal « mistero del Sabato Santo » (cfr M.
Hayek, Maronite [Eglise], Dictionnaire de spiritualité, X
[1980], 632-644).
(24) Rito del Battesimo
dei bambini, n. 9; cfr Rito dell'iniziazione cristiana
degli adulti, n. 59.
(25) Cfr Messale Romano,
Rito dell'aspersione domenicale dell'acqua benedetta.
(26) Cfr s. Basilio, Sullo
Spirito Santo 27, 66: SC 17, 484-485. Cfr anche Epistola
di Barnaba 15, 8-9: SC 172, 186-189; s. Giustino, Dialogo
con Trifone 24.138: PG 6, 528.793; Origene, Comm.
sui Salmi, Salmo 118 (119), 1: PG 12, 1588.
(27) « Domine,
praestitisti nobis pacem quietis, pacem sabbati, pacem sine
vespera »: Confess. 13, 50: CCL 27, 272.
(28) Cfr s. Agostino, Epist.
55,17: CSEL 34, 188: « Ita ergo erit octavus, qui
primus, ut prima vita sed aeterna reddatur ».
(29) Così nell'inglese
Sunday e nel tedesco Sonntag.
(30) Apologia I,
67: PG 6, 430.
(31) Cfr s. Massimo di
Torino, Sermo 44, 1: CCL 23, 178; Id., Sermo
53, 2: CCL 23, 219; Eusebio di Cesarea, Comm. in Ps.
91: PG 23, 1169-1173.
(32) Si veda, ad esempio,
l'inno per l'Ufficio delle Letture: « Dies aetasque
ceteris octava splendet sanctior in te quam, Iesu, consecras
primitiae surgentium » (I sett.); ed anche: « Salve
dies, dierum gloria dies felix Christi victoria, dies digna
iugi laetitia dies prima. Lux
divina caecis irradiat, in qua Christus infernum spoliat,
mortem vincit et reconciliat summis ima »
(II sett.). Analoghe
espressioni si ritrovano in inni adottati nella Liturgia delle
Ore in diverse lingue moderne.
(33) Cfr s. Clemente
Alessandrino Stromati VI, 138, 1-2: PG 9, 364.
(34) Cfr Giovanni Paolo II,
Lett. enc. Dominum et vivificantem (18 maggio 1986),
22-26: AAS 78 (1986), 829-837.
(35) Cfr s. Atanasio di
Alessandria, Lettere domenicali 1, 10: PG 26,
1366.
(36) Cfr Bardesane, Dialogo
sul destino 46: PS 2, 606-607.
(37) Cost. sulla sacra
liturgia Sacrosanctum Concilium, Appendice:
Dichiarazione circa la riforma del calendario.
(38)
Cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 9.
(39) Cfr Giovanni Paolo II,
Lett. Dominicae Cenae (24 febbraio 1980), 4: AAS
72 (1980), 120; Lett. enc. Dominum et vivificantem (18
maggio 1986), 62-64: AAS 78 (1986), 889-894.
(40) Cfr Giovanni Paolo II,
Lett. ap. Vicesimus
quintus annus
(4 dicembre 1988), 9: AAS 81 (1989), 905-906.
(41) N. 2177.
(42) Cfr Giovanni Paolo II,
Lett. ap. Vicesimus
quintus annus
(4 dicembre 1988), 9: AAS 81 (1989), 905-906.
(43) Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 41;
cfr Decr. sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus
Dominus, 15.
(44) Sono le parole dell'embolismo,
formulato con questa o analoghe espressioni all'interno di
alcuni canoni eucaristici in diverse lingue. Esse sottolineano
efficacemente il carattere « pasquale » della domenica.
(45) Cfr Congr. per la
Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica
su alcuni aspetti della Chiesa come comunione Communionis
notio (28 maggio 1992), 11-14: AAS 85 (1993),
844-847.
(46) Discorso al terzo
gruppo di Vescovi degli Stati Uniti d'America (17 marzo 1998),
4: L'Osservatore Romano 18 marzo 1998, p. 4.
(47) Cost. sulla sacra
liturgia Sacrosanctum Concilium, 42.
(48) S. Congr. dei Riti,
Istr. sul culto del mistero eucaristico Eucharisticum
mysterium (25 maggio 1967), 26: AAS 59 (1967), 555.
(49)
Cfr s. Cipriano, De Orat. Dom. 23: PL 4, 553;
Id. De cath. Eccl. unitate, 7: CSEL 3-1, 215;
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium,
4; Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium,
26.
(50) Cfr Giovanni Paolo II,
Esort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981), 57;
61: AAS 74 (1982), 151; 154.
(51) Cfr S. Congr. per il
Culto Divino, Direttorio per le Messe dei fanciulli (1
novembre 1973): AAS 66 (1974), 30-46.
(52) Cfr S. Congr. dei
Riti, Istr. sul culto del mistero eucaristico Eucharisticum
mysterium (25 maggio 1967), 26: AAS 59 (1967),
555-556; S. Congr. per i Vescovi, Direttorio per il ministero
pastorale dei Vescovi Ecclesiae imago (22 febbraio
1973), 86 c: Ench. Vat., 4, 2071.
(53) Cfr Giovanni Paolo II,
Esort. ap. post-sinodale Christifideles laici (30
dicembre 1988), 30: AAS 81 (1989), 446-447.
(54) Cfr S. Congr. per il
Culto Divino, Istr. Le messe per gruppi particolari (15
maggio 1969), 10: AAS 61 (1969), 810.
(55)
Cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 48-51.
(56) « Haec est vita
nostra, ut desiderando exerceamur »: S. Agostino, In
prima Ioan. tract. 4, 6: SC 75, 232.
(57) Messale Romano,
Embolismo dopo il Padre Nostro.
(58) Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium
et spes, 1.
(59) Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 1; cfr Giovanni
Paolo II, Lett. enc. Dominum et vivificantem (18 maggio
1986), 61-64: AAS 78 (1986), 888-894.
(60) Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 7;
cfr 33.
(61) Ibid., 56; cfr
Ordo Lectionum Missae, Praenotanda, n. 10.
(62) Cost. sulla sacra
liturgia Sacrosanctum Concilium, 51.
(63) Cfr ibid., 52;
Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 2; Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 614.
(64) Cost. ap. Missale
Romanum (3 aprile 1969): AAS 61 (1969), 220.
(65) Nella Cost.
conciliare Sacrosanctum Concilium, 24, si parla di « suavis
et vivus Sacrae Scripturae affectus ».
(66) Giovanni Paolo II,
Lett. Dominicae Cenae (24 febbraio 1980), 10: AAS
72 (1980), 135.
(67)
Cfr Conc. Ecum Vat. II,
Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, 25.
(68) Cfr Ordo lectionum
Missae, Praenotanda, cap. III.
(69) Cfr Ordo Lectionum
Missae, Praenotanda, cap. I, n. 6.
(70) Conc. Ecum.
Tridentino, Sess. XXII, Dottrina e canoni sul santissimo
sacrificio della Messa, II: DS, 1743; cfr Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1366.
(71) Catechismo della
Chiesa Cattolica, 1368.
(72) S. Congr. dei Riti
Istr. sul culto del mistero eucaristico Eucharisticum
mysterium (25 maggio 1967), 3 b: AAS 59 (1967),
541; cfr Pio XII, Lett. enc. Mediator Dei (20 novembre
1947), II: AAS 39 (1947), 564-566.
(73) Cfr Catechismo
della Chiesa Cattolica, 1385; cfr anche Congr. per la
Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica
circa la recezione della comunione eucaristica da parte di
fedeli divorziati risposati (14 settembre 1994): AAS 86
(1994), 974-979.
(74) Cfr Innocenzo I, Epist.
25, 1 a Decenzio di Gubbio: PL 20, 553.
(75) II, 59, 2-3: ed. F.
X. Funk, 1905, 170-171.
(76) Cfr Apologia I,
67, 3-5: PG 6, 430.
(77) Acta SS. Saturnini,
Dativi et aliorum plurimorum martyrum in Africa 7, 9, 10: PL
8, 707.709-710.
(78) Cfr can. 21, Mansi, Conc.
II, col. 9.
(79) Cfr can. 47, Mansi, Conc.
VIII, col. 332.
(80) Cfr la proposizione
contraria, condannata da Innocenzo XI nel 1679, riguardante
l'obbligo morale della santificazione della festa: DS
2152.
(81) Can. 1248: « Festis
de praecepto diebus Missa audienda est »; can. 1247 § 1:
« Dies festi sub praecepto in universa Ecclesia sunt...
omnes et singuli dies dominici ».
(82) Codice di Diritto
Canonico, can. 1247; il Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 881 § 1, prescrive che « i fedeli
cristiani sono tenuti all'obbligo, nelle domeniche e nelle
feste di precetto, di partecipare alla Divina Liturgia oppure,
secondo le prescrizioni o la legittima consuetudine della
propria Chiesa sui iuris, alla celebrazione delle lodi
divine ».
(83) « Coloro che
deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un
peccato grave ». N. 2181.
(84) S. Congr. per i
Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi
Ecclesiae imago (22 febbraio 1973), 86 a: Ench. Vat. 4,
2069.
(85) Cfr Codice di
Diritto Canonico, can. 905 § 2.
(86)
Cfr Pio XII, Cost. ap. Christus
Dominus (6 gennaio
1953): AAS 45 (1953), 15-24; Motu proprio Sacram
Communionem (19 marzo 1957): AAS 49 (1957),
177-178. Congr. S. Uffizio, Istr. sulla disciplina circa il
digiuno eucaristico (6 gennaio 1953): AAS 45 (1953),
47-51.
(87) Cfr Codice di
Diritto Canonico, can. 1248 § 1; Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali, can. 881 § 2.
(88) Cfr Missale
Romanum, Normae universales de Anno liturgico et de
Calendario, 3.
(89) Cfr S. Congr. per i
vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Ecclesiae
imago (22 febbraio 1973), 86: Ench. Vat. 4,
2069-2073.
(90)
Cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. sulla sacra liturgia, Sacrosanctum Concilium,
14.26; Giovanni Paolo II, Lett. ap. Vicesimus
quintus annus
(4 dicembre 1988), 4.6.12: AAS 81 (1989), 900-901; 902;
909-910.
(91)
Cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 10.
(92) Cfr Istr.
interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione
dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de
mysterio (15 agosto 1997), 6.8: AAS 89 (1997),
869.870-872.
(93) Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 10: « in
oblationem Eucharistiae concurrunt ».
(94) Ibid., 11.
(95) Cfr Codice di Diritto
Canonico, can. 1248 § 2.
(96) Cfr S. Congr. per il
Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in
assenza del sacerdote Christi Ecclesia (2 giugno 1988):
Ench. Vat. 11, 442-468; Istr. interdicasteriale su
alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al
ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15
agosto 1997): AAS 89 (1997), 852-877.
(97) Cfr Codice di Diritto
Canonico, can. 1248 § 2; Congr. per la Dottrina della Fede,
Lettera Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III: AAS
75 (1983), 1007.
(98) Cfr Pont. Commissione
per le Comunicazioni Sociali, Istr. Communio et progressio
(23 maggio 1971), 150-152.157: AAS 63 (1971),
645-646.647.
(99) Proclamazione
diaconale in onore del giorno del Signore: cfr il testo
siriaco nel Messale secondo il rito della Chiesa di Antiochia
dei Maroniti (edizione in siriaco e arabo), Jounieh (Libano)
1959, p. 38.
(100) V, 20, 11: ed. F. X.
Funk, 1905, 298; cfr Didachè 14, 1: ed. F. X. Funk,
1901, 32; Tertulliano, Apologeticum 16, 11: CCL
1, 116. Si veda, in particolare, l'Epistola di Barnaba
15, 9: SC 172, 188-189: « Ecco perché celebriamo come
una festa gioiosa l'ottavo giorno nel quale Gesù è
risuscitato dai morti e, dopo essere apparso, è salito al
cielo ».
(101) Tertulliano, ad
esempio, ci informa che nelle domeniche era vietato
l'inginocchiarsi, in quanto questa posizione, essendo allora
colta soprattutto come gesto penitenziale, sembrava poco
opportuna nel giorno della gioia: cfr De corona 3, 4: CCL
2, 1043.
(102) Epist. 55,
28: CSEL 342, 202.
(103) Cfr S. Teresa di Gesù
Bambino e del Volto Santo, Derniers entretiens, 5-6 Juillet
1897, in: Oeuvres complètes, Cerf-Desclée de Brouwer,
Paris 1992, pp. 1024-1025.
(104) Esort. ap. Gaudete
in Domino (9 maggio 1975), II: AAS 67 (1975), 295.
(105)
Ibid., VII, l.c., 322.
(106) Hex. 6, 10,
76: CSEL 321, 261.
(107) Cfr editto di
Costantino, 3 luglio 321: Codex Theodosianus II, tit. 8, 1,
ed. Th. Mommsen, 12, 87; Codex Iustiniani 3, 12, 2, ed.
P. Krueger, 248.
(108) Cfr Eusebio di
Cesarea, Vita di Costantino 4, 18: PG 20, 1165.
(109) Il più antico
documento ecclesiastico sull'argomento è il can. 29 del
Concilio di Laodicea (2a metà del IV sec.): Mansi, II, col.
569-570. Dal VI al IX secolo molti Concili proibirono le « opera
ruralia ». La legislazione sui lavori proibiti, sostenuta
anche da leggi civili, diventò progressivamente più
dettagliata.
(110)
Cfr Lett. enc. Rerum
novarum (15 maggio
1891): Acta Leonis XIII 11 (1891), 127-128.
(111) Hex. 2, 1, 1:
CSEL 321, 41.
(112) Cfr Codice di
Diritto Canonico, can. 1247; Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali, can. 881 §§ 1.4.
(113) Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 9.
(114) Cfr anche s.
Giustino, Apologia I, 67, 6: « Quelli che sono
nell'abbondanza e che vogliono dare, danno liberamente
ciascuno ciò che vuole, e ciò che è raccolto è consegnato
a colui che presiede e egli assiste gli orfani, le vedove, i
malati, gli indigenti, i prigionieri, gli ospiti stranieri, in
una parola, soccorre tutti quelli che sono nel bisogno »: PG
6, 430.
(115)
De Nabuthae 10, 45: « Audis, dives, quid Dominus
Deus dicat? Et
tu ad ecclesiam venis, non ut aliquid largiaris pauperi, sed
ut auferas »: CSEL
322, 492.
(116) Omelie sul
Vangelo di Matteo 50, 3-4: PG 58, 508-509.
(117) Cfr s. Paolino di
Nola, Epist. 13, 11-12 a Pammachio: CSEL 29,
92-93. Il senatore romano è lodato appunto per aver quasi
riprodotto il miracolo evangelico, unendo alla partecipazione
eucaristica la distribuzione di cibo ai poveri.
(118) Giovanni Paolo II,
Lett. ap. Tertio millennio adveniente (10 novembre
1994), 10: AAS 87 (1995), 11.
(119) Ibid.
(120) Cfr Catechismo
della Chiesa Cattolica, 731-732.
(121)
Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 102.
(122)
Ibid., 103.
(123)
Ibid., 104.
(124) Carm. XVI,
3-4: « Omnia praetereunt, sanctorum gloria durat in
Christo qui cuncta novat, dum permanet ipse »: CSEL
30, 67.
(125) Cfr Codice di
Diritto Canonico, can. 1247; Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali, can. 881 §§ 1.4.
(126) Di diritto comune,
nella Chiesa latina, sono di precetto le feste della Natività
del nostro Signore Gesù Cristo, dell'Epifania,
dell'Ascensione, del Corpo e del Sangue di Cristo, di santa
Maria Madre di Dio, della sua Immacolata Concezione e della
sua Assunzione, di san Giuseppe, dei santi Apostoli Pietro e
Paolo, di Tutti i Santi: cfr Codice di Diritto Canonico,
can. 1246. Giorni festivi di precetto comuni a tutte le Chiese
orientali sono quelli della Natività di Nostro Signore Gesù
Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione, della Dormizione di
santa Maria Madre di Dio, dei santi Apostoli Pietro e Paolo:
cfr Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 880
§ 3.
(127) Cfr Codice di
Diritto Canonico, can. 1246 § 2; per le Chiese orientali
cfr Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 880
§ 3.
(128) Cfr S. Congr. der
Riti, Normae universales de Anno liturgico et de Calendario
(21 marzo 1969), 5. 7: Ench. Vat. 3, 895. 897.
(129) Cfr Caeremoniale
Episcoporum, Ed. typica 1995, n. 230.
(130)
Cfr ibid., n. 233.
(131) Contro Celso
VIII, 22: SC 150, 222-224.
|