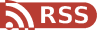|
|
LETTERA APOSTOLICA
NOVO MILLENNIO INEUNTE
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
ALL'EPISCOPATO, AL CLERO E AI FEDELI
AL TERMINE DEL GRANDE GIUBILEO
DELL'ANNO DUEMILA
Ai Confratelli nell'Episcopato,
ai sacerdoti e ai diaconi,
ai religiosi e alle religiose,
a tutti i fedeli laici.
1. All'inizio del
nuovo millennio, mentre si chiude il Grande Giubileo in cui abbiamo
celebrato i duemila anni della nascita di Gesù e un nuovo tratto di
cammino si apre per la Chiesa, riecheggiano nel nostro cuore le parole
con cui un giorno Gesù, dopo aver parlato alle folle dalla barca di
Simone, invitò l'Apostolo a « prendere il largo » per la pesca: « Duc
in altum » (Lc 5,4). Pietro e i primi compagni si fidarono
della parola di Cristo, e gettarono le reti. « E avendolo fatto,
presero una quantità enorme di pesci » (Lc 5,6).
Duc in altum! Questa
parola risuona oggi per noi, e ci invita a fare memoria grata del
passato, a vivere con passione il presente, ad aprirci con fiducia al
futuro: « Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre! » (Eb 13,8).
Grande è stata quest'anno la gioia della
Chiesa, che si è dedicata a contemplare il volto del suo Sposo e
Signore. Essa si è fatta più che mai popolo pellegrinante, guidato da
Colui che è « il Pastore grande delle pecore » (Eb 13,20). Con
uno straordinario dinamismo, che ha coinvolto tanti suoi membri, il
Popolo di Dio, qui a Roma, come a Gerusalemme e in tutte le singole
Chiese locali, è passato attraverso la « Porta Santa » che è Cristo.
A lui, traguardo della storia e unico Salvatore del mondo, la Chiesa e
lo Spirito hanno gridato: « Marana tha — Vieni, Signore Gesù
» (cfr Ap 22,17.20; 1 Cor 16,22).
È impossibile misurare l'evento di
grazia che, nel corso dell'anno, ha toccato le coscienze. Ma certamente,
« un fiume d'acqua viva », quello che perennemente scaturisce « dal
trono di Dio e dell'Agnello » (cfr Ap 22,1), si è riversato
sulla Chiesa. E l'acqua dello Spirito che disseta e rinnova (cfr Gv 4,14).
E l'amore misericordioso del Padre che, in Cristo, ci è stato ancora
una volta svelato e donato. Al termine di quest'anno possiamo ripetere,
con rinnovata esultanza, l'antica parola della gratitudine: « Celebrate
il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia » (Sal
118[117],1).
2. Sento perciò il bisogno di rivolgermi
a voi, carissimi, per condividere il canto della lode. A quest'Anno
Santo del Duemila avevo pensato, come ad una scadenza importante, fin
dall'inizio del mio Pontificato. Avevo colto, in questa celebrazione, un
appuntamento provvidenziale, in cui la Chiesa, a trentacinque anni dal
Concilio Ecumenico Vaticano II, sarebbe stata invitata ad interrogarsi
sul suo rinnovamento per assumere con nuovo slancio la sua missione
evangelizzatrice.
È riuscito il Giubileo in questo
intento? Il nostro impegno, con i suoi sforzi generosi e le immancabili
fragilità, è davanti allo sguardo di Dio. Ma non possiamo sottrarci al
dovere della gratitudine per le « meraviglie » che Dio ha compiuto per
noi. « Misericordias Domini in aeternum cantabo » (Sal 89[88],2).
Al tempo stesso, quanto è avvenuto sotto
i nostri occhi chiede di essere riconsiderato e, in certo senso,
decifrato, per ascoltare ciò che lo Spirito, lungo quest'anno così
intenso, ha detto alla Chiesa (cfr Ap 2,7.11.17 ecc.).
3. Soprattutto, carissimi Fratelli e
Sorelle, è doveroso per noi proiettarci verso il futuro che ci attende.
Tante volte, in questi mesi, abbiamo guardato al nuovo millennio che si
apre, vivendo il Giubileo non solo come memoria del passato, ma
come profezia dell'avvenire. Bisogna ora far tesoro della grazia
ricevuta, traducendola in fervore di propositi e concrete linee
operative. Un compito al quale desidero invitare tutte le Chiese locali.
In ciascuna di esse, raccolta intorno al suo Vescovo, nell'ascolto della
Parola, nell'unione fraterna e nella « frazione del pane » (cfr At 2,42),
è « veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa,
cattolica e apostolica ».1 È soprattutto nel concreto di
ciascuna Chiesa che il mistero dell'unico Popolo di Dio assume quella
speciale configurazione che lo rende aderente ai singoli contesti e
culture.
Questo radicarsi della Chiesa nel tempo e
nello spazio riflette, in ultima analisi, il movimento stesso
dell'Incarnazione. E ora dunque che ciascuna Chiesa, riflettendo su
ciò che lo Spirito ha detto al Popolo di Dio in questo speciale anno di
grazia, ed anzi nel più lungo arco di tempo che va dal Concilio
Vaticano II al Grande Giubileo, compia una verifica del suo fervore e
recuperi nuovo slancio per il suo impegno spirituale e pastorale. È a
tal fine che desidero offrire in questa Lettera, a conclusione dell'Anno
giubilare, il contributo del mio ministero petrino, perché la Chiesa
risplenda sempre di più nella varietà dei suoi doni e nell'unità del
suo cammino.
I
L'incontro
con Cristo
EreditÀ del Grande Giubileo
4. « Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio
onnipotente » (Ap 11,17). Nella Bolla di indizione del Giubileo
auspicavo che la celebrazione bimillenaria del mistero dell'Incarnazione
fosse vissuta come «un unico, ininterrotto canto di lode alla Trinità»2
e insieme «come cammino di riconciliazione e come segno di genuina
speranza per quanti guardano a Cristo ed alla sua Chiesa».3
L'esperienza dell'Anno giubilare si è modulata appunto secondo queste
dimensioni vitali, raggiungendo momenti di intensità che ci hanno fatto
quasi toccare con mano la presenza misericordiosa di Dio, dal quale «discende
ogni buon regalo e ogni dono perfetto» (Gc 1,17).
Penso alla dimensione della lode, innanzitutto.
È da qui infatti che muove ogni autentica risposta di fede alla
rivelazione di Dio in Cristo. Il cristianesimo è grazia, è la sorpresa
di un Dio che, non pago di creare il mondo e l'uomo, si è messo al
passo con la sua creatura, e dopo aver parlato a più riprese e in
diversi modi « per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha
parlato a noi per mezzo del Figlio » (Eb 1,1-2).
In questi giorni! Sì,
il Giubileo ci ha fatto sentire che duemila anni di storia sono passati
senza attenuare la freschezza di quell'« oggi » con cui gli angeli
annunciarono ai pastori l'evento meraviglioso della nascita di Gesù a
Betlemme: « Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è
il Cristo Signore » (Lc 2,11). Duemila anni sono passati, ma
resta più che mai viva la proclamazione che Gesù fece della sua
missione davanti ai suoi attoniti concittadini nella sinagoga di
Nazareth, applicando a sé la profezia di Isaia: « Oggi si è adempiuta
questa Scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi » (Lc 4,21).
Duemila anni sono passati, ma torna sempre consolante per i peccatori
bisognosi di misericordia — e chi non lo è ? — quell'« oggi »
della salvezza che sulla Croce aprì le porte del Regno di Dio al
ladrone pentito: « In verità ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso
» (Lc 23,43).
La pienezza del tempo
5. La coincidenza di questo Giubileo con
l'ingresso in un nuovo millennio ha certamente favorito, senza alcun
cedimento a fantasie millenariste, la percezione del mistero di Cristo
nel grande orizzonte della storia della salvezza. Il cristianesimo è
religione calata nella storia! È sul terreno della storia, infatti,
che Dio ha voluto stabilire con Israele un'alleanza e preparare così la
nascita del Figlio dal grembo di Maria nella « pienezza del tempo » (Gal
4,4). Colto nel suo mistero divino e umano, Cristo è il fondamento
e il centro della storia, ne è il senso e la meta ultima. È per mezzo
di lui, infatti, Verbo e immagine del Padre, che « tutto è stato fatto
» (Gv 1,3; cfr Col 1,15). La sua incarnazione, culminante
nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito, costituisce il cuore
pulsante del tempo, l'ora misteriosa in cui il Regno di Dio si è fatto
vicino (cfr Mc 1,15), anzi ha messo radici, come seme destinato a
diventare un grande albero (cfr Mc 4,30-32), nella nostra storia.
« Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e
sempre tu regnerai ». Con questo canto mille e mille volte ripetuto,
abbiamo quest'anno contemplato Cristo quale ce lo presenta l'Apocalisse:
« l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine » (Ap
22,13). E contemplando Cristo, abbiamo insieme adorato il Padre e lo
Spirito, l'unica e indivisa Trinità, mistero ineffabile in cui tutto ha
la sua origine e tutto il suo compimento.
Purificazione della memoria
6. Perché il nostro occhio potesse
essere più puro per contemplare il mistero, quest'Anno giubilare è
stato fortemente caratterizzato dalla richiesta di perdono. E ciò
è stato vero non solo per i singoli, che si sono interrogati sulla
propria vita, per implorare misericordia e ottenere il dono speciale
dell'indulgenza, ma per l'intera Chiesa, che ha voluto ricordare le
infedeltà con cui tanti suoi figli, nel corso della storia, hanno
gettato ombra sul suo volto di Sposa di Cristo.
A questo esame di coscienza ci eravamo a
lungo disposti, consapevoli che la Chiesa, comprendendo nel suo seno i
peccatori, è « santa e sempre bisognosa di purificazione ».4
Convegni scientifici ci hanno aiutato a focalizzare quegli aspetti in
cui lo spirito evangelico, nel corso dei primi due millenni, non sempre
ha brillato. Come dimenticare la toccante Liturgia del 12 marzo 2000,
in cui io stesso, nella Basilica di san Pietro, fissando lo sguardo
sul Crocifisso, mi sono fatto voce della Chiesa chiedendo perdono per il
peccato di tutti i suoi figli? Questa « purificazione della memoria »
ha rafforzato i nostri passi nel cammino verso il futuro, rendendoci
insieme più umili e vigili nella nostra adesione al Vangelo.
I testimoni della fede
7. La viva coscienza penitenziale,
tuttavia, non ci ha impedito di rendere gloria al Signore per quanto ha
operato in tutti i secoli, e in particolare nel secolo che ci siamo
lasciati alle spalle, assicurando alla sua Chiesa una grande schiera
di santi e di martiri. Per alcuni di essi l'Anno giubilare è stato
anche l'anno della beatificazione o canonizzazione. Riferita a Pontefici
ben noti alla storia o ad umili figure di laici e religiosi, da un
continente all'altro del globo, la santità è apparsa più che mai la
dimensione che meglio esprime il mistero della Chiesa. Messaggio
eloquente che non ha bisogno di parole, essa rappresenta al vivo il
volto di Cristo.
Molto si è fatto poi, in occasione
dell'Anno Santo, per raccogliere le memorie preziose dei Testimoni
della fede nel secolo XX. Li abbiamo commemorati il 7 maggio 2000,
insieme con i rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali,
nello scenario suggestivo del Colosseo, simbolo delle antiche
persecuzioni. È un'eredità da non disperdere, da consegnare a un
perenne dovere di gratitudine e a un rinnovato proposito di imitazione.
Chiesa pellegrinante
8. Quasi mettendosi sulle orme dei Santi,
si sono avvicendati qui a Roma, presso le tombe degli Apostoli,
innumerevoli figli della Chiesa, desiderosi di professare la propria
fede, confessare i propri peccati e ricevere la misericordia che salva.
Il mio sguardo quest'anno non è rimasto soltanto impressionato dalle
folle che hanno riempito Piazza san Pietro durante molte celebrazioni.
Non di rado mi sono soffermato a guardare le lunghe file di pellegrini
in paziente attesa di varcare la Porta Santa. In ciascuno di essi
cercavo di immaginare una storia di vita, fatta di gioie, ansie, dolori;
una storia incontrata da Cristo, e che nel dialogo con lui riprendeva il
suo cammino di speranza.
Osservando poi il continuo fluire dei
gruppi, ne traevo come un'immagine plastica della Chiesa
pellegrinante, di quella Chiesa posta, come dice sant'Agostino, «
fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio ».5 A
noi non è dato di osservare che il volto più esteriore di questo
evento singolare. Chi può misurare le meraviglie di grazia, che si sono
realizzate nei cuori? Conviene tacere e adorare, fidandosi umilmente
dell'azione misteriosa di Dio e cantandone l'amore senza fine: «Misericordias
Domini in aeternum cantabo!».
I giovani
9. I numerosi incontri giubilari hanno
visto radunarsi le più diverse categorie di persone, registrando una
partecipazione davvero impressionante, che talvolta ha messo a dura
prova l'impegno degli organizzatori e degli animatori, sia ecclesiali
che civili. Desidero approfittare di questa Lettera per esprimere a
tutti il mio grazie più cordiale. Ma al di là del numero, ciò che
tante volte mi ha commosso è stata la constatazione dell'impegno serio
di preghiera, di riflessione, di comunione, che questi incontri hanno
per lo più manifestato.
E come non ricordare specialmente il
gioioso ed entusiasmante raduno dei giovani? Se c'è un'immagine del
Giubileo dell'Anno 2000 che più di altre resterà viva nella memoria,
sicuramente è quella della marea di giovani con i quali ho potuto
stabilire una sorta di dialogo privilegiato, sul filo di una reciproca
simpatia e di un'intesa profonda. È stato così fin dal benvenuto che
ho loro dato in Piazza san Giovanni in Laterano e in Piazza san Pietro.
Poi li ho visti sciamare per la Città, allegri come devono essere i
giovani, ma anche pensosi, desiderosi di preghiera, di « senso », di
amicizia vera. Non sarà facile, né per loro stessi, né per quanti li
hanno osservati, cancellare dalla memoria quella settimana in cui Roma
si è fatta « giovane coi giovani ». Non sarà possibile dimenticare
la celebrazione eucaristica di Tor Vergata.
Ancora una volta, i giovani si sono
rivelati per Roma e per la Chiesa un dono speciale dello Spirito di
Dio. C'è talvolta, quando si guarda ai giovani, con i problemi e le
fragilità che li segnano nella società contemporanea, una tendenza al
pessimismo. Il Giubileo dei Giovani ci ha come «spiazzati»,
consegnandoci invece il messaggio di una gioventù che esprime un
anelito profondo, nonostante possibili ambiguità, verso quei valori
autentici che hanno in Cristo la loro pienezza. Non è forse Cristo il
segreto della vera libertà e della gioia profonda del cuore? Non è
Cristo l'amico supremo e insieme l'educatore di ogni autentica amicizia?
Se ai giovani Cristo è presentato col suo vero volto, essi lo sentono
come una risposta convincente e sono capaci di accoglierne il messaggio,
anche se esigente e segnato dalla Croce. Per questo, vibrando al loro
entusiasmo, non ho esitato a chiedere loro una scelta radicale di fede e
di vita, additando un compito stupendo: quello di farsi « sentinelle
del mattino » (cfr Is 21,11-12) in questa aurora del nuovo
millennio.
Pellegrini delle varie categorie
10. Non posso ovviamente soffermarmi in
dettaglio sui singoli eventi giubilari. Ciascuno di essi ha avuto il suo
carattere e ha lasciato il suo messaggio non solo a quanti vi hanno
preso parte direttamente, ma anche a quanti ne hanno avuto notizia o vi
hanno partecipato a distanza, attraverso i mass media. Ma come non
ricordare il tono festoso del primo grande incontro dedicato ai
bambini? Iniziare con loro, significava in certo modo rispettare il
monito di Gesù: « Lasciate che i bambini vengano a me » (Mc 10,14).
Significava forse ancor più ripetere il gesto che egli compì, quando
« pose in mezzo » un bambino e ne fece il simbolo stesso
dell'atteggiamento da assumere, se si vuole entrare nel Regno di Dio (cfr
Mt 18,2-4).
Così, in certo senso, è sulle orme dei
bambini che sono venuti a chiedere la misericordia giubilare le più
varie categorie di adulti: dagli anziani ai malati e disabili, dai
lavoratori delle officine e dei campi agli sportivi, dagli artisti ai
docenti universitari, dai Vescovi e presbiteri alle persone di vita
consacrata, dai politici ai giornalisti fino ai militari, venuti a
ribadire il senso del loro servizio come un servizio alla pace.
Grande respiro ebbe il raduno dei
lavoratori, svoltosi il 1° maggio nella tradizionale data della
festa del lavoro. Ad essi chiesi di vivere la spiritualità del lavoro,
ad imitazione di san Giuseppe e di Gesù stesso. Il loro giubileo mi
offrì inoltre l'occasione per pronunciare un forte invito a sanare gli
squilibri economici e sociali esistenti nel mondo del lavoro, e a
governare con decisione i processi della globalizzazione economica in
funzione della solidarietà e del rispetto dovuto a ciascuna persona
umana.
I bambini, con la loro incontenibile
festosità, sono tornati nel Giubileo delle Famiglie, in cui sono
stati additati al mondo come « primavera della famiglia e della società
». Davvero eloquente è stato questo incontro giubilare, in cui tante
famiglie, provenienti dalle diverse regioni del mondo, sono venute ad
attingere con rinnovato fervore la luce di Cristo sul disegno originario
di Dio a loro riguardo (cfr Mc 10,6-8; Mt 19,4-6). Esse si
sono impegnate a irradiarla verso una cultura che rischia di smarrire in
modo sempre più preoccupante il senso stesso del matrimonio e
dell'istituto familiare.
Tra gli incontri più toccanti, poi,
rimane per me quello che ho avuto con i carcerati di Regina Caeli.
Nei loro occhi ho letto il dolore, ma anche il pentimento e la speranza.
Per loro il Giubileo è stato a titolo tutto speciale un « anno di
misericordia ».
Simpatico, infine, negli ultimi giorni
dell'anno, l'incontro con il mondo dello spettacolo, che tanta
forza di attrazione esercita sull'animo della gente. Alle persone
coinvolte in questo settore ho ricordato la grande responsabilità di
proporre, con il lieto divertimento, messaggi positivi, moralmente sani,
capaci di infondere fiducia e amore alla vita.
Il Congresso Eucaristico
Internazionale
11. Nella logica di quest'Anno giubilare,
un significato qualificante doveva avere il Congresso Eucaristico
Internazionale. E lo ha avuto! Se l'Eucaristia è il sacrificio di
Cristo che si rende presente tra noi, poteva la sua presenza reale non
essere al centro dell'Anno Santo dedicato all'incarnazione del Verbo? Fu
previsto, proprio per questo, come anno «intensamente eucaristico»6
e così abbiamo cercato di viverlo. Al tempo stesso, come poteva
mancare, accanto al ricordo della nascita del Figlio, quello della
Madre? Maria è stata presente nella celebrazione giubilare non solo
attraverso opportuni e qualificati Convegni, ma soprattutto attraverso
il grande Atto di affidamento con cui, affiancato da buona parte
dell'Episcopato mondiale, ho consegnato alla sua premura materna la vita
degli uomini e delle donne del nuovo millennio.
La dimensione ecumenica
12. Si comprenderà che mi sia spontaneo
parlare soprattutto del Giubileo visto dalla Sede di Pietro. Non
dimentico tuttavia di aver voluto io stesso che la sua celebrazione
avesse luogo a pieno titolo anche nelle Chiese particolari, ed è lì
che la maggior parte dei fedeli ha potuto ottenere le grazie speciali e,
in particolare, l'indulgenza legata all'Anno giubilare. Resta comunque
significativo che numerose Diocesi abbiano sentito il desiderio di
rendersi presenti, con vasti gruppi di fedeli, anche qui a Roma. La Città
eterna ha così manifestato ancora una volta il suo ruolo provvidenziale
di luogo in cui le ricchezze e i doni di ogni singola Chiesa, ed anzi di
ogni singola nazione e cultura, si armonizzano nella « cattolicità »,
perché l'unica Chiesa di Cristo manifesti in modo sempre più eloquente
il suo mistero di sacramento di unità.7
Un'attenzione speciale avevo anche
chiesto che si riservasse nel programma dell'Anno giubilare alla
dimensione ecumenica. Quale occasione più propizia, per
incoraggiare il cammino verso la piena comunione, che la comune
celebrazione della nascita di Cristo? Molti sforzi sono stati compiuti a
tale scopo, e rimane luminoso l'incontro ecumenico nella Basilica di san
Paolo, il 18 gennaio 2000, quando per la prima volta nella storia una
Porta Santa è stata aperta congiuntamente dal Successore di Pietro,
dal Primate Anglicano e da un Metropolita del Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli, alla presenza di rappresentanti di Chiese e Comunità
ecclesiali di tutto il mondo. In questa linea sono andati anche alcuni
importanti incontri con Patriarchi ortodossi e Capi di altre Confessioni
cristiane. Ricordo, in particolare, la recente visita di S.S. Karekin II,
Patriarca Supremo e Catholicos di tutti gli Armeni. Inoltre tanti fedeli
di altre Chiese e Comunità ecclesiali hanno partecipato agli incontri
giubilari delle singole categorie. Il cammino ecumenico resta certo
faticoso, forse lungo, ma ci anima la speranza di essere guidati dalla
presenza del Risorto e dalla forza inesauribile del suo Spirito, capace
di sorprese sempre nuove.
Il pellegrinaggio in Terra Santa
13. E come poi non ricordare il mio
personale Giubileo sulle strade della Terra Santa? Avrei desiderato
iniziarlo ad Ur dei Caldei, per mettermi quasi sensibilmente sulle orme
di Abramo «nostro padre nella fede» (cfr Rm 4,11-16). Dovetti
invece accontentarmi di una tappa solo spirituale, con la suggestiva «
Liturgia della Parola » celebrata il 23 febbraio nell'Aula Paolo VI.
Venne subito dopo il pellegrinaggio vero e proprio, seguendo
l'itinerario della storia della salvezza. Ebbi così la gioia di sostare
al Monte Sinai, nello scenario del dono del Decalogo e della prima
Alleanza. Ripresi un mese più tardi il cammino, toccando il Monte Nebo
e recandomi poi negli stessi luoghi abitati e santificati dal Redentore.
È difficile esprimere la commozione che ho provato nel poter venerare i
luoghi della nascita e della vita di Cristo, a Betlemme e a Nazareth,
nel celebrare l'Eucaristia nel Cenacolo, nello stesso luogo della sua
istituzione, nel rimeditare il mistero della Croce sul Golgotha, dove
Egli ha dato la vita per noi. In quei luoghi, ancora tanto travagliati e
anche recentemente funestati dalla violenza, ho potuto sperimentare
un'accoglienza straordinaria non soltanto da parte dei figli della
Chiesa, ma anche da parte delle comunità israeliana e palestinese.
Intensa è stata poi la mia emozione nella preghiera presso il Muro del
Pianto e nella visita al Mausoleo di Yad Vashem, ricordo agghiacciante
delle vittime dei campi di sterminio nazisti. Quel pellegrinaggio è
stato un momento di fraternità e di pace, che mi piace raccogliere come
uno dei più bei doni dell'evento giubilare. Ripensando al clima vissuto
in quei giorni, non posso non esprimere l'augurio sentito di una
sollecita e giusta soluzione dei problemi ancora aperti in quei luoghi
santi, congiuntamente cari agli ebrei, ai cristiani e ai musulmani.
Il debito internazionale
14. Il Giubileo è stato anche — e non
poteva essere diversamente — un grande evento di carità. Fin dagli
anni preparatori, avevo fatto appello ad una maggiore e più operosa
attenzione ai problemi della povertà che ancora travagliano il mondo.
Un particolare significato ha assunto, in questo scenario, il problema
del debito internazionale dei Paesi poveri. Nei confronti di
questi ultimi, un gesto di generosità era nella logica stessa del
Giubileo, che nella sua originaria configurazione biblica era appunto il
tempo in cui la comunità si impegnava a ristabilire giustizia e
solidarietà nei rapporti tra le persone, restituendo anche i beni
materiali sottratti. Sono lieto di osservare che recentemente i
Parlamenti di molti degli Stati creditori hanno votato un sostanziale
condono del debito bilaterale a carico dei Paesi più poveri e
indebitati. Faccio voti che i rispettivi Governi diano compimento, in
tempi brevi, a queste decisioni parlamentari. Piuttosto problematica si
è rivelata invece la questione del debito multilaterale, contratto dai
Paesi più poveri con gli Organismi finanziari internazionali. C'è da
augurarsi che gli Stati membri di tali Organizzazioni, soprattutto
quelli che hanno un maggiore peso decisionale, riescano a trovare i
necessari consensi per arrivare alla rapida soluzione di una questione,
da cui dipende il cammino di sviluppo di molti Paesi, con pesanti
conseguenze per la condizione economica ed esistenziale di tante
persone.
Un dinamismo nuovo
15. Sono, queste, soltanto alcune delle
linee emergenti dall'esperienza giubilare. Essa lascia impressi in noi
tanti ricordi. Ma se volessimo ricondurre al nucleo essenziale la grande
eredità che essa ci consegna, non esiterei ad individuarlo nella
contemplazione del volto di Cristo: lui considerato nei suoi
lineamenti storici e nel suo mistero, accolto nella sua molteplice
presenza nella Chiesa e nel mondo, confessato come senso della storia e
luce del nostro cammino.
Ora dobbiamo guardare avanti, dobbiamo «
prendere il largo », fiduciosi nella parola di Cristo: Duc in altum!
Ciò che abbiamo fatto quest'anno non può giustificare una
sensazione di appagamento ed ancor meno indurci ad un atteggiamento di
disimpegno. Al contrario, le esperienze vissute devono suscitare in
noi un dinamismo nuovo, spingendoci ad investire l'entusiasmo
provato in iniziative concrete. Gesù stesso ci ammonisce: « Nessuno
che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il
regno di Dio » (Lc 9,62). Nella causa del Regno non c'è tempo
per guardare indietro, tanto meno per adagiarsi nella pigrizia. Molto ci
attende, e dobbiamo per questo porre mano ad un'efficace programmazione
pastorale post-giubilare.
È tuttavia importante che quanto ci
proporremo, con l'aiuto di Dio, sia profondamente radicato nella
contemplazione e nella preghiera. Il nostro è tempo di continuo
movimento che giunge spesso fino all'agitazione, col facile rischio del
« fare per fare ». Dobbiamo resistere a questa tentazione, cercando di
« essere » prima che di « fare ». Ricordiamo a questo proposito il
rimprovero di Gesù a Marta: « Tu ti preoccupi e ti agiti per molte
cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno » (Lc 10,41-42).
In questo spirito, prima di proporre alla vostra considerazione alcune
linee operative, desidero parteciparvi qualche spunto di meditazione sul
mistero di Cristo, fondamento assoluto di ogni nostra azione pastorale.
II
UN VOLTO DA CONTEMPLARE
16. « Vogliamo vedere Gesù » (Gv 12,21).
Questa richiesta, fatta all'apostolo Filippo da alcuni Greci che si
erano recati a Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, è
riecheggiata spiritualmente anche alle nostre orecchie in questo Anno
giubilare. Come quei pellegrini di duemila anni fa, gli uomini del
nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti di
oggi non solo di « parlare » di Cristo, ma in certo senso di farlo
loro « vedere ». E non è forse compito della Chiesa riflettere la
luce di Cristo in ogni epoca della storia, farne risplendere il volto
anche davanti alle generazioni del nuovo millennio?
La nostra testimonianza sarebbe,
tuttavia, insopportabilmente povera, se noi per primi non fossimo contemplatori
del suo volto. Il Grande Giubileo ci ha sicuramente aiutati ad
esserlo più profondamente. A conclusione del Giubileo, mentre
riprendiamo il cammino ordinario, portando nell'animo la ricchezza delle
esperienze vissute in questo periodo specialissimo, lo sguardo resta più
che mai fisso sul volto del Signore.
La testimonianza dei Vangeli
17. E la contemplazione del volto di
Cristo non può che ispirarsi a quanto di Lui ci dice la Sacra
Scrittura, che è, da capo a fondo, attraversata dal suo mistero,
oscuramente additato nell'Antico Testamento, pienamente rivelato nel
Nuovo, al punto che san Girolamo sentenzia con vigore: «L'ignoranza
delle Scritture è ignoranza di Cristo stesso».8 Restando
ancorati alla Scrittura, ci apriamo all'azione dello Spirito (cfr
Gv 15,26), che è all'origine di quegli scritti, e insieme alla testimonianza
degli Apostoli (cfr ibid., 27), che hanno fatto esperienza
viva di Cristo, il Verbo della vita, lo hanno visto con i loro occhi,
udito con le loro orecchie, toccato con le loro mani (cfr 1 Gv 1,1).
Quella che ci giunge per loro tramite è
una visione di fede, suffragata da una precisa testimonianza storica:
una testimonianza veritiera, che i Vangeli, pur nella loro complessa
redazione e con un'intenzionalità primariamente catechetica, ci
consegnano in modo pienamente attendibile.9
18. I Vangeli in realtà non pretendono
di essere una biografia completa di Gesù secondo i canoni della moderna
scienza storica. Da essi tuttavia il volto del Nazareno emerge con
sicuro fondamento storico, giacché gli Evangelisti si preoccuparono
di delinearlo raccogliendo testimonianze affidabili (cfr Lc 1,3)
e lavorando su documenti sottoposti al vigile discernimento ecclesiale.
Fu sulla base di queste testimonianze della prima ora che essi, sotto
l'azione illuminante dello Spirito Santo, appresero il dato umanamente
sconcertante della nascita verginale di Gesù da Maria, sposa di
Giuseppe. Da chi lo aveva conosciuto durante i circa trent'anni da lui
trascorsi a Nazareth (cfr Lc 3,23), raccolsero i dati sulla sua
vita di « figlio del carpentiere » (Mt 13,55) e «carpentiere»
egli stesso, ben collocato nel quadro della sua parentela (cfr Mc 6,3).
Ne registrarono la religiosità, che lo spingeva a recarsi con i suoi in
pellegrinaggio annuale al tempio di Gerusalemme (cfr Lc 2,41) e
soprattutto lo rendeva abituale frequentatore della sinagoga della sua
città (cfr Lc 4,16).
Le notizie si fanno poi più ampie, pur
senza essere un resoconto organico e dettagliato, per il periodo del
ministero pubblico, a partire dal momento in cui il giovane Galileo si
fa battezzare da Giovanni Battista al Giordano, e forte della
testimonianza dall'alto, con la consapevolezza di essere il « figlio
prediletto » (Lc 3,22), inizia la sua predicazione dell'avvento
del Regno di Dio, illustrandone le esigenze e la potenza attraverso
parole e segni di grazia e misericordia. I Vangeli ce lo presentano così
in cammino per città e villaggi, accompagnato da dodici Apostoli da lui
scelti (cfr Mc 3,13-19), da un gruppo di donne che li assistono (cfr
Lc 8,2-3), da folle che lo cercano o lo seguono, da malati che ne
invocano la potenza guaritrice, da interlocutori che ne ascoltano, con
vario profitto, le parole.
La narrazione dei Vangeli converge poi
nel mostrare la crescente tensione che si verifica tra Gesù e i gruppi
emergenti della società religiosa del suo tempo, fino alla crisi
finale, che ha il suo drammatico epilogo sul Golgotha. È l'ora delle
tenebre, a cui segue una nuova, radiosa e definitiva aurora. I racconti
evangelici si chiudono infatti mostrando il Nazareno vittorioso sulla
morte, ne additano la tomba vuota e lo seguono nel ciclo delle
apparizioni, nelle quali i discepoli, prima perplessi e attoniti, poi
colmi di indicibile gioia, lo sperimentano vivente e radioso, e da lui
ricevono il dono dello Spirito (cfr Gv 20,22) e il mandato di
annunciare il Vangelo a « tutte le nazioni » (Mt 28,19).
La via della fede
19. « E i discepoli gioirono al vedere
il Signore » (Gv 20,20). Il volto che gli Apostoli contemplarono
dopo la risurrezione era lo stesso di quel Gesù col quale avevano
vissuto circa tre anni, e che ora li convinceva della verità
strabiliante della sua nuova vita mostrando loro « le mani e il costato
» (ibid.). Certo, non fu facile credere. I discepoli di Emmaus
credettero solo dopo un faticoso itinerario dello spirito (cfr Lc 24,13-35).
L'apostolo Tommaso credette solo dopo aver constatato il prodigio (cfr Gv
20,24-29). In realtà, per quanto si vedesse e si toccasse il suo
corpo, solo la fede poteva varcare pienamente il mistero di quel
volto. Era, questa, un'esperienza che i discepoli dovevano aver
fatto già nella vita storica di Cristo, negli interrogativi che
affioravano alla loro mente ogni volta che si sentivano interpellati dai
suoi gesti e dalle sue parole. A Gesù non si arriva davvero che per la
via della fede, attraverso un cammino di cui il Vangelo stesso sembra
delinearci le tappe nella ben nota scena di Cesarea di Filippo (cfr Mt
16,13-20). Ai discepoli, quasi facendo una sorta di primo bilancio
della sua missione, Gesù chiede che cosa la « gente » pensi di lui,
ricevendone come risposta: « Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia,
altri Geremia o uno dei profeti » (Mt 16,14). Risposta
sicuramente elevata, ma distante ancora — e quanto! — dalla verità.
Il popolo arriva a intravedere la dimensione religiosa decisamente
eccezionale di questo rabbì che parla in modo così
affascinante, ma non riesce a collocarlo oltre quegli uomini di Dio che
hanno scandito la storia di Israele. Gesù, in realtà, è ben altro! È
appunto questo passo ulteriore di conoscenza, che riguarda il livello
profondo della sua persona, quello che Egli si aspetta dai «suoi»: «Voi
chi dite che io sia?» (Mt 16,15). Solo la fede professata da
Pietro, e con lui dalla Chiesa di tutti i tempi, va al cuore,
raggiungendo la profondità del mistero: «Tu sei il Cristo, il figlio
del Dio vivente» (Mt 16,16).
20. Com'era arrivato Pietro a questa
fede? E che cosa viene chiesto a noi, se vogliamo metterci in maniera
sempre più convinta sulle sue orme? Matteo ci dà una indicazione
illuminante nelle parole con cui Gesù accoglie la confessione di
Pietro: « Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre
mio che sta nei cieli » (16,17). L'espressione « carne e sangue »
evoca l'uomo e il modo comune di conoscere. Questo modo comune, nel caso
di Gesù, non basta. È necessaria una grazia di « rivelazione » che
viene dal Padre (cfr ibid.). Luca ci offre un'indicazione che va
nella stessa direzione, quando annota che questo dialogo con i discepoli
si svolse « mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare »
(Lc 9,18). Ambedue le indicazioni convergono nel farci prendere
coscienza del fatto che alla contemplazione piena del volto del Signore
non arriviamo con le sole nostre forze, ma lasciandoci prendere per mano
dalla grazia. Solo l'esperienza del silenzio e della preghiera offre
l'orizzonte adeguato in cui può maturare e svilupparsi la conoscenza più
vera, aderente e coerente, di quel mistero, che ha la sua espressione
culminante nella solenne proclamazione dell'evangelista Giovanni: « E
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo
la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di
verità » (Gv 1,14).
La profondità del mistero
21. Il Verbo e la carne, la gloria divina
e la sua tenda tra gli uomini! È nell'unione intima e indissociabile
di queste due polarità che sta l'identità di Cristo, secondo la
formulazione classica del Concilio di Calcedonia (a. 451): « una
persona in due nature ». La persona è quella, e solo quella, del Verbo
eterno, figlio del Padre. Le due nature, senza confusione alcuna, ma
anche senza alcuna possibile separazione, sono quella divina e quella
umana.10
Siamo consapevoli della limitatezza dei
nostri concetti e delle nostre parole. La formula, pur sempre umana, è
tuttavia attentamente calibrata nel suo contenuto dottrinale e ci
consente di affacciarci, in qualche modo, sull'abisso del mistero. Sì,
Gesù è vero Dio e vero uomo! Come l'apostolo Tommaso, la Chiesa è
continuamente invitata da Cristo a toccare le sue piaghe, a riconoscerne
cioè la piena umanità assunta da Maria, consegnata alla morte,
trasfigurata dalla risurrezione: « Metti qua il tuo dito e guarda le
mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato » (Gv 20,27).
Come Tommaso la Chiesa si prostra adorante davanti al Risorto, nella
pienezza del suo splendore divino, e perennemente esclama: « Mio
Signore e mio Dio! » (Gv 20,28).
22. « Il Verbo si è fatto carne » (Gv
1,14). Questa folgorante presentazione giovannea del mistero di
Cristo è confermata da tutto il Nuovo Testamento. In questa linea si
pone anche l'apostolo Paolo quando afferma che il Figlio di Dio è «
nato dalla stirpe di Davide secondo la carne » (Rm 1,3; cfr
9,5). Se oggi, col razionalismo che serpeggia in tanta parte della
cultura contemporanea, è soprattutto la fede nella divinità di Cristo
che fa problema, in altri contesti storici e culturali ci fu piuttosto
la tendenza a sminuire o dissolvere la concretezza storica dell'umanità
di Gesù. Ma per la fede della Chiesa è essenziale e irrinunciabile
affermare che davvero il Verbo « si è fatto carne » ed ha assunto tutte
le dimensioni dell'umano, tranne il peccato (cfr Eb 4,15). In
questa prospettiva, l'Incarnazione è veramente una kenosi, uno
« spogliarsi », da parte del Figlio di Dio, di quella gloria che egli
possiede dall'eternità (cfr Fil 2,6-8; 1 Pt 3,18).
D'altra parte, questo abbassamento del
Figlio di Dio non è fine a se stesso; tende piuttosto alla piena
glorificazione di Cristo, anche nella sua umanità: « Per questo Dio
l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro
nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli,
sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre » (Fil 2,9-11).
23. « Il tuo volto, Signore, io cerco »
(Sal 27[26], 8). L'antico anelito del Salmista non poteva
ricevere esaudimento più grande e sorprendente che nella contemplazione
del volto di Cristo. In lui veramente Dio ci ha benedetti, e ha fatto «
splendere il suo volto » sopra di noi (cfr Sal 67[66], 3). Al
tempo stesso, Dio e uomo qual è, egli ci rivela anche il volto
autentico dell'uomo, « svela pienamente l'uomo all'uomo ».11
Gesù è « l'uomo nuovo » (Ef 4,24;
cfr Col 3,10) che chiama a partecipare alla sua vita divina
l'umanità redenta. Nel mistero dell'Incarnazione sono poste le basi per
un'antropologia che può andare oltre i propri limiti e le proprie
contraddizioni, muovendosi verso Dio stesso, anzi, verso il traguardo
della « divinizzazione », attraverso l'inserimento in Cristo dell'uomo
redento, ammesso all'intimità della vita trinitaria. Su questa
dimensione soteriologica del mistero dell'Incarnazione i Padri hanno
tanto insistito: solo perché il Figlio di Dio è diventato veramente
uomo, l'uomo può, in lui e attraverso di lui, divenire realmente figlio
di Dio.12
Volto del Figlio
24. Questa identità divino-umana emerge
con forza dai Vangeli, che ci offrono una serie di elementi grazie ai
quali possiamo introdurci in quella « zona-limite » del mistero,
rappresentata dall'auto-coscienza di Cristo. La Chiesa non dubita
che nel loro racconto gli Evangelisti, ispirati dall'Alto, abbiano colto
correttamente, nelle parole pronunciate da Gesù, la verità della sua
persona e della coscienza che egli ne aveva. Non è forse questo che ci
vuol dire Luca, raccogliendo le prime parole di Gesù, appena dodicenne,
nel tempio di Gerusalemme? Egli appare già allora consapevole di essere
in una relazione unica con Dio, quale è quella propria del « figlio ».
Alla Madre, infatti, che gli fa notare l'angoscia con cui lei e Giuseppe
lo hanno cercato, Gesù risponde senza esitazione: « Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
» (Lc 2,49). Non meraviglia dunque che, nella maturità, il suo
linguaggio esprima decisamente la profondità del suo mistero, come è
abbondantemente sottolineato sia dai Vangeli sinottici (cfr Mt 11,27;
Lc 10,22), sia soprattutto dall'evangelista Giovanni. Nella sua
auto-coscienza Gesù non ha alcun dubbio: « Il Padre è in me e io nel
Padre » (Gv 10,38).
Per quanto sia lecito ritenere che, per
la condizione umana che lo faceva crescere « in sapienza, età e grazia
» (Lc 2,52), anche la coscienza umana del suo mistero
progredisse fino all'espressione piena della sua umanità glorificata,
non c'è dubbio che già nella sua esistenza storica Gesù avesse
consapevolezza della sua identità di Figlio di Dio. Giovanni lo
sottolinea fino ad affermare che fu, in definitiva, per questo, che
venne respinto e condannato: cercavano infatti di ucciderlo « perché
non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi
uguale a Dio » (Gv 5,18). Nello scenario del Getsemani e del
Golgotha, la coscienza umana di Gesù sarà sottoposta alla prova più
dura. Ma nemmeno il dramma della passione e morte riuscirà a intaccare
la sua serena certezza di essere il Figlio del Padre celeste.
Volto dolente
25. La contemplazione del volto di Cristo
ci conduce così ad accostare l'aspetto più paradossale del suo
mistero, quale emerge nell'ora estrema, l'ora della Croce. Mistero
nel mistero, davanti al quale l'essere umano non può che prostrarsi in
adorazione.
Passa davanti al nostro sguardo
l'intensità della scena dell'agonia nell'orto degli Ulivi. Gesù,
oppresso dalla previsione della prova che lo attende, solo davanti a
Dio, lo invoca con la sua abituale e tenera espressione di confidenza:
« Abbà, Padre ». Gli chiede di allontanare da lui, se possibile, il
calice della sofferenza (cfr Mc 14,36). Ma il Padre sembra non
voler ascoltare la voce del Figlio. Per riportare all'uomo il volto del
Padre, Gesù ha dovuto non soltanto assumere il volto dell'uomo, ma
caricarsi persino del « volto » del peccato. « Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché
noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio » (2 Cor 5,21).
Non finiremo mai di indagare l'abisso di
questo mistero. È tutta l'asprezza di questo paradosso che emerge nel
grido di dolore, apparentemente disperato, che Gesù leva sulla croce:
« Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato? » (Mc 15,34). È possibile
immaginare uno strazio più grande, un'oscurità più densa? In realtà,
l'angoscioso «perché» rivolto al Padre con le parole iniziali del
Salmo 22, pur conservando tutto il realismo di un indicibile dolore,
si illumina con il senso dell'intera preghiera, in cui il Salmista
unisce insieme, in un intreccio toccante di sentimenti, la sofferenza e
la confidenza. Continua infatti il Salmo: « In te hanno sperato i
nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati [...] Da me non stare
lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta » (22[21],
5.12).
26. Il grido di Gesù sulla croce,
carissimi Fratelli e Sorelle, non tradisce l'angoscia di un disperato,
ma la preghiera del Figlio che offre la sua vita al Padre nell'amore,
per la salvezza di tutti. Mentre si identifica col nostro peccato, «
abbandonato » dal Padre, egli si « abbandona » nelle mani del Padre.
I suoi occhi restano fissi sul Padre. Proprio per la conoscenza e
l'esperienza che solo lui ha di Dio, anche in questo momento di oscurità
egli vede limpidamente la gravità del peccato e soffre per esso. Solo
lui, che vede il Padre e ne gioisce pienamente, misura fino in fondo che
cosa significhi resistere col peccato al suo amore. Prima ancora, e ben
più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima. La
tradizione teologica non ha evitato di chiedersi come potesse, Gesù,
vivere insieme l'unione profonda col Padre, di sua natura fonte di gioia
e di beatitudine, e l'agonia fino al grido dell'abbandono. La
compresenza di queste due dimensioni apparentemente inconciliabili è in
realtà radicata nella profondità insondabile dell'unione ipostatica.
27. Di fronte a questo mistero, accanto
all'indagine teologica, un aiuto rilevante può venirci da quel grande
patrimonio che è la « teologia vissuta » dei Santi. Essi ci
offrono indicazioni preziose che consentono di accogliere più
facilmente l'intuizione della fede, e ciò in forza delle particolari
luci che alcuni di essi hanno ricevuto dallo Spirito Santo, o persino
attraverso l'esperienza che essi stessi hanno fatto di quegli stati
terribili di prova che la tradizione mistica descrive come « notte
oscura ». Non rare volte i Santi hanno vissuto qualcosa di simile
all'esperienza di Gesù sulla croce nel paradossale intreccio di
beatitudine e di dolore. Nel Dialogo della Divina Provvidenza Dio
Padre mostra a Caterina da Siena come nelle anime sante possa
essere presente la gioia insieme alla sofferenza: « E l'anima se ne sta
beata e dolente: dolente per i peccati del prossimo, beata per l'unione
e per l'affetto della carità che ha ricevuto in se stessa. Costoro
imitano l'immacolato Agnello, l'Unigenito Figlio mio, il quale stando
sulla croce era beato e dolente ».13 Allo stesso modo Teresa
di Lisieux vive la sua agonia in comunione con quella di Gesù,
verificando in se stessa proprio il paradosso di Gesù beato e
angosciato: « Nostro Signore nell'orto degli Ulivi godeva di tutte le
gioie della Trinità, eppure la sua agonia non era meno crudele. È un
mistero, ma le assicuro che, da ciò che provo io stessa, ne capisco
qualcosa ».14 È una testimonianza illuminante! Del resto,
la stessa narrazione degli Evangelisti dà fondamento a questa
percezione ecclesiale della coscienza di Cristo, quando ricorda che, pur
nel suo abisso di dolore, egli muore implorando il perdono per i suoi
carnefici (cfr Lc 23,34) ed esprimendo al Padre il suo estremo
abbandono filiale: « Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito » (Lc
23,46).
Volto del Risorto
28. Come nel Venerdì e nel Sabato Santo,
la Chiesa continua a restare in contemplazione di questo volto
insanguinato, nel quale è nascosta la vita di Dio ed offerta la
salvezza del mondo. Ma la sua contemplazione del volto di Cristo non può
fermarsi all'immagine di lui crocifisso. Egli è il Risorto! Se
così non fosse, vana sarebbe la nostra predicazione e vana la nostra
fede (cfr 1 Cor 15,14). La risurrezione fu la risposta del Padre
alla sua obbedienza, come ricorda la Lettera agli Ebrei: « Egli nei
giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti
grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per
la sua pietà. Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che
patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti
coloro che gli obbediscono » (5, 7-9).
È a Cristo risorto che ormai la Chiesa
guarda. Lo fa ponendosi sulle orme di Pietro, che versò lacrime per il
suo rinnegamento, e riprese il suo cammino confessando a Cristo, con
comprensibile trepidazione, il suo amore: « Tu sai che io ti amo » (Gv
21,15.17). Lo fa accompagnandosi a Paolo, che lo incontrò sulla via
di Damasco e ne restò folgorato: « Per me il vivere è Cristo, e il
morire un guadagno » (Fil 1,21).
A duemila anni di distanza da questi
eventi, la Chiesa li rivive come se fossero accaduti oggi. Nel volto di
Cristo essa, la Sposa, contempla il suo tesoro, la sua gioia. « Dulcis
Iesu memoria, dans vera cordis gaudia »: quanto è dolce il ricordo
di Gesù, fonte di vera gioia del cuore! Confortata da questa
esperienza, la Chiesa riprende oggi il suo cammino, per annunciare
Cristo al mondo, all'inizio del terzo millennio: Egli « è lo stesso
ieri, oggi e sempre » (Eb 13,8).
III
RIPARTIRE DA CRISTO
29. « Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 28,20). Questa certezza,
carissimi Fratelli e Sorelle, ha accompagnato la Chiesa per due
millenni, ed è stata ora ravvivata nei nostri cuori dalla celebrazione
del Giubileo. Da essa dobbiamo attingere un rinnovato slancio nella
vita cristiana, facendone anzi la forza ispiratrice del nostro
cammino. È nella consapevolezza di questa presenza tra noi del Risorto
che ci poniamo oggi la domanda rivolta a Pietro a Gerusalemme, subito
dopo il suo discorso di Pentecoste: « Che cosa dobbiamo fare? » (At
2,37).
Ci interroghiamo con fiducioso ottimismo,
pur senza sottovalutare i problemi. Non ci seduce certo la prospettiva
ingenua che, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci
una formula magica. No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e
la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!
Non si tratta, allora, di inventare un «
nuovo programma ». Il programma c'è già: è quello di sempre,
raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in
ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per
vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino
al suo compimento nella Gerusalemme celeste. È un programma che non
cambia col variare dei tempi e delle culture, anche se del tempo e della
cultura tiene conto per un dialogo vero e una comunicazione efficace.
Questo programma di sempre è il nostro per il terzo millennio.
È necessario tuttavia che esso si
traduca in orientamenti pastorali adatti alle condizioni di ciascuna
comunità. Il Giubileo ci ha offerto l'opportunità straordinaria di
impegnarci, per alcuni anni, in un cammino unitario di tutta la Chiesa,
un cammino di catechesi articolata sul tema trinitario e accompagnata da
specifici impegni pastorali finalizzati a una feconda esperienza
giubilare. Ringrazio per l'adesione cordiale con cui è stata ampiamente
accolta la proposta da me fatta nella Lettera apostolica Tertio
millennio adveniente. Ora non è più un traguardo immediato che si
delinea davanti a noi, ma il più grande e impegnativo orizzonte della
pastorale ordinaria. Dentro le coordinate universali e irrinunciabili,
è necessario che l'unico programma del Vangelo continui a calarsi, come
da sempre avviene, nella storia di ciascuna realtà ecclesiale. È nelle
Chiese locali che si possono stabilire quei tratti programmatici
concreti — obiettivi e metodi di lavoro, formazione e valorizzazione
degli operatori, ricerca dei mezzi necessari — che consentono
all'annuncio di Cristo di raggiungere le persone, plasmare le comunità,
incidere in profondità mediante la testimonianza dei valori evangelici
nella società e nella cultura.
Esorto, perciò, vivamente i Pastori
delle Chiese particolari, aiutati dalla partecipazione delle diverse
componenti del Popolo di Dio, a delineare con fiducia le tappe del
cammino futuro, sintonizzando le scelte di ciascuna Comunità diocesana
con quelle delle Chiese limitrofe e con quelle della Chiesa universale.
Tale sintonia sarà certamente facilitata
dal lavoro collegiale, ormai divenuto abituale, che viene svolto dai
Vescovi nelle Conferenze episcopali e nei Sinodi. Non è forse stato
questo anche il senso delle Assemblee continentali del Sinodo dei
Vescovi, che hanno scandito la preparazione al Giubileo, elaborando
linee significative per l'odierno annuncio del Vangelo nei molteplici
contesti e nelle diverse culture? Questo ricco patrimonio di riflessione
non deve essere lasciato cadere, ma reso concretamente operativo.
È dunque un'entusiasmante opera di
ripresa pastorale che ci attende. Un'opera che ci coinvolge tutti.
Desidero tuttavia additare, a comune edificazione ed orientamento, alcune
priorità pastorali, che l'esperienza stessa del Grande Giubileo ha
fatto emergere con particolare forza al mio sguardo.
La santità
30. E in primo luogo non esito a dire che
la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella
della santità. Non era forse questo il senso ultimo
dell'indulgenza giubilare, quale grazia speciale offerta da Cristo perché
la vita di ciascun battezzato potesse purificarsi e rinnovarsi
profondamente?
Mi auguro che, tra coloro che hanno
partecipato al Giubileo, siano stati tanti a godere di tale grazia, con
piena coscienza del suo carattere esigente. Finito il Giubileo,
ricomincia il cammino ordinario, ma additare la santità resta più che
mai un'urgenza della pastorale.
Occorre allora riscoprire, in tutto il
suo valore programmatico, il capitolo V della Costituzione dogmatica
sulla Chiesa Lumen gentium, dedicato alla « vocazione universale
alla santità ». Se i Padri conciliari diedero a questa tematica tanto
risalto, non fu per conferire una sorta di tocco spirituale
all'ecclesiologia, ma piuttosto per farne emergere una dinamica
intrinseca e qualificante. La riscoperta della Chiesa come « mistero »,
ossia come popolo « adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello
Spirito »,15 non poteva non comportare anche la riscoperta
della sua « santità », intesa nel senso fondamentale
dell'appartenenza a Colui che è per antonomasia il Santo, il « tre
volte Santo » (cfr Is 6,3). Professare la Chiesa come santa
significa additare il suo volto di Sposa di Cristo, per la quale
egli si è donato, proprio al fine di santificarla (cfr Ef 5,25-26).
Questo dono di santità, per così dire, oggettiva, è offerto a ciascun
battezzato.
Ma il dono si traduce a sua volta in un
compito, che deve governare l'intera esistenza cristiana: «Questa è la
volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3). È un
impegno che non riguarda solo alcuni cristiani: «Tutti i fedeli di
qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana
e alla perfezione della carità».16
31. Ricordare questa elementare verità,
ponendola a fondamento della programmazione pastorale che ci vede
impegnati all'inizio del nuovo millennio, potrebbe sembrare, di primo
acchito, qualcosa di scarsamente operativo. Si può forse « programmare
» la santità? Che cosa può significare questa parola, nella logica di
un piano pastorale?
In realtà, porre la programmazione
pastorale nel segno della santità è una scelta gravida di conseguenze.
Significa esprimere la convinzione che, se il Battesimo è un vero
ingresso nella santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione
del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita
mediocre, vissuta all'insegna di un'etica minimalistica e di una
religiosità superficiale. Chiedere a un catecumeno: « Vuoi ricevere il
Battesimo? » significa al tempo stesso chiedergli: « Vuoi diventare
santo? ». Significa porre sulla sua strada il radicalismo del discorso
della Montagna: « Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste » (Mt 5,48).
Come il Concilio stesso ha spiegato,
questo ideale di perfezione non va equivocato come se implicasse una
sorta di vita straordinaria, praticabile solo da alcuni « geni » della
santità. Le vie della santità sono molteplici, e adatte alla vocazione
di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di beatificare e
canonizzare, in questi anni, tanti cristiani, e tra loro molti laici che
si sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita. È ora
di riproporre a tutti con convinzione questa « misura alta » della
vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e
delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione. È però
anche evidente che i percorsi della santità sono personali, ed esigono
una vera e propria pedagogia della santità, che sia capace di
adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà integrare le
ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di
aiuto personale e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle
associazioni e nei movimenti riconosciuti dalla Chiesa.
La preghiera
32. Per questa pedagogia della santità
c'è bisogno di un cristianesimo che si distingua innanzitutto nell'arte
della preghiera. L'Anno giubilare è stato un anno di più intensa
preghiera, personale e comunitaria. Ma sappiamo bene che anche la
preghiera non va data per scontata. È necessario imparare a pregare,
quasi apprendendo sempre nuovamente quest'arte dalle labbra stesse del
Maestro divino, come i primi discepoli: « Signore, insegnaci a pregare!
» (Lc 11,1). Nella preghiera si sviluppa quel dialogo con Cristo
che ci rende suoi intimi: « Rimanete in me e io in voi » (Gv 15,4).
Questa reciprocità è la sostanza stessa, l'anima della vita cristiana
ed è condizione di ogni autentica vita pastorale. Realizzata in noi
dallo Spirito Santo, essa ci apre, attraverso Cristo ed in Cristo, alla
contemplazione del volto del Padre. Imparare questa logica trinitaria
della preghiera cristiana, vivendola pienamente innanzitutto nella
liturgia, culmine e fonte della vita ecclesiale,17 ma anche
nell'esperienza personale, è il segreto di un cristianesimo veramente
vitale, che non ha motivo di temere il futuro, perché continuamente
torna alle sorgenti e in esse si rigenera.
33. E non è forse un « segno dei tempi
» che si registri oggi, nel mondo, nonostante gli ampi processi di
secolarizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità, che in
gran parte si esprime proprio in un rinnovato bisogno di preghiera?
Anche le altre religioni, ormai ampiamente presenti nei Paesi di antica
cristianizzazione, offrono le proprie risposte a questo bisogno, e lo
fanno talvolta con modalità accattivanti. Noi che abbiamo la grazia di
credere in Cristo, rivelatore del Padre e Salvatore del mondo, abbiamo
il dovere di mostrare a quali profondità possa portare il rapporto con
lui.
La grande tradizione mistica della
Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, può dire molto a tal
proposito. Essa mostra come la preghiera possa progredire, quale vero e
proprio dialogo d'amore, fino a rendere la persona umana totalmente
posseduta dall'Amato divino, vibrante al tocco dello Spirito,
filialmente abbandonata nel cuore del Padre. Si fa allora l'esperienza
viva della promessa di Cristo: « Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui » (Gv 14,21). Si
tratta di un cammino interamente sostenuto dalla grazia, che chiede
tuttavia forte impegno spirituale e conosce anche dolorose purificazioni
(la « notte oscura »), ma approda, in diverse forme possibili,
all'indicibile gioia vissuta dai mistici come « unione sponsale ».
Come dimenticare qui, tra tante luminose testimonianze, la dottrina di
san Giovanni della Croce e di santa Teresa d'Avila?
Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, le
nostre comunità cristiane devono diventare autentiche « scuole »
di preghiera, dove l'incontro con Cristo non si esprima soltanto in
implorazione di aiuto, ma anche in rendimento di grazie, lode,
adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero
« invaghimento » del cuore. Una preghiera intensa, dunque, che
tuttavia non distoglie dall'impegno nella storia: aprendo il cuore
all'amore di Dio, lo apre anche all'amore dei fratelli, e rende capaci
di costruire la storia secondo il disegno di Dio.18
34. Certo alla preghiera sono in
particolare chiamati quei fedeli che hanno avuto il dono della vocazione
ad una vita di speciale consacrazione: questa li rende, per sua natura,
più disponibili all'esperienza contemplativa, ed è importante che essi
la coltivino con generoso impegno. Ma ci si sbaglierebbe a pensare che i
comuni cristiani si possano accontentare di una preghiera superficiale,
incapace di riempire la loro vita. Specie di fronte alle numerose prove
che il mondo d'oggi pone alla fede, essi sarebbero non solo cristiani
mediocri, ma « cristiani a rischio ». Correrebbero, infatti, il
rischio insidioso di veder progressivamente affievolita la loro fede, e
magari finirebbero per cedere al fascino di « surrogati », accogliendo
proposte religiose alternative e indulgendo persino alle forme
stravaganti della superstizione.
Occorre allora che l'educazione alla
preghiera diventi in qualche modo un punto qualificante di ogni
programmazione pastorale. Io stesso mi sono orientato a dedicare le
prossime catechesi del mercoledì alla riflessione sui Salmi,
cominciando da quelli delle Lodi, con cui la preghiera pubblica della
Chiesa ci invita a consacrare e orientare le nostre giornate. Quanto
gioverebbe che non solo nelle comunità religiose, ma anche in quelle
parrocchiali, ci si adoperasse maggiormente perché tutto il clima fosse
pervaso di preghiera. Occorrerebbe valorizzare, col debito
discernimento, le forme popolari, e soprattutto educare a quelle
liturgiche. Una giornata della comunità cristiana, in cui si coniughino
insieme i molteplici impegni pastorali e di testimonianza nel mondo con
la celebrazione eucaristica e magari con la recita di Lodi e Vespri, è
forse più « pensabile » di quanto ordinariamente non si creda.
L'esperienza di tanti gruppi cristianamente impegnati, anche a forte
componente laicale, lo dimostra.
L'Eucaristia domenicale
35. Il massimo impegno va posto dunque
nella liturgia, « il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e,
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù ».19
Nel secolo XX, specie dal Concilio in poi, molto è cresciuta la comunità
cristiana nel modo di celebrare i Sacramenti e soprattutto l'Eucaristia.
Occorre insistere in questa direzione, dando particolare rilievo all'Eucaristia
domenicale e alla stessa domenica, sentita come giorno
speciale della fede, giorno del Signore risorto e del dono dello
Spirito, vera Pasqua della settimana.20 Da duemila anni, il
tempo cristiano è scandito dalla memoria di quel « primo giorno dopo
il sabato » (Mc 16,2.9; Lc 24,1; Gv 20,1), in cui
Cristo risorto portò agli Apostoli il dono della pace e dello Spirito (cfr
Gv 20,19-23). La verità della risurrezione di Cristo è il dato
originario su cui poggia la fede cristiana (cfr 1 Cor 15,14),
evento che si colloca al centro del mistero del tempo, e
prefigura l'ultimo giorno, quando Cristo ritornerà glorioso. Non
sappiamo quali eventi ci riserverà il millennio che sta iniziando, ma
abbiamo la certezza che esso resterà saldamente nelle mani di Cristo,
il « Re dei re e Signore dei signori » (Ap 19,16), e proprio
celebrando la sua Pasqua, non solo una volta all'anno, ma ogni domenica,
la Chiesa continuerà ad additare ad ogni generazione « ciò che
costituisce l'asse portante della storia, al quale si riconducono il
mistero delle origini e quello del destino finale del mondo ».21
36. Vorrei pertanto insistere, nel solco
della Dies Domini, perché la partecipazione all'Eucaristia sia
veramente, per ogni battezzato, il cuore della domenica: un
impegno irrinunciabile, da vivere non solo per assolvere a un precetto,
ma come bisogno di una vita cristiana veramente consapevole e coerente.
Stiamo entrando in un millennio che si prefigura caratterizzato da un
profondo intreccio di culture e religioni anche nei Paesi di antica
cristianizzazione. In molte regioni i cristiani sono, o stanno
diventando, un « piccolo gregge » (Lc 12,32). Ciò li pone di
fronte alla sfida di testimoniare con maggior forza, spesso in
condizione di solitudine e di difficoltà, gli aspetti specifici della
propria identità. Il dovere della partecipazione eucaristica ogni
domenica è uno di questi. L'Eucaristia domenicale, raccogliendo
settimanalmente i cristiani come famiglia di Dio intorno alla mensa
della Parola e del Pane di vita, è anche l'antidoto più naturale alla
dispersione. Essa è il luogo privilegiato dove la comunione è
costantemente annunciata e coltivata. Proprio attraverso la
partecipazione eucaristica, il giorno del Signore diventa anche
il giorno della Chiesa,22 che può svolgere così in
modo efficace il suo ruolo di sacramento di unità.
Il sacramento della Riconciliazione
37. Un rinnovato coraggio pastorale vengo
poi a chiedere perché la quotidiana pedagogia delle comunità cristiane
sappia proporre in modo suadente ed efficace la pratica del
sacramento della Riconciliazione. Come ricorderete, nel 1984
intervenni su questo tema con l'Esortazione post-sinodale Reconciliatio
et paenitentia, che raccoglieva i frutti di riflessione di
un'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata a questa problematica.
Invitavo allora a fare ogni sforzo per fronteggiare la crisi del «
senso del peccato » che si registra nella cultura contemporanea,23
ma più ancora invitavo a far riscoprire Cristo come mysterium
pietatis, colui nel quale Dio ci mostra il suo cuore compassionevole
e ci riconcilia pienamente a sé. È questo volto di Cristo che occorre
far riscoprire anche attraverso il sacramento della Penitenza, che è
per un cristiano « la via ordinaria per ottenere il perdono e la
remissione dei suoi peccati gravi commessi dopo il Battesimo ».24
Quando il menzionato Sinodo affrontò il problema, stava sotto gli occhi
di tutti la crisi del Sacramento, specialmente in alcune regioni del
mondo. I motivi che ne erano all'origine non sono svaniti in questo
breve arco di tempo. Ma l'Anno giubilare, che è stato particolarmente
caratterizzato dal ricorso alla Penitenza sacramentale, ci ha offerto un
messaggio incoraggiante, da non lasciar cadere: se molti, e tra essi
anche tanti giovani, si sono accostati con frutto a questo Sacramento,
probabilmente è necessario che i Pastori si armino di maggior fiducia,
creatività e perseveranza nel presentarlo e farlo valorizzare. Non
dobbiamo arrenderci, carissimi Fratelli nel sacerdozio, di fronte a
crisi temporanee! I doni del Signore — e i Sacramenti sono tra i più
preziosi — vengono da Colui che ben conosce il cuore dell'uomo ed è
il Signore della storia.
Il primato della grazia
38. Impegnarci con maggior fiducia, nella
programmazione che ci attende, ad una pastorale che dia tutto il suo
spazio alla preghiera, personale e comunitaria, significa rispettare un
principio essenziale della visione cristiana della vita: il primato
della grazia. C'è una tentazione che da sempre insidia ogni cammino
spirituale e la stessa azione pastorale: quella di pensare che i
risultati dipendano dalla nostra capacità di fare e di programmare.
Certo, Iddio ci chiede una reale collaborazione alla sua grazia, e
dunque ci invita ad investire, nel nostro servizio alla causa del Regno,
tutte le nostre risorse di intelligenza e di operatività. Ma guai a
dimenticare che « senza Cristo non possiamo far nulla » (cfr Gv 15,5).
La preghiera ci fa vivere appunto in
questa verità. Essa ci ricorda costantemente il primato di Cristo e, in
rapporto a lui, il primato della vita interiore e della santità. Quando
questo principio non è rispettato, c'è da meravigliarsi se i progetti
pastorali vanno incontro al fallimento e lasciano nell'animo un
avvilente senso di frustrazione? Facciamo allora l'esperienza dei
discepoli nell'episodio evangelico della pesca miracolosa: « Abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla » (Lc 5,5). È
quello il momento della fede, della preghiera, del dialogo con Dio, per
aprire il cuore all'onda della grazia e consentire alla parola di Cristo
di passare attraverso di noi con tutta la sua potenza: Duc in altum! Fu
Pietro, in quella pesca, a dire la parola della fede: « Sulla tua
parola getterò le reti » (ibid.). Consentite al Successore di
Pietro, in questo inizio di millennio, di invitare tutta la Chiesa a
questo atto di fede, che s'esprime in un rinnovato impegno di preghiera.
Ascolto della Parola
39. Non c'è dubbio che questo primato
della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un
rinnovato ascolto della parola di Dio. Da quando il Concilio
Vaticano II ha sottolineato il ruolo preminente della parola di Dio
nella vita della Chiesa, certamente sono stati fatti grandi passi in
avanti nell'ascolto assiduo e nella lettura attenta della Sacra
Scrittura. Ad essa si è assicurato l'onore che merita nella preghiera
pubblica della Chiesa. Ad essa i singoli e le comunità ricorrono ormai
in larga misura, e tra gli stessi laici sono tanti che vi si dedicano
anche con l'aiuto prezioso di studi teologici e biblici. Soprattutto poi
è l'opera dell'evangelizzazione e della catechesi che si sta
rivitalizzando proprio nell'attenzione alla parola di Dio. Occorre,
carissimi Fratelli e Sorelle, consolidare e approfondire questa linea,
anche mediante la diffusione nelle famiglie del libro della Bibbia. In
particolare è necessario che l'ascolto della Parola diventi un incontro
vitale, nell'antica e sempre valida tradizione della lectio divina,
che fa cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella,
orienta, plasma l'esistenza.
Annuncio della Parola
40. Nutrirci della Parola, per essere «
servi della Parola » nell'impegno dell'evangelizzazione: questa è
sicuramente una priorità per la Chiesa all'inizio del nuovo millennio.
È ormai tramontata, anche nei Paesi di antica evangelizzazione, la
situazione di una « società cristiana », che, pur tra le tante
debolezze che sempre segnano l'umano, si rifaceva esplicitamente ai
valori evangelici. Oggi si deve affrontare con coraggio una situazione
che si fa sempre più varia e impegnativa, nel contesto della
globalizzazione e del nuovo e mutevole intreccio di popoli e culture che
la caratterizza. Ho tante volte ripetuto in questi anni l'appello della nuova
evangelizzazione. Lo ribadisco ora, soprattutto per indicare che
occorre riaccendere in noi lo slancio delle origini, lasciandoci
pervadere dall'ardore della predicazione apostolica seguita alla
Pentecoste. Dobbiamo rivivere in noi il sentimento infuocato di Paolo,
il quale esclamava: « Guai a me se non predicassi il Vangelo! » (1
Cor 9,16).
Questa passione non mancherà di
suscitare nella Chiesa una nuova missionarietà, che non potrà essere
demandata ad una porzione di « specialisti », ma dovrà coinvolgere la
responsabilità di tutti i membri del Popolo di Dio. Chi ha incontrato
veramente Cristo, non può tenerselo per sé, deve annunciarlo. Occorre
un nuovo slancio apostolico che sia vissuto quale impegno quotidiano
delle comunità e dei gruppi cristiani. Ciò tuttavia avverrà nel
rispetto dovuto al cammino sempre diversificato di ciascuna persona e
nell'attenzione per le diverse culture in cui il messaggio cristiano
deve essere calato, così che gli specifici valori di ogni popolo non
siano rinnegati, ma purificati e portati alla loro pienezza.
Il cristianesimo del terzo millennio dovrà
rispondere sempre meglio a questa esigenza di inculturazione.
Restando pienamente se stesso, nella totale fedeltà all'annuncio
evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso porterà anche il volto
delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato.
Della bellezza di questo volto pluriforme della Chiesa abbiamo
particolarmente goduto nell'Anno giubilare. È forse solo un inizio,
un'icona appena abbozzata del futuro che lo Spirito di Dio ci prepara.
La proposta di Cristo va fatta a tutti
con fiducia. Ci si rivolgerà agli adulti, alle famiglie, ai giovani, ai
bambini, senza mai nascondere le esigenze più radicali del messaggio
evangelico, ma venendo incontro alle esigenze di ciascuno quanto a
sensibilità e linguaggio, secondo l'esempio di Paolo, il quale
affermava: « Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo
qualcuno » (1 Cor 9,22). Nel raccomandare tutto questo, penso in
particolare alla pastorale giovanile. Proprio per quanto riguarda
i giovani, come poc'anzi ho ricordato, il Giubileo ci ha offerto una
testimonianza di generosa disponibilità. Dobbiamo saper valorizzare
quella risposta consolante, investendo quell'entusiasmo come un nuovo «
talento » (cfr Mt 25,15) che il Signore ci ha messo nelle mani
perché lo facciamo fruttificare.
41. Ci sostenga ed orienti, in questa «
missionarietà » fiduciosa, intraprendente, creativa, l'esempio fulgido
dei tanti testimoni della fede che il Giubileo ci ha fatto rievocare. La
Chiesa ha trovato sempre, nei suoi martiri, un seme di vita. Sanguis
martyrum — semen christianorum:25 questa celebre «
legge » enunciata da Tertulliano, si è dimostrata sempre vera alla
prova della storia. Non sarà così anche per il secolo, per il
millennio che stiamo iniziando? Eravamo forse troppo abituati a pensare
ai martiri in termini un po' lontani, quasi si trattasse di una
categoria del passato, legata soprattutto ai primi secoli dell'era
cristiana. La memoria giubilare ci ha aperto uno scenario sorprendente,
mostrandoci il nostro tempo particolarmente ricco di testimoni, che in
un modo o nell'altro, hanno saputo vivere il Vangelo in situazioni di
ostilità e persecuzione, spesso fino a dare la prova suprema del
sangue. In loro la parola di Dio, seminata in buon terreno, ha portato
il centuplo (cfr Mt 13,8.23). Con il loro esempio ci hanno
additato e quasi spianato la strada del futuro. A noi non resta che
metterci, con la grazia di Dio, sulle loro orme.
IV
TESTIMONI DELL'AMORE
42. « Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri » (Gv 13,35).
Se abbiamo veramente contemplato il volto di Cristo, carissimi Fratelli
e Sorelle, la nostra programmazione pastorale non potrà non ispirarsi
al « comandamento nuovo » che egli ci ha dato: «Come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34).
È l'altro grande ambito in cui occorrerà
esprimere un deciso impegno programmatico, a livello di Chiesa
universale e di Chiese particolari: quello della comunione (koinonìa)
che incarna e manifesta l'essenza stessa del mistero della Chiesa. La
comunione è il frutto e la manifestazione di quell'amore che, sgorgando
dal cuore dell'eterno Padre, si riversa in noi attraverso lo Spirito che
Gesù ci dona (cfr Rm 5,5), per fare di tutti noi « un cuore
solo e un'anima sola » (At 4,32). È realizzando questa
comunione di amore che la Chiesa si manifesta come « sacramento »,
ossia «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di
tutto il genere umano».26
Le parole del Signore, a questo
proposito, sono troppo precise per poterne ridurre la portata. Tante
cose, anche nel nuovo secolo, saranno necessarie per il cammino storico
della Chiesa; ma se mancherà la carità (agape), tutto sarà
inutile. È lo stesso apostolo Paolo a ricordarcelo nell'inno alla
carità: se anche parlassimo le lingue degli uomini e degli angeli,
e avessimo una fede « da trasportare le montagne », ma poi mancassimo
della carità, tutto sarebbe « nulla » (cfr 1 Cor 13,2). La
carità è davvero il « cuore » della Chiesa, come aveva ben intuito
santa Teresa di Lisieux, che ho voluto proclamare Dottore della Chiesa
proprio come esperta della scientia amoris: «Capii che la Chiesa
aveva un Cuore e che questo Cuore era acceso d'Amore. Capii che solo
l'Amore faceva agire le membra della Chiesa [...] Capii che l'Amore
racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore era tutto».27
Una spiritualità di comunione
43. Fare della Chiesa la casa e la
scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel
millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e
rispondere anche alle attese profonde del mondo.
Che cosa significa questo in concreto?
Anche qui il discorso potrebbe farsi immediatamente operativo, ma
sarebbe sbagliato assecondare simile impulso. Prima di programmare
iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della
comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i
luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri
dell'altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono
le famiglie e le comunità. Spiritualità della comunione significa
innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che
abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci
stanno accanto. Spiritualità della comunione significa inoltre capacità
di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico,
dunque, come « uno che mi appartiene », per saper condividere le sue
gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura
dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia.
Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere innanzitutto
ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo
come dono di Dio: un « dono per me », oltre che per il fratello che lo
ha direttamente ricevuto. Spiritualità della comunione è infine saper
« fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri »
(Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche che
continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo,
diffidenza, gelosie. Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino
spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della
comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, maschere di comunione più
che sue vie di espressione e di crescita.
44. Su questa base, il nuovo secolo dovrà
vederci impegnati più che mai a valorizzare e sviluppare quegli ambiti
e strumenti che, secondo le grandi direttive del Concilio Vaticano II,
servono ad assicurare e garantire la comunione. Come non pensare,
innanzitutto, a quegli specifici servizi alla comunione che sono il
ministero petrino, e, in stretta relazione con esso, la
collegialità episcopale? Si tratta di realtà che hanno il loro
fondamento e la loro consistenza nel disegno stesso di Cristo sulla
Chiesa,28 ma proprio per questo bisognose di una continua
verifica che ne assicuri l'autentica ispirazione evangelica.
Molto si è fatto dal Concilio Vaticano
II in poi anche per quanto riguarda la riforma della Curia romana,
l'organizzazione dei Sinodi, il funzionamento delle Conferenze
episcopali. Ma certamente molto resta da fare, per esprimere al meglio
le potenzialità di questi strumenti della comunione, oggi
particolarmente necessari di fronte all'esigenza di rispondere con
prontezza ed efficacia ai problemi che la Chiesa deve affrontare nei
cambiamenti così rapidi del nostro tempo.
45. Gli spazi della comunione vanno
coltivati e dilatati giorno per giorno, ad ogni livello, nel tessuto
della vita di ciascuna Chiesa. La comunione deve qui rifulgere nei
rapporti tra Vescovi, presbiteri e diaconi, tra Pastori e intero Popolo
di Dio, tra clero e religiosi, tra associazioni e movimenti ecclesiali.
A tale scopo devono essere sempre meglio valorizzati gli organismi di
partecipazione previsti dal Diritto canonico, come i Consigli
presbiterali e pastorali. Essi, com'è noto, non si ispirano ai
criteri della democrazia parlamentare, perché operano per via
consultiva e non deliberativa;29 non per questo tuttavia
perdono di significato e di rilevanza. La teologia e la spiritualità
della comunione, infatti, ispirano un reciproco ed efficace ascolto tra
Pastori e fedeli, tenendoli, da un lato, uniti a priori in tutto
ciò che è essenziale, e spingendoli, dall'altro, a convergere
normalmente anche nell'opinabile verso scelte ponderate e condivise.
Occorre a questo scopo far nostra
l'antica sapienza che, senza portare alcun pregiudizio al ruolo
autorevole dei Pastori, sapeva incoraggiarli al più ampio ascolto di
tutto il Popolo di Dio. Significativo ciò che san Benedetto ricorda
all'Abate del monastero, nell'invitarlo a consultare anche i più
giovani: « Spesso ad uno più giovane il Signore ispira un parere
migliore ».30 E san Paolino di Nola esorta: «Pendiamo dalla
bocca di tutti i fedeli, perché in ogni fedele soffia lo Spirito di Dio».31
Se dunque la saggezza giuridica, ponendo
precise regole alla partecipazione, manifesta la struttura gerarchica
della Chiesa e scongiura tentazioni di arbitrio e pretese
ingiustificate, la spiritualità della comunione conferisce un'anima al
dato istituzionale con un'indicazione di fiducia e di apertura che
pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni membro del
Popolo di Dio.
La varietà delle vocazioni
46. Questa prospettiva di comunione è
strettamente legata alla capacità della comunità cristiana di fare
spazio a tutti i doni dello Spirito. L'unità della Chiesa non è
uniformità, ma integrazione organica delle legittime diversità. È la
realtà di molte membra congiunte in un corpo solo, l'unico Corpo di
Cristo (cfr 1 Cor 12,12). È necessario perciò che la Chiesa del
terzo millennio stimoli tutti i battezzati e cresimati a prendere
coscienza della propria attiva responsabilità nella vita ecclesiale.
Accanto al ministero ordinato, altri ministeri, istituiti o
semplicemente riconosciuti, possono fiorire a vantaggio di tutta la
comunità, sostenendola nei suoi molteplici bisogni: dalla catechesi
all'animazione liturgica, dall'educazione dei giovani alle più varie
espressioni della carità.
Certamente un impegno generoso va posto
— soprattutto con la preghiera insistente al padrone della messe (cfr Mt
9,38) — per la promozione delle vocazioni al sacerdozio e di
quelle di speciale consacrazione. È questo un problema di grande
rilevanza per la vita della Chiesa in ogni parte del mondo. In certi
Paesi di antica evangelizzazione, poi, esso si è fatto addirittura
drammatico a motivo del mutato contesto sociale e dell'inaridimento
religioso indotto dal consumismo e dal secolarismo. È necessario ed
urgente impostare una vasta e capillare pastorale delle vocazioni,
che raggiunga le parrocchie, i centri educativi, le famiglie, suscitando
una più attenta riflessione sui valori essenziali della vita, che
trovano la loro sintesi risolutiva nella risposta che ciascuno è
invitato a dare alla chiamata di Dio, specialmente quando questa
sollecita la donazione totale di sé e delle proprie energie alla causa
del Regno.
In questo contesto prende tutto il suo
rilievo anche ogni altra vocazione, radicata in definitiva nella
ricchezza della vita nuova ricevuta nel sacramento del Battesimo. In
particolare, sarà da scoprire sempre meglio la vocazione che è
propria dei laici, chiamati come tali a « cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio »32 ed
anche a svolgere « i compiti propri nella Chiesa e nel mondo [...] con
la loro azione per l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini
».33
In questa stessa linea, grande importanza
per la comunione riveste il dovere di promuovere le varie realtà
aggregative, che sia nelle forme più tradizionali, sia in quelle più
nuove dei movimenti ecclesiali, continuano a dare alla Chiesa una
vivacità che è dono di Dio e costituisce un'autentica « primavera
dello Spirito ». Occorre certo che associazioni e movimenti, tanto
nella Chiesa universale quanto nelle Chiese particolari, operino nella
piena sintonia ecclesiale e in obbedienza alle direttive autorevoli dei
Pastori. Ma torna anche per tutti, esigente e perentorio, il monito
dell'Apostolo: «Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie;
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1 Ts 5,19-21).
47. Un'attenzione speciale, poi, deve
essere assicurata alla pastorale della famiglia, tanto più
necessaria in un momento storico come il presente, che sta registrando
una crisi diffusa e radicale di questa fondamentale istituzione. Nella
visione cristiana del matrimonio, la relazione tra un uomo e una donna
— relazione reciproca e totale, unica e indissolubile — risponde al
disegno originario di Dio, offuscato nella storia dalla « durezza del
cuore », ma che Cristo è venuto a restaurare nel suo splendore
originario, svelando ciò che Dio ha voluto fin « dal principio » (Mt
19,8). Nel matrimonio, elevato alla dignità di Sacramento, è
espresso poi il « grande mistero » dell'amore sponsale di Cristo per
la sua Chiesa (cfr Ef 5,32).
Su questo punto, la Chiesa non può
cedere alle pressioni di una certa cultura, anche se diffusa e talvolta
militante. Occorre piuttosto fare in modo che, attraverso un'educazione
evangelica sempre più completa, le famiglie cristiane offrano un
esempio convincente della possibilità di un matrimonio vissuto in modo
pienamente conforme al disegno di Dio e alle vere esigenze della persona
umana: di quella dei coniugi, e soprattutto di quella più fragile dei
figli. Le famiglie stesse devono essere sempre più consapevoli
dell'attenzione dovuta ai figli e farsi soggetti attivi di un'efficace
presenza ecclesiale e sociale a tutela dei loro diritti.
L'impegno ecumenico
48. E che dire poi dell'urgenza di
promuovere la comunione nel delicato ambito dell'impegno ecumenico?
Purtroppo, le tristi eredità del passato ci seguono ancora oltre la
soglia del nuovo millennio. La celebrazione giubilare ha registrato
qualche segnale davvero profetico e commovente, ma ancora tanto cammino
rimane da fare.
In realtà, facendoci fissare lo sguardo
su Cristo, il Grande Giubileo ci ha fatto prendere più viva coscienza
della Chiesa come mistero di unità. « Credo la Chiesa una »: ciò che
esprimiamo nella professione di fede, ha il suo fondamento ultimo in
Cristo, nel quale la Chiesa non è divisa (cfr 1 Cor 1,11-13).
In quanto suo Corpo, nell'unità prodotta dal dono dello Spirito, essa
è indivisibile. La realtà della divisione si genera sul terreno della
storia, nei rapporti tra i figli della Chiesa, quale conseguenza
dell'umana fragilità nell'accogliere il dono che continuamente fluisce
dal Cristo-Capo nel Corpo mistico. La preghiera di Gesù nel Cenacolo
— « come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una
cosa sola » (Gv 17,21) — è insieme rivelazione e invocazione.
Essa ci rivela l'unità di Cristo col Padre quale luogo sorgivo
dell'unità della Chiesa e dono perenne che in lui questa,
misteriosamente, riceverà fino alla fine dei tempi. Quest'unità, che
non manca di realizzarsi concretamente nella Chiesa cattolica,
nonostante i limiti propri dell'umano, opera pure in varia misura nei
tanti elementi di santificazione e di verità che si trovano all'interno
delle altre Chiese e Comunità ecclesiali; tali elementi, come doni
propri della Chiesa di Cristo, le sospingono incessantemente verso
l'unità piena.34
La preghiera di Cristo ci ricorda che
questo dono ha bisogno di essere accolto e sviluppato in maniera sempre
più profonda. L'invocazione « ut unum sint » è, insieme,
imperativo che ci obbliga, forza che ci sostiene, salutare rimprovero
per le nostre pigrizie e ristrettezze di cuore. È sulla preghiera di
Gesù, non sulle nostre capacità, che poggia la fiducia di poter
raggiungere anche nella storia, la comunione piena e visibile di tutti i
cristiani.
In questa prospettiva di rinnovato
cammino post-giubilare, guardo con grande speranza alle Chiese
dell'Oriente, auspicando che riprenda pienamente quello scambio di
doni che ha arricchito la Chiesa del primo millennio. Il ricordo del
tempo in cui la Chiesa respirava con «due polmoni» spinga i cristiani
d'Oriente e d'Occidente a camminare insieme, nell'unità della fede e
nel rispetto delle legittime diversità, accogliendosi e sostenendosi a
vicenda come membra dell'unico Corpo di Cristo.
Con analogo impegno dev'essere coltivato
il dialogo ecumenico con i fratelli e le sorelle della Comunione
anglicana e delle Comunità ecclesiali nate dalla Riforma. Il
confronto teologico su punti essenziali della fede e della morale
cristiana, la collaborazione nella carità e, soprattutto, il grande
ecumenismo della santità, con l'aiuto di Dio non potranno nel futuro
non produrre i loro frutti. Intanto proseguiamo con fiducia nel cammino,
sospirando il momento in cui, con tutti i discepoli di Cristo, senza
eccezione, potremo cantare insieme a voce spiegata: « Ecco quanto è
buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme » (Sal 133[132],1).
Scommettere sulla carità
49. Dalla comunione intra-ecclesiale, la
carità si apre per sua natura al servizio universale, proiettandoci nell'impegno
di un amore operoso e concreto verso ogni essere umano. È un
ambito, questo, che qualifica in modo ugualmente decisivo la vita
cristiana, lo stile ecclesiale e la programmazione pastorale. Il secolo
e il millennio che si avviano dovranno ancora vedere, ed anzi è
auspicabile che lo vedano con forza maggiore, a quale grado di dedizione
sappia arrivare la carità verso i più poveri. Se siamo ripartiti
davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere
soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto
identificarsi: « Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi » (Mt 25,35-36). Questa pagina non è un semplice
invito alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta un
fascio di luce sul mistero di Cristo. Su questa pagina, non meno che sul
versante dell'ortodossia, la Chiesa misura la sua fedeltà di Sposa di
Cristo.
Certo, non va dimenticato che nessuno può
essere escluso dal nostro amore, dal momento che « con l'incarnazione
il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo ».35
Ma stando alle inequivocabili parole del Vangelo, nella persona dei
poveri c'è una sua presenza speciale, che impone alla Chiesa un'opzione
preferenziale per loro. Attraverso tale opzione, si testimonia lo stile
dell'amore di Dio, la sua provvidenza, la sua misericordia, e in qualche
modo si seminano ancora nella storia quei semi del Regno di Dio che Gesù
stesso pose nella sua vita terrena venendo incontro a quanti ricorrevano
a lui per tutte le necessità spirituali e materiali.
50. In effetti sono tanti, nel nostro
tempo, i bisogni che interpellano la sensibilità cristiana. Il nostro
mondo comincia il nuovo millennio carico delle contraddizioni di una
crescita economica, culturale, tecnologica, che offre a pochi fortunati
grandi possibilità, lasciando milioni e milioni di persone non solo ai
margini del progresso, ma alle prese con condizioni di vita ben al di
sotto del minimo dovuto alla dignità umana. È possibile che, nel
nostro tempo, ci sia ancora chi muore di fame? chi resta condannato
all'analfabetismo? chi manca delle cure mediche più elementari? chi non
ha una casa in cui ripararsi?
Lo scenario della povertà può
allargarsi indefinitamente, se aggiungiamo alle vecchie le nuove povertà,
che investono spesso anche gli ambienti e le categorie non prive di
risorse economiche, ma esposte alla disperazione del non senso,
all'insidia della droga, all'abbandono nell'età avanzata o nella
malattia, all'emarginazione o alla discriminazione sociale. Il
cristiano, che si affaccia su questo scenario, deve imparare a fare il
suo atto di fede in Cristo decifrandone l'appello che egli manda da
questo mondo della povertà. Si tratta di continuare una tradizione di
carità che ha avuto già nei due passati millenni tantissime
espressioni, ma che oggi forse richiede ancora maggiore inventiva. È
l'ora di una nuova « fantasia della carità », che si dispieghi non
tanto e non solo nell'efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità
di farsi vicini, solidali con chi soffre, così che il gesto di aiuto
sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione.
Dobbiamo per questo fare in modo che i
poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come « a casa loro ».
Non sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace presentazione
della buona novella del Regno? Senza questa forma di evangelizzazione,
compiuta attraverso la carità e la testimonianza della povertà
cristiana, l'annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia
di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui
l'odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone. La
carità delle opere assicura una forza inequivocabile alla carità
delle parole.
Le sfide odierne
51. E come poi tenerci in disparte di
fronte alle prospettive di un dissesto ecologico, che rende
inospitali e nemiche dell'uomo vaste aree del pianeta? O rispetto ai problemi
della pace, spesso minacciata con l'incubo di guerre catastrofiche?
O di fronte al vilipendio dei diritti umani fondamentali di tante
persone, specialmente dei bambini? Tante sono le urgenze, alle quali
l'animo cristiano non può restare insensibile.
Un impegno speciale deve riguardare
alcuni aspetti della radicalità evangelica che sono spesso meno
compresi, fino a rendere impopolare l'intervento della Chiesa, ma che
non possono per questo essere meno presenti nell'agenda ecclesiale della
carità. Mi riferisco al dovere di impegnarsi per il rispetto della
vita di ciascun essere umano dal concepimento fino al suo naturale
tramonto. Allo stesso modo, il servizio all'uomo ci impone di gridare,
opportunamente e importunamente, che quanti s'avvalgono delle nuove
potenzialità della scienza, specie sul terreno delle biotecnologie,
non possono mai disattendere le esigenze fondamentali dell'etica,
appellandosi magari ad una discutibile solidarietà, che finisce per
discriminare tra vita e vita, in spregio della dignità propria di ogni
essere umano.
Per l'efficacia della testimonianza
cristiana, specie in questi ambiti delicati e controversi, è importante
fare un grande sforzo per spiegare adeguatamente i motivi della
posizione della Chiesa, sottolineando soprattutto che non si tratta di
imporre ai non credenti una prospettiva di fede, ma di interpretare e
difendere i valori radicati nella natura stessa dell'essere umano. La
carità si farà allora necessariamente servizio alla cultura, alla
politica, all'economia, alla famiglia, perché dappertutto vengano
rispettati i principi fondamentali dai quali dipende il destino
dell'essere umano e il futuro della civiltà.
52. Tutto questo ovviamente dovrà essere
realizzato con uno stile specificamente cristiano: saranno soprattutto i
laici a rendersi presenti in questi compiti in adempimento della
vocazione loro propria, senza mai cedere alla tentazione di ridurre le
comunità cristiane ad agenzie sociali. In particolare, il rapporto con
la società civile dovrà configurarsi in modo da rispettare l'autonomia
e le competenze di quest'ultima, secondo gli insegnamenti proposti dalla
dottrina sociale della Chiesa.
È noto lo sforzo che il Magistero
ecclesiale ha compiuto, soprattutto nel secolo XX, per leggere la realtà
sociale alla luce del Vangelo ed offrire in modo sempre più puntuale ed
organico il proprio contributo alla soluzione della questione sociale,
divenuta ormai una questione planetaria.
Questo versante etico-sociale si propone
come dimensione imprescindibile della testimonianza cristiana: si deve
respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e
individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità,
oltre che con la logica dell'Incarnazione e, in definitiva, con la
stessa tensione escatologica del cristianesimo. Se quest'ultima ci rende
consapevoli del carattere relativo della storia, ciò non vale a
disimpegnarci in alcun modo dal dovere di costruirla. Rimane più che
mai attuale, a tal proposito, l'insegnamento del Concilio Vaticano II:
« Il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito
di edificare il mondo, lungi dall'incitarli a disinteressarsi del bene
dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo
ancora più stringente ».36
Un segno concreto
53. Per dare un segno di questo indirizzo
di carità e di promozione umana, che si radica nelle intime esigenze
del Vangelo, ho voluto che lo stesso Anno giubilare, tra i numerosi
frutti di carità che già ha prodotto nel corso del suo svolgimento —
penso, in particolare, all'aiuto offerto a tanti fratelli più poveri
per consentir loro di prendere parte al Giubileo — lasciasse anche
un'opera che costituisse, in qualche modo, il frutto e il sigillo
della carità giubilare. Molti pellegrini, infatti, hanno in diversi
modi versato il loro obolo e, insieme con loro, anche molti protagonisti
dell'attività economica hanno offerto sostegni generosi, che sono
serviti ad assicurare una conveniente realizzazione dell'evento
giubilare. Saldati i conti delle spese che è stato necessario
affrontare nel corso dell'anno, il denaro che si sarà potuto
risparmiare dovrà essere destinato a finalità caritative. È
importante infatti che da un evento religioso tanto significativo sia
allontanata ogni parvenza di speculazione economica. Ciò che
sopravanzerà servirà a ripetere anche in questa circostanza
l'esperienza vissuta tante altre volte nel corso della storia da quando,
agli inizi della Chiesa, la comunità di Gerusalemme offrì ai non
cristiani lo spettacolo commovente di uno spontaneo scambio di doni,
fino alla comunione dei beni, a favore dei più poveri (cfr At 2,44-45).
L'opera che verrà realizzata sarà
soltanto un piccolo rivolo che confluirà nel grande fiume della carità
cristiana che percorre la storia. Piccolo, ma significativo rivolo: il
Giubileo ha spinto il mondo a guardare verso Roma, la Chiesa « che
presiede alla carità »37 ed a recare a Pietro il proprio
obolo. Ora la carità manifestata nel centro della cattolicità torna,
in qualche modo, a volgersi verso il mondo attraverso questo segno, che
vuole restare come frutto e memoria viva della comunione sperimentata in
occasione del Giubileo.
Dialogo e missione
54. Un nuovo secolo, un nuovo millennio
si aprono nella luce di Cristo. Non tutti però vedono questa luce. Noi
abbiamo il compito stupendo ed esigente di esserne il « riflesso ». È
il mysterium lunae così caro alla contemplazione dei Padri, i
quali indicavano con tale immagine la dipendenza della Chiesa da Cristo,
Sole di cui essa riflette la luce.38 Era un modo per
esprimere quanto Cristo stesso dice, presentandosi come « luce del
mondo » (Gv 8,12) e chiedendo insieme ai suoi discepoli di
essere « la luce del mondo » (Mt 5,14).
È un compito, questo, che ci fa
trepidare, se guardiamo alla debolezza che ci rende tanto spesso opachi
e pieni di ombre. Ma è compito possibile, se esponendoci alla luce di
Cristo, sappiamo aprirci alla grazia che ci rende uomini nuovi.
55. È in quest'ottica che si pone anche
la grande sfida del dialogo interreligioso, nel quale il nuovo
secolo ci vedrà ancora impegnati, nella linea indicata dal Concilio
Vaticano II.39 Negli anni che hanno preparato il Grande
Giubileo la Chiesa ha tentato, anche con incontri di notevole rilevanza
simbolica, di delineare un rapporto di apertura e dialogo con
esponenti di altre religioni. Il dialogo deve continuare. Nella
condizione di più spiccato pluralismo culturale e religioso, quale si
va prospettando nella società del nuovo millennio, tale dialogo è
importante anche per mettere un sicuro presupposto di pace e allontanare
lo spettro funesto delle guerre di religione che hanno rigato di sangue
tanti periodi nella storia dell'umanità. Il nome dell'unico Dio deve
diventare sempre di più, qual è, un nome di pace e un imperativo di
pace.
56. Ma il dialogo non può essere fondato
sull'indifferentismo religioso, e noi cristiani abbiamo il dovere di
svilupparlo offrendo la testimonianza piena della speranza che è in noi
(cfr 1 Pt 3,15). Non dobbiamo aver paura che possa costituire
offesa all'altrui identità ciò che è invece annuncio gioioso di un
dono che è per tutti, e che va a tutti proposto con il più grande
rispetto della libertà di ciascuno: il dono della rivelazione del
Dio-Amore che « ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito
» (Gv 3,16). Tutto questo, come è stato anche recentemente
sottolineato dalla Dichiarazione Dominus Iesus, non può essere
oggetto di una sorta di trattativa dialogica, quasi fosse per noi una
semplice opinione: è invece per noi grazia che ci riempie di gioia, è
notizia che abbiamo il dovere di annunciare.
La Chiesa, pertanto, non si può
sottrarre all'attività missionaria verso i popoli, e resta compito
prioritario della missio ad gentes l'annuncio che è nel Cristo,
« Via, Verità e Vita » (Gv 14,6), che gli uomini trovano la
salvezza. Il dialogo interreligioso « non può semplicemente sostituire
l'annuncio, ma resta orientato verso l'annuncio ».40 Il
dovere missionario, d'altra parte, non ci impedisce di andare al dialogo
intimamente disposti all'ascolto. Sappiamo infatti che, di fronte
al mistero di grazia infinitamente ricco di dimensioni e di implicazioni
per la vita e la storia dell'uomo, la Chiesa stessa non finirà mai di
indagare, contando sull'aiuto del Paraclito, lo Spirito di verità (cfr Gv
14,17), al quale appunto compete di portarla alla « pienezza della
verità » (cfr Gv 16,13).
Questo principio è alla base non solo
dell'inesauribile approfondimento teologico della verità cristiana, ma
anche del dialogo cristiano con le filosofie, le culture, le religioni.
Non raramente lo Spirito di Dio, che « soffia dove vuole » (Gv 3,8),
suscita nell'esperienza umana universale, nonostante le sue molteplici
contraddizioni, segni della sua presenza, che aiutano gli stessi
discepoli di Cristo a comprendere più profondamente il messaggio di cui
sono portatori. Non è stato forse con questa umile e fiduciosa apertura
che il Concilio Vaticano II si è impegnato a leggere i « segni dei
tempi? ».41 Pur attuando un operoso e vigile discernimento,
per cogliere i « veri segni della presenza o del disegno di Dio »,42
la Chiesa riconosce che non ha solo dato, ma anche « ricevuto dalla
storia e dallo sviluppo del genere umano ».43 Questo
atteggiamento di apertura e insieme di attento discernimento il Concilio
lo ha inaugurato anche nei confronti delle altre religioni. Tocca a noi
seguirne l'insegnamento e la traccia con grande fedeltà.
Nella luce del Concilio
57. Quanta ricchezza, carissimi Fratelli
e Sorelle, negli orientamenti che il Concilio Vaticano II ci ha dato!
Per questo, in preparazione al Grande Giubileo, ho chiesto alla Chiesa
di interrogarsi sulla ricezione del Concilio.44 È
stato fatto? Il Convegno che si è tenuto qui in Vaticano è stato un
momento di questa riflessione, e mi auguro che altrettanto si sia fatto,
in diversi modi, in tutte le Chiese particolari. A mano a mano che
passano gli anni, quei testi non perdono il loro valore né il loro
smalto. È necessario che essi vengano letti in maniera appropriata,
che vengano conosciuti e assimilati, come testi qualificati e normativi
del Magistero, all'interno della Tradizione della Chiesa. A Giubileo
concluso sento più che mai il dovere di additare il Concilio, come la
grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso
ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo
che si apre.
CONCLUSIONE
DUC
IN ALTUM!
58. Andiamo avanti con speranza! Un nuovo
millennio si apre davanti alla Chiesa come oceano vasto in cui
avventurarsi, contando sull'aiuto di Cristo. Il Figlio di Dio, che si è
incarnato duemila anni or sono per amore dell'uomo, compie anche oggi la
sua opera: dobbiamo avere occhi penetranti per vederla, e soprattutto un
cuore grande per diventarne noi stessi strumenti. Non è stato forse per
riprendere contatto con questa fonte viva della nostra speranza, che
abbiamo celebrato l'Anno giubilare? Ora il Cristo contemplato e amato ci
invita ancora una volta a metterci in cammino: « Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo » (Mt 28,19). Il mandato
missionario ci introduce nel terzo millennio invitandoci allo stesso
entusiasmo che fu proprio dei cristiani della prima ora: possiamo
contare sulla forza dello stesso Spirito, che fu effuso a Pentecoste e
ci spinge oggi a ripartire sorretti dalla speranza « che non delude »
(Rm 5,5).
Il nostro passo, all'inizio di questo
nuovo secolo, deve farsi più spedito nel ripercorrere le strade del
mondo. Le vie sulle quali ciascuno di noi, e ciascuna delle nostre
Chiese, cammina, sono tante, ma non v'è distanza tra coloro che sono
stretti insieme dall'unica comunione, la comunione che ogni giorno si
alimenta alla mensa del Pane eucaristico e della Parola di vita. Ogni
domenica il Cristo risorto ci ridà come un appuntamento nel Cenacolo,
dove la sera del «primo giorno dopo il sabato» (Gv 20,19) si
presentò ai suoi per « alitare » su di loro il dono vivificante dello
Spirito e iniziarli alla grande avventura dell'evangelizzazione.
Ci accompagna in questo cammino la
Vergine Santissima, alla quale, qualche mese fa, insieme con tanti
Vescovi convenuti a Roma da tutte le parti del mondo, ho affidato il
terzo millennio. Tante volte in questi anni l'ho presentata e invocata
come « Stella della nuova evangelizzazione ». La addito ancora, come
aurora luminosa e guida sicura del nostro cammino. «Donna, ecco i tuoi
figli», le ripeto, riecheggiando la voce stessa di Gesù (cfr Gv 19,26),
e facendomi voce, presso di lei, dell'affetto filiale di tutta la
Chiesa.
59. Carissimi Fratelli e Sorelle! Il
simbolo della Porta Santa si chiude alle nostre spalle, ma per lasciare
più spalancata che mai la porta viva che è Cristo. Non è a un grigio
quotidiano che noi torniamo, dopo l'entusiasmo giubilare. Al contrario,
se autentico è stato il nostro pellegrinaggio, esso ha come sgranchito
le nostre gambe per il cammino che ci attende. Dobbiamo imitare lo
slancio dell'apostolo Paolo: « Proteso verso il futuro, corro verso la
meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in
Cristo Gesù » (Fil 3,13-14). Dobbiamo imitare insieme la
contemplazione di Maria, che, dopo il pellegrinaggio alla città santa
di Gerusalemme, ritornava nella casa di Nazareth meditando nel suo cuore
il mistero del Figlio (cfr Lc 2,51).
Gesù risorto, che si accompagna a noi
sulle nostre strade, lasciandosi riconoscere, come dai discepoli di
Emmaus « nello spezzare il pane » (Lc 24,35), ci trovi vigili e
pronti per riconoscere il suo volto e correre dai nostri fratelli a
portare il grande annuncio: « Abbiamo visto il Signore! » (Gv 20,25).
È questo il frutto tanto auspicato del
Giubileo dell'Anno Duemila, il Giubileo che ha riproposto al vivo ai
nostri occhi il mistero di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio e Redentore
dell'uomo. Mentre esso si conclude e ci apre a un futuro di speranza,
salga al Padre, attraverso Cristo, nello Spirito Santo, la lode e il
ringraziamento di tutta la Chiesa.
Con questo auspicio invio a tutti dal
profondo del cuore la mia Benedizione.
Dal Vaticano, il 6 gennaio, Solennità
dell'Epifania del Signore, dell'anno 2001, ventitreesimo di Pontificato.
NOTE
(1) Conc. Ecum. Vat. II, Decr.
sull'ufficio pastorale dei Vescovi Christus Dominus, 11.
(2) Bolla Incarnationis mysterium (29
novembre 1998), 3: AAS 91 (1999), 132.
(3) Ibid., 4: l.c., 133.
(4) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, 8.
(5) De civ. Dei XVIII, 51,2: PL
41,614; cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen
gentium, 8.
(6) Cfr Giovanni Paolo II, Lett. ap. Tertio
millennio adveniente (10 novembre 1994), 55: AAS 87 (1995),
38.
(7) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, 1.
(8) « Ignoratio enim Scripturarum
ignoratio Christi est »: Comm. in Is., Prol.: PL 24,17.
(9) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla divina rivelazione Dei Verbum, 19.
(10) « Seguendo i santi Padri,
all'unanimità, noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto
nella sua umanità, vero Dio e vero uomo [...] uno e medesimo Cristo
Signore unigenito, da riconoscersi in due nature, senza confusione,
immutabili, indivise, inseparabili [...] egli non è diviso o separato
in due persone, ma è un unico e medesimo figlio, unigenito, Dio, Verbo
e Signore Gesù Cristo »: DS 301-302.
(11) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past.
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 22.
(12) Osserva a tal proposito sant'Atanasio:
« L'uomo non poteva essere divinizzato rimanendo unito a una creatura,
se il Figlio non fosse vero Dio », Discorso II contro gli Ariani 70:
PG 26, 425 B – 426 G.
(13) N. 78.
(14) Ultimi Colloqui. Quaderno giallo,
6 luglio 1897: Opere complete, Città del Vaticano 1997, 1003.
(15) S. Cipriano, De Orat. Dom. 23:
PL 4, 553; cfr Lumen gentium, 4.
(16) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, 40.
(17) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla
sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 10.
(18) Cfr Congr. per la Dottrina della
Fede, Lett. su alcuni aspetti della meditazione cristiana Orationis
formas (15 ottobre 1989): AAS 82 (1990), 362-379.
(19) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla
sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 10.
(20) Cfr Giovanni Paolo II, Lett. ap. Dies
Domini (31 maggio 1998), 19: AAS 90 (1998), 724.
(21) Ibid., 2: l.c., 714.
(22) Cfr ibid., 35: l.c.,
734.
(23) Cfr n. 18: AAS 77 (1985),
224.
(24) Ibid., 31: l.c., 258.
(25) Tertulliano, Apol., 50,13: PL
1, 534.
(26) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, 1.
(27) MsB 3vo, Opere complete, Città
del Vaticano, 1997, 223.
(28) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, c. III.
(29) Cfr Congr. per il Clero ed Altre,
Istr. interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei
laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15 agosto
1997): AAS 89 (1997), 852-877, specie art. 5: Gli organismi di
collaborazione nella Chiesa particolare.
(30) Reg. III, 3: « Ideo autem omnes
ad consilium vocari diximus, quia saepe iuniori Dominus revelat quod
melius est ».
(31) « De omnium fidelium ore
pendeamus, quia in omnem fidelem Spiritus Dei spirat »: Epist. 23,
36 a Sulpicio Severo: CSEL 29, 193.
(32) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, 31.
(33) Conc. Ecum. Vat. II, Decr.
sull'apostolato dei laici Apostolicam actuositatem, 2.
(34) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.
sulla Chiesa Lumen gentium, 8.
(35) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past.
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 22.
(36) Cost. past. sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo Gaudium et spes, 34.
(37) S. Ignazio di Antiochia, Lettera
ai Romani, Pref., ed. Funk, I, 252.
(38) Così, ad esempio, S. Agostino: « Luna
intellegitur Ecclesia, quod suum lumen non habeat, sed ab Unigenito Dei
Filio, qui multis locis in Sanctis Scripturis allegorice sol appellatus
est »: Enarr. in Ps. 10, 3: CCL 38, 42.
(39) Cfr Dich. sulle relazioni della
Chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetate.
(40) Istr. sull'annuncio del Vangelo e il
dialogo interreligioso del Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso e della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Dialogo
e annuncio: riflessioni e orientamenti (19 maggio 1991), 82: AAS 84
(1992), 444.
(41) Cfr Cost. past. sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo Gaudium et spes, 4.
(42) Ibid., 11.
(43) Ibid., 44.
(44) Cfr Lett. ap. Tertio millennio
adveniente (10 novembre 1994), 36: AAS 87 (1995), 28.
|