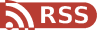LETTERA
APOSTOLICA
SALVIFICI
DOLORIS
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
AI VESCOVI, AI SACERDOTI,
ALLE FAMIGLIE RELIGIOSE
ED AI FEDELI DELLA CHIESA CATTOLICA
SUL SENSO CRISTIANO
DELLA SOFFERENZA UMANA
Venerati Fratelli
nell'episcopato,
carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo!
I
INTRODUZIONE
1. « Completo nella mia carne —
dice l'apostolo Paolo spiegando il valore salvifico della sofferenza
— quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo
che è la Chiesa »(1).
Queste parole sembrano trovarsi al
termine del lungo cammino che si snoda attraverso la sofferenza
inserita nella storia dell'uomo ed illuminata dalla Parola di Dio.
Esse hanno quasi il valore di una definitiva scoperta, che viene
accompagnata dalla gioia; per questo l'Apostolo scrive: « Perciò
sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi »(2). La gioia
proviene dalla scoperta del senso della sofferenza, ed una tale
scoperta, anche se vi partecipa in modo personalissimo Paolo di Tarso
che scrive queste parole, è al tempo stesso valida per gli altri.
L'Apostolo comunica la propria scoperta e ne gioisce a motivo di tutti
coloro che essa può aiutare — così come aiutò lui — a penetrare
il senso salvifico della sofferenza.
2. Il tema della
sofferenza—proprio sotto l'aspetto di questo senso
salvifico—sembra essere profondamente inserito nel contesto
dell'Anno della Redenzione come giubileo straordinario della Chiesa;
ed anche questa circostanza si dimostra direttamente in favore
dell'attenzione da dedicare ad esso proprio durante questo periodo.
Indipendentemente da questo fatto, è un tema universale che
accompagna l'uomo ad ogni grado della longitudine e della latitudine
geografica: esso, in un certo senso, coesiste con lui nel mondo, e
perciò esige di essere costantemente ripreso. Anche se Paolo nella
Lettera ai Romani ha scritto che « tutta la creazione geme e soffre
fino ad oggi nelle doglie del parto »(3), anche se all'uomo sono note
e vicine le sofferenze proprie del mondo degli animali, tuttavia ciò
che esprimiamo con la parola « sofferenza » sembra essere
particolarmente essenziale alla natura dell'uomo. Ciò è tanto
profondo quanto l'uomo, appunto perché manifesta a suo modo quella
profondità che è propria dell'uomo, ed a suo modo la supera. La
sofferenza sembra appartenere alla trascendenza dell'uomo: essa è uno
di quei punti, nei quali l'uomo viene in un certo senso « destinato
» a superare se stesso, e viene a ciò chiamato in modo misterioso.
3. Se il tema della sofferenza
esige di essere affrontato in modo particolare nel contesto dell'Anno
della Redenzione, ciò avviene prima di tutto perché la redenzione
si è compiuta mediante la Croce di Cristo, ossia mediante
la sua sofferenza. E al tempo stesso nell'Anno della Redenzione
ripensiamo alla verità espressa nell'Enciclica Redemptor hominis: in
Cristo « ogni uomo diventa la via della Chiesa »(4). Si può dire
che l'uomo diventa in modo speciale la via della Chiesa, quando nella
sua vita entra la sofferenza. Ciò avviene — come è noto — in
diversi momenti della vita, si realizza in modi differenti, assume
diverse dimensioni; tuttavia, nell'una o nell'altra forma, la
sofferenza sembra essere, ed è, quasi inseparabile dall'esistenza
terrena dell'uomo.
Dato dunque che l'uomo, attraverso
la sua vita terrena, cammina in un modo o nell'altro sulla via della
sofferenza, la Chiesa in ogni tempo — e forse specialmente nell'Anno
della Redenzione — dovrebbe incontrarsi con l'uomo proprio su questa
via. La Chiesa, che nasce dal mistero della redenzione nella Croce di
Cristo, è tenuta a cercare l'incontro con l'uomo in modo
particolare sulla via della sua sofferenza. In un tale incontro l'uomo
« diventa la via della Chiesa », ed è, questa, una delle vie più
importanti.
4. Da qui deriva anche la presente
riflessione, proprio nell'Anno della Redenzione: la riflessione sulla
sofferenza. La sofferenza umana desta compassione, desta anche rispetto,
ed a suo modo intimidisce. In essa, infatti, è contenuta
la grandezza di uno specifico mistero. Questo particolare rispetto per
ogni umana sofferenza deve esser posto all'inizio di quanto verrà
espresso qui successivamente dal più profondo bisogno del cuore, ed
anche dal profondo imperativo della fede. Intorno al tema della
sofferenza questi due motivi sembrano avvicinarsi particolarmente tra
loro ed unirsi: il bisogno del cuore ci ordina di vincere il timore, e
l'imperativo della fede — formulato, per esempio, nelle parole di
San Paolo, riportate all'inizio — fornisce il contenuto, nel nome e
in forza del quale osiamo toccare ciò che sembra in ogni uomo tanto
intangibile: poiché l'uomo, nella sua sofferenza, rimane un mistero
intangibile.
II
IL
MONDO DELL' UMANA SOFFERENZA
5. Anche se nella sua dimensione
soggettiva, come fatto personale, racchiuso nel concreto e
irripetibile interno dell'uomo, la sofferenza sembra quasi ineffabile
ed incomunicabile al tempo stesso, forse nient'altro quanto essa
esige, nella sua « realtà oggettiva », che sia trattata,
meditata, concepita nella forma di un esplicito problema, e che quindi
intorno ad essa si pongano interrogativi di fondo e si cerchino le
risposte. Come si vede, non si tratta qui solo di dare una descrizione
della sofferenza. Vi sono altri criteri, che vanno oltre la sfera
della descrizione, e che dobbiamo introdurre, quando vogliamo
penetrare il mondo dell'umana sofferenza.
Può darsi che la medicina, come
scienza ed insieme come arte del curare, scopra sul vasto terreno
delle sofferenze dell'uomo il settore più conosciuto, quello
identificato con maggior precisione e, relativamente, più
controbilanciato dai metodi del «reagire » (cioè della terapia).
Tuttavia, questo è solo un settore. Il terreno della sofferenza umana
è molto più vasto, molto più vario e pluridimensionale. L'uomo
soffre in modi diversi, non sempre contemplati dalla medicina, neanche
nelle sue più avanzate specializzazioni. La sofferenza è qualcosa di
ancora più ampio della malattia, di più complesso ed insieme
ancor più profondamente radicato nell'umanità stessa. Una certa idea
di questo problema ci viene dalla distinzione tra sofferenza fisica e
sofferenza morale. Questa distinzione prende come fondamento la
duplice dimensione dell'essere umano, ed indica l'elemento corporale e
spirituale come l'immediato o diretto soggetto della sofferenza. Per
quanto si possano, fino ad un certo grado, usare come sinonimi le
parole « sofferenza » e « dolore », la sofferenza fisica si
verifica quando in qualsiasi modo « duole il corpo », mentre la
sofferenza morale è « dolore dell'anima ». Si tratta, infatti,
del dolore di natura spirituale, e non solo della dimensione «
psichica » del dolore che accompagna sia la sofferenza morale, sia
quella fisica. La vastità e la multiformità della sofferenza morale
non sono certamente minori di quella fisica; al tempo stesso, però,
essa sembra quasi meno identificata e meno raggiungibile dalla
terapia.
6. La Sacra Scrittura è un grande
libro sulla sofferenza. Riportiamo dai Libri dell'Antico
Testamento solo alcuni esempi di situazioni, che recano i segni della
sofferenza e, prima di tutto, di quella morale: il pericolo di
morte(5), la morte dei propri figli(6) e, specialmente, la morte del
figlio primogenito ed unico(7), e poi anche: la mancanza di prole(8),
la nostalgia per la patria(9), la persecuzione e l'ostilità
dell'ambiente(10), lo scherno e la derisione per il sofferente(11), la
solitudine e l'abbandono(12); ed ancora: i rimorsi di coscienza(13),
la difficoltà di capire perché i cattivi prosperano e i giusti
soffrono(14), l'infedeltà e l'ingratitudine da parte degli amici e
dei vicini(15); infine: le sventure della propria nazione(16).
L'Antico Testamento, trattando
l'uomo come un « insieme » psicofisico, unisce spesso le
sofferenze « morali » col dolore di determinate parti
dell'organismo: delle ossa(17), dei reni(18), del fegato(19), dei
visceri(20), del cuore(21). Non si può, infatti, negare che le
sofferenze morali abbiano anche una loro componente « fisica », o
somatica, e che spesso si riflettano sullo stato dell'intero
organismo.
7. Come si vede dagli esempi
riportati, nella Sacra Scrittura troviamo un vasto elenco di
situazioni variamente dolorose per l'uomo. Questo elenco diversificato
certamente non esaurisce tutto ciò che in tema di sofferenza ha già
detto e costantemente ripete il libro della storia dell'uomo (questo
è piuttosto un « libro non scritto »), ed ancor più il libro della
storia dell'umanità, letto attraverso la storia di ogni uomo.
Si può dire che l'uomo soffre,
allorquando sperimenta un qualsiasi male. Nel vocabolario
dell'Antico Testamento il rapporto tra sofferenza e male si pone in
evidenza come identità. Quel vocabolario, infatti, non possedeva una
parola specifica per indicare la « sofferenza »; perciò, definiva
come « male » tutto ciò che era sofferenza»(22). Solamente la
lingua greca e, insieme con essa, il Nuovo Testamento (e le versioni
greche dall'Antico) si servono del verbo «pasko = sono affetto da
..., provo una sensazione, soffro »; e grazie ad esso la sofferenza
non è più direttamente identificabile col male (oggettivo), ma
esprime una situazione nella quale l'uomo prova il male e, provandolo,
diventa soggetto di sofferenza. Questa invero ha, ad un tempo, carattere
attivo e passivo (da « patior »). Perfino quando l'uomo
si provoca da solo una sofferenza, quando è l'autore di essa, questa
sofferenza rimane qualcosa di passivo nella sua essenza metafisica.
Ciò, tuttavia, non vuol dire che
la sofferenza in senso psicologico non sia contrassegnata da una specifica
« attività ». Questa è, infatti, quella molteplice e
soggettivamente differenziata « attività » di dolore, di tristezza,
di delusione, di abbattimento o, addirittura, di disperazione, a
seconda dell'intensità della sofferenza, della sua profondità e,
indirettamente, a seconda di tutta la struttura del soggetto
sofferente e della sua specifica sensibilità. Al centro di ciò che
costituisce la forma psicologica della sofferenza si trova sempre un'esperienza
del male, a causa del quale l'uomo soffre.
Così dunque la realtà della
sofferenza provoca l'interrogativo sull'essenza del male: che cosa è
il male?
Questo interrogativo sembra, in un
certo senso, inseparabile dal tema della sofferenza. La risposta
cristiana ad esso è diversa da quella che viene data da alcune
tradizioni culturali e religiose, le quali ritengono che l'esistenza
sia un male, dal quale bisogna liberarsi. Il cristianesimo proclama
l'essenziale bene dell'esistenza e il bene di ciò che esiste,
professa la bontà del Creatore e proclama il bene delle creature.
L'uomo soffre a causa del male, che è una certa mancanza, limitazione
o distorsione del bene. Si potrebbe dire che l'uomo soffre a motivo
di un bene al quale egli non partecipa, dal quale viene, in un
certo senso, tagliato fuori, o del quale egli stesso si è privato.
Soffre in particolare quando « dovrebbe » aver parte—nell'ordine
normale delle cose—a questo bene, e non l'ha.
Cosi dunque nel concetto cristiano
la realtà della sofferenza si spiega per mezzo del male, che è
sempre, in qualche modo, in riferimento ad un bene.
8. La sofferenza umana costituisce
in se stessa quasi uno specifico « mondo » che esiste insieme
all'uomo, che appare in lui e passa, e a volte non passa, ma in lui si
consolida ed approfondisce. Questo mondo della sofferenza, diviso in
molti, in numerosissimi soggetti, esiste quasi nella dispersione. Ogni
uomo, mediante la sua personale sofferenza, costituisce non solo una
piccola parte di quel « mondo », ma al tempo stesso quel « mondo »
è in lui come un'entità finita e irripetibile. Di pari passo con ciò
va, tuttavia, la dimensione interumana e sociale. Il mondo della
sofferenza possiede quasi una sua propria compattezza. Gli
uomini sofferenti si rendono simili tra loro mediante l'analogia della
situazione, la prova del destino, oppure mediante il bisogno di
comprensione e di premura, e forse soprattutto mediante il persistente
interrogativo circa il senso di essa. Benché dunque il mondo della
sofferenza esista nella dispersione, al tempo stesso contiene in se'
una singolare sfida alla comunione e alla solidarietà. Cercheremo
anche di seguire un tale appello nella presente riflessione.
Pensando al mondo della sofferenza
nel suo significato personale ed insieme collettivo, non si può,
infine, non notare il fatto che un tal mondo, in alcuni periodi di
tempo ed in alcuni spazi dell'esistenza umana, quasi si addensa in
modo particolare. Ciò accade, per esempio, nei casi di calamità
naturali, di epidemie, di catastrofi e di cataclismi, di diversi
flagelli sociali: si pensi, ad esempio, a quello di un cattivo
raccolto e legato ad esso — oppure a diverse altre cause — al
flagello della fame.
Si pensi, infine, alla guerra.
Parlo di essa in modo speciale. Parlo della ultime due guerre
mondiali, delle quali la seconda ha portato con se' una messe molto più
grande di morte ed un cumulo più pesante di umane sofferenze. A sua
volta, la seconda metà del nostro secolo — quasi in proporzione
agli errori ed alle trasgressioni della nostra civiltà
contemporanea — porta in se' una minaccia così orribile di guerra
nucleare, che non possiamo pensare a questo periodo se non in termini
di un accumulo incomparabile di sofferenze, fino alla possibile
auto-distruzione dell'umanità. In questo modo quel mondo di
sofferenza, che in definitiva ha il suo soggetto in ciascun uomo,
sembra trasformarsi nella nostra epoca — forse più che in qualsiasi
altro momento — in una particolare « sofferenza del mondo »: del
mondo che come non mai è trasformato dal progresso per opera
dell'uomo e, in pari tempo, come non mai è in pericolo a causa degli
errori e delle colpe dell'uomo.
III
ALLA
RICERCA DELLA RISPOSTA ALL' INTERROGATIVO
SUL SENSO DELLA SOFFERENZA
9. All'interno di ogni singola
sofferenza provata dall'uomo e, parimenti, alla base dell'intero mondo
delle sofferenze appare inevitabilmente l'interrogativo: perché? E'
un interrogativo circa la causa, la ragione, ed insieme un
interrogativo circa lo scopo (perché?) e, in definitiva, circa
il senso. Esso non solo accompagna l'umana sofferenza, ma sembra
addirittura determinarne il contenuto umano, ciò per cui la
sofferenza è propriamente sofferenza umana.
Ovviamente il dolore, specie
quello fisico, è ampiamente diffuso nel mondo degli animali. Però
solo l'uomo, soffrendo, sa di soffrire e se ne chiede il perché; e
soffre in modo umanamente ancor più profondo, se non trova
soddisfacente risposta. Questa è una domanda difficile, così
come lo è un'altra, molto affine, cioè quella intorno al male. Perché
il male? Perché il male nel mondo? Quando poniamo l'interrogativo in
questo modo, facciamo sempre, almeno in una certa misura, una domanda
anche sulla sofferenza.
L'uno e l'altro interrogativo sono
difficili, quando l'uomo li pone all'uomo, gli uomini agli uomini,
come anche quando l'uomo li pone a Dio. L'uomo, infatti, non
pone questo interrogativo al mondo, benché molte volte la sofferenza
gli provenga da esso, ma lo pone a Dio come al Creatore e al Signore
del mondo. Ed è ben noto come sul terreno di questo interrogativo si
arrivi non solo a molteplici frustrazioni e conflitti nei rapporti
dell'uomo con Dio, ma capiti anche che si giunga alla negazione
stessa di Dio. Se, infatti, l'esistenza del mondo apre quasi lo
sguardo dell'anima umana all'esistenza di Dio, alla sua sapienza,
potenza e magnificenza, allora il male e la sofferenza sembrano
offuscare quest'immagine, a volte in modo radicale, tanto più nella
quotidiana drammaticità di tante sofferenze senza colpa e di tante
colpe senza adeguata pena. Perciò, questa circostanza — forse ancor
più di qualunque altra — indica quanto sia importante l'interrogativo
sul senso della sofferenza, e con quale acutezza occorra trattare
sia l'interrogativo stesso, sia ogni possibile risposta da darvi.
10. L'uomo può rivolgere un tale
interrogativo a Dio con tutta la commozione del suo cuore e con la
mente piena di stupore e di inquietudine; e Dio aspetta la domanda e
l'ascolta, come vediamo nella Rivelazione dell'Antico Testamento. Nel
Libro di Giobbe l'interrogativo ha trovato la sua espressione più
viva.
E' nota la storia di questo uomo
giusto, il quale senza nessuna colpa da parte sua viene provato da
innumerevoli sofferenze. Egli perde i beni, i figli e le figlie, ed
infine viene egli stesso colpito da una grave malattia. In quest'orribile
situazione si presentano nella sua casa i tre vecchi conoscenti, i
quali — ognuno con diverse parole — cercano di convincerlo che,
poiché è stato colpito da una così molteplice e terribile
sofferenza, egli deve aver commesso una qualche colpa grave. La
sofferenza — essi dicono — colpisce infatti sempre l'uomo come
pena per un reato; viene mandata da Dio assolutamente giusto e trova
la propria motivazione nell'ordine della giustizia. Si direbbe che i
vecchi amici di Giobbe vogliano non solo convincerlo della
giustezza morale del male, ma in un certo senso tentino di difendere
davanti a se' stessi il senso morale della sofferenza. Questa, ai
loro occhi, può avere esclusivamente un senso come pena per il
peccato, esclusivamente dunque sul terreno della giustizia di Dio, che
ripaga col bene il bene e col male il male.
Il punto di riferimento è in
questo caso la dottrina espressa in altri scritti dell'Antico
Testamento, che ci mostrano la sofferenza come pena inflitta da Dio
per i peccati degli uomini. Il Dio della Rivelazione è Legislatore
e Giudice in una tale misura, quale nessuna autorità temporale può
avere. Il Dio della Rivelazione, infatti, è prima di tutto il Creatore,
dal quale, insieme con l'esistenza, proviene il bene essenziale
della creazione. Pertanto, anche la consapevole e libera violazione di
questo bene da parte dell'uomo è non solo una trasgressione della
legge, ma al tempo stesso un'offesa al Creatore, che è il primo
Legislatore. Tale trasgressione ha carattere di peccato, secondo il
significato esatto, cioè biblico e teologico, di questa parola. Al male
morale del peccato corrisponde la punizione, che garantisce
l'ordine morale nello stesso senso trascendente, nel quale quest'ordine
è stabilito dalla volontà del Creatore e supremo Legislatore. Di qui
deriva anche una delle fondamentali verità della fede religiosa,
basata del pari sulla Rivelazione: che cioè Dio è giudice giusto, il
quale premia il bene e punisce il male: « Tu, Signore, sei giusto in
tutto ciò che hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue
vie e giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per
quanto hai fatto ricadere su di noi ... Con verità e giustizia tu ci
hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati »(23).
Nell'opinione espressa dagli amici
di Giobbe, si manifesta una convinzione che si trova anche nella
coscienza morale dell'umanità: l'ordine morale oggettivo richiede una
pena per la trasgressione, per il peccato e per il reato. La
sofferenza appare, da questo punto di vita, come un « male
giustificato ». La convinzione di coloro che spiegano la sofferenza
come punizione del peccato trova il suo sostegno nell'ordine della
giustizia, e ciò corrisponde all'opinione espressa da un amico di
Giobbe: « Per quanto io ho visto, chi coltiva iniquità, chi semina
affanni, li raccoglie »(24).
11. Giobbe, tuttavia, contesta la
verità del principio, che identifica la sofferenza con la punizione
del peccato. E lo fa in base alla propria opinione. Infatti, egli è
consapevole di non aver meritato una tale punizione, anzi espone il
bene che ha fatto nella sua vita. Alla fine Dio stesso rimprovera gli
amici di Giobbe per le loro accuse e riconosce che Giobbe non è
colpevole. La sua è la sofferenza di un innocente; deve essere
accettata come un mistero, che l'uomo non è in grado di penetrare
fino in fondo con la sua intelligenza.
Il Libro di Giobbe non intacca le
basi dell'ordine morale trascendente, fondato sulla giustizia, quali
son proposte dalla Rivelazione, nell'Antica e nella Nuova Alleanza. Al
tempo stesso, però, il Libro dimostra con tutta fermezza che i
principi di quest'ordine non si possono applicare in modo esclusivo e
superficiale. Se è vero che la sofferenza ha un senso come punizione,
quando è legata alla colpa, non è vero, invece, che ogni
sofferenza sia conseguenza della colpa ed abbia carattere di
punizione. La figura del giusto Giobbe ne è una prova speciale
nell'Antico Testamento. La Rivelazione, parola di Dio stesso, pone con
tutta franchezza il problema della sofferenza dell'uomo innocente: la
sofferenza senza colpa. Giobbe non è stato punito, non vi erano le
basi per infliggergli una pena, anche se è stato sottoposto ad una
durissima prova. Dall'introduzione del Libro risulta che Dio permise
questa prova per provocazione di Satana. Questi, infatti, aveva
contestato davanti al Signore la giustizia di Giobbe: « Forse che
Giobbe teme Dio per nulla? ... Tu hai benedetto il lavoro delle sue
mani, e il suo bestiame abbonda sulla terra. Ma stendi un poco la mano
e tocca quanto ha, e vedrai come ti benedirà in faccia »(25). E se
il Signore acconsente a provare Giobbe con la sofferenza, lo fa per
dimostrarne la giustizia. La sofferenza ha carattere di prova.
I1 Libro di Giobbe non è l'ultima
parola della Rivelazione su questo tema. In un certo modo esso è un
annuncio della passione di Cristo. Ma, già da solo, è un
argomento sufficiente, perché la risposta all'interrogativo sul
senso della sofferenza non sia collegata senza riserve con l'ordine
morale, basato sulla sola giustizia. Se una tale risposta ha una sua
fondamentale e trascendente ragione e validità, al tempo stesso essa
si dimostra non solo insoddisfacente in casi analoghi alla sofferenza
del giusto Giobbe, ma anzi sembra addirittura appiattire ed impoverire
il concetto di giustizia, che incontriamo nella Rivelazione.
12. Il Libro di Giobbe pone in
modo acuto il « perché » della sofferenza, mostra pure che essa
colpisce l'innocente, ma non dà ancora la soluzione al problema.
Già nell'Antico Testamento
notiamo un orientamento che tende a superare il concetto, secondo cui
la sofferenza ha senso unicamente come punizione del peccato, in
quanto si sottolinea nello stesso tempo il valore educativo della pena
sofferenza. Così dunque, nelle sofferenze inflitte da Dio al popolo
eletto è racchiuso un invito della sua misericordia, la quale
corregge per condurre alla conversione: « Questi castighi non vengono
per la distruzione, ma per la correzione del nostro popolo »(26).
Così si afferma la dimensione
personale della pena. Secondo tale dimensione, la pena ha senso non
soltanto perché serve a ripagare lo stesso male oggettivo della
trasgressione con un altro male, ma prima di tutto perché essa crea
la possibilità di ricostruire il bene nello stesso soggetto
sofferente.
Questo è un aspetto estremamente
importante della sofferenza. Esso è profondamente radicato
nell'intera Rivelazione dell'Antica e, soprattutto, della Nuova
Alleanza. La sofferenza deve servire alla conversione, cioè alla
ricostruzione del bene nel soggetto, che può riconoscere la
misericordia divina in questa chiamata alla penitenza. La penitenza ha
come scopo di superare il male, che sotto diverse forme è latente
nell'uomo, e di consolidare il bene sia in lui stesso, sia nei
rapporti con gli altri e, soprattutto, con Dio.
13. Ma per poter percepire la vera
risposta al « perché » della sofferenza, dobbiamo volgere il nostro
sguardo verso la rivelazione dell'amore divino, fonte ultima del senso
di tutto ciò che esiste. L'amore è anche la fonte più ricca del
senso della sofferenza, che rimane sempre un mistero: siamo
consapevoli dell'insufficienza ed inadeguatezza delle nostre
spiegazioni. Cristo ci fa entrare nel mistero e ci fa scoprire il «
perché » della sofferenza, in quanto siamo capaci di comprendere la
sublimità dell'amore divino.
Per ritrovare il senso profondo
della sofferenza, seguendo la Parola rivelata di Dio, bisogna aprirsi
largamente verso il soggetto umano nella sua molteplice potenzialità.
Bisogna, soprattutto, accogliere la luce della Rivelazione non
soltanto in quanto essa esprime l'ordine trascendente della giustizia,
ma in quanto illumina questo ordine con l'amore, quale sorgente
definitiva di tutto ciò che esiste. L'Amore è anche la sorgente più
piena della risposta all'interrogativo sul senso della sofferenza.
Questa risposta è stata data da Dio all'uomo nella Croce di Gesù
Cristo.
IV
GESU'
CRISTO: LA SOFFERENZA VINTA DALL'AMORE
14. « Dio infatti ha tanto amato
il mondo che ha dato il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna »(27).
Queste parole, pronunciate da
Cristo nel colloquio con Nicodemo, ci introducono nel centro stesso dell'azione
salvifica di Dio. Esse esprimono anche l'essenza stessa della
soteriologia cristiana, cioè della teologia della salvezza. Salvezza
significa liberazione dal male, e per ciò stesso rimane in stretto
rapporto col problema della sofferenza. Secondo le parole rivolte a
Nicodemo, Dio dà il suo Figlio al « mondo » per liberare l'uomo dal
male, che porta in se' la definitiva ed assoluta prospettiva della
sofferenza. Contemporaneamente, la stessa parola « dà »(«ha
dato ») indica che questa liberazione deve essere compiuta dal Figlio
unigenito mediante la sua propria sofferenza. E in ciò si manifesta
l'amore, l'amore infinito sia di quel Figlio unigenito, sia del Padre,
il quale « dà » per questo il suo Figlio. Questo è l'amore per
l'uomo, l'amore per il « mondo »: è l'amore salvifico.
Ci troviamo qui — occorre
rendersene conto chiaramente nella nostra comune riflessione su questo
problema — in una dimensione completamente nuova del nostro tema. E'
dimensione diversa da quella che determinava e, in un certo senso,
chiudeva la ricerca del significato della sofferenza entro i limiti
della giustizia. Questa è la dimensione della Redenzione ,
alla quale nell'Antico Testamento già sembrano preludere, almeno
secondo il testo della Volgata, le parole del giusto Giobbe: « Io so
infatti che il mio Redentore vive, e che nell'ultimo giorno... vedrò
il mio Dio... »(28). Mentre finora la nostra considerazione si è
concentrata prima di tutto e, in un certo senso, esclusivamente sulla
sofferenza nella sua molteplice forma temporale (come anche le
sofferenze del giusto Giobbe), invece le parole, ora riportate dal
colloquio di Gesù con Nicodemo, riguardano la sofferenza nel suo
senso fondamentale e definitivo. Dio dà il suo Figlio unigenito,
affinché l'uomo « non muoia », e il significato di questo « non
muoia » viene precisato accuratamente dalle parole successive: « ma
abbia la vita eterna ».
L'uomo « muore », quando perde
« la vita eterna ». Il contrario della salvezza non è, quindi, la
sola sofferenza temporale, una qualsiasi sofferenza, ma la sofferenza
definitiva: la perdita della vita eterna, l'essere respinti da Dio, la
dannazione. Il Figlio unigenito è stato dato all'umanità per
proteggere l'uomo, prima di tutto, contro questo male definitivo e
contro la sofferenza definitiva. Nella sua missione salvifica
egli deve, dunque, toccare il male alle sue stesse radici
trascendentali, dalle quali esso si sviluppa nella storia dell'uomo.
Tali radici trascendentali del male sono fissate nel peccato e nella
morte: esse, infatti, si trovano alla base della perdita della vita
eterna. La missione del Figlio unigenito consiste nel vincere il
peccato e la morte. Egli vince il peccato con la sua obbedienza
fino alla morte, e vince la morte con la sua risurrezione.
15. Quando si dice che Cristo con
la sua missione tocca il male alle sue stesse radici, noi abbiamo in
mente non solo il male e la sofferenza definitiva, escatologica (perché
l'uomo « non muoia, ma abbia la vita eterna »), ma anche — almeno
indirettamente — il male e la sofferenza nella loro dimensione
temporale e storica. Il male, infatti, rimane legato al
peccato e alla morte. E anche se con grande cautela si deve giudicare
la sofferenza dell'uomo come conseguenza di peccati concreti (ciò
indica proprio l'esempio del giusto Giobbe), tuttavia essa non può
essere distaccata dal peccato delle origini, da ciò che in san
Giovanni è chiamato « il peccato del mondo »(29), dallo sfondo
peccaminoso delle azioni personali e dei processi sociali nella
storia dell'uomo. Se non è lecito applicare qui il criterio ristretto
della diretta dipendenza (come facevano i tre amici di Giobbe),
tuttavia non si può neanche rinunciare al criterio che, alla base
delle umane sofferenze, vi è un multiforme coinvolgimento nel
peccato.
Similmente avviene quando si
tratta della morte. Molte volte essa è attesa persino come una
liberazione dalle sofferenze di questa vita. Al tempo stesso, non è
possibile lasciarsi sfuggire che essa costituisce quasi una definitiva
sintesi della loro opera distruttiva sia nell'organismo corporeo che
nella psiche. Ma, prima di tutto la morte comporta la dissociazione
dell'intera personalità psicofisica dell'uomo. L'anima sopravvive
e sussiste separata dal corpo, mentre il corpo viene sottoposto ad una
graduale decomposizione secondo le parole del Signore Dio, pronunciate
dopo il peccato commesso dall'uomo agli inizi della sua storia
terrena: « Tu sei polvere e in polvere ritornerai »(30). Anche se
dunque la morte non è una sofferenza nel senso temporale della
parola, anche se in un certo modo si trova al di là di
tutte le sofferenze, contemporaneamente il male, che l'essere
umano sperimenta in essa, ha un caratere definitivo e totalizzante.
Con la sua opera salvifica il Figlio unigenito libera l'uomo dal
peccato e dalla morte. Prima di tutto egli cancella dalla
storia dell'uomo il dominio del peccato, che si è radicato
sotto l'influsso dello Spirito maligno, iniziando dal peccato
originale, e dà poi all'uomo la possibilità di vivere nella Grazia
santificante. Sulla scia della vittoria sul peccato egli toglie anche
il dominio della morte, dando, con la sua risurrezione, l'avvio
alla futura risurrezione dei corpi. L'una e l'altra sono condizione
essenziale della « vita eterna », cioè della definitiva felicità
dell'uomo in unione con Dio; ciò vuol dire, per i salvati, che nella
prospettiva escatologica la sofferenza è totalmente cancellata.
In conseguenza dell'opera
salvifica di Cristo l'uomo esiste sulla terra con la speranza della
vita e della santità eterne. E anche se la vittoria sul peccato e
sulla morte, riportata da Cristo con la sua croce e risurrezione, non
abolisce le sofferenze temporali dalla vita umana, né libera dalla
sofferenza l'intera dimensione storica dell'esistenza umana, tuttavia
su tutta questa dimensione e su ogni sofferenza essa getta una luce
nuova, che è la luce della salvezza. E' questa la luce del
Vangelo, cioè della Buona Novella. Al centro di questa luce si trova
la verità enunciata nel colloquio con Nicodemo: « Dio infatti ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito »(31). Questa
verità cambia dalle sue fondamenta il quadro della storia dell'uomo e
della sua situazione terrena: nonostante il peccato che si è radicato
in questa storia e come eredità originale e come « peccato del mondo
» e come somma dei peccati personali, Dio Padre ha amato il Figlio
unigenito, cioè lo ama in modo durevole; nel tempo poi, proprio per
quest'amore che supera tutto, egli « dà » questo Figlio, affinché
tocchi le radici stesse del male umano e così si avvicini in modo
salvifico all'intero mondo della sofferenza, di cui l'uomo è
partecipe.
16. Nella sua attività messianica
in mezzo a Israele Cristo si è avvicinato incessantemente al mondo
dell'umana sofferenza. « Passò facendo del bene »(32), e questo
suo operare riguardava, prima di tutto, i sofferenti e coloro che
attendevano aiuto. Egli guariva gli ammalati, consolava gli afflitti,
nutriva gli affamati, liberava gli uomini dalla sordità, dalla cecità,
dalla lebbra, dal demonio e da diverse minorazioni fisiche, tre volte
restituì ai morti la vita. Era sensibile a ogni umana sofferenza, sia
a quella del corpo che a quella dell'anima. E al tempo stesso
ammaestrava, ponendo al centro del suo insegnamento le otto
beatitudini, che sono indirizzate agli uomini provati da svariate
sofferenze nella vita temporale. Essi sono « i poveri in spirito » e
« gli afflitti », e « quelli che hanno fame e sete della giustizia
» e « i perseguitati per causa della giustizia », quando li
insultano, li perseguitano e mentendo, dicono ogni sorta di male
contro di loro per causa di Cristo(33)... Così secondo Matteo; Luca
menziona esplicitamente coloro « che ora hanno fame »(34).
Ad ogni modo Cristo si è
avvicinato soprattutto al mondo dell'umana sofferenza per il fatto di
aver assunto egli stesso questa sofferenza su di se'. Durante
la sua attività pubblica provò non solo la fatica, la mancanza di
una casa, l'incomprensione persino da parte dei più vicini, ma, più
di ogni cosa, venne sempre più ermeticamente circondato da un cerchio
di ostilità e divennero sempre più chiari i preparativi per
toglierlo di mezzo dai viventi. Cristo è consapevole di ciò, e molte
volte parla ai suoi discepoli delle sofferenze e della morte che lo
attendono: « Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà
consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a
morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno
addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni
risusciterà »(35). Cristo va incontro alla sua passione e morte con
tutta la consapevolezza della missione che ha da compiere proprio in
questo modo. Proprio per mezzo di questa sua sofferenza egli
deve far sì « che l'uomo non muoia, ma abbia la vita eterna ».
Proprio per mezzo della sua Croce deve toccare le radici del male,
piantate nella storia dell'uomo e nelle anime umane. Proprio per mezzo
della sua Croce deve compiere l'opera della salvezza. Quest'opera,
nel disegno dell'eterno Amore, ha un carattere redentivo.
E perciò Cristo rimprovera
severamente Pietro, quando vuole fargli abbandonare i pensieri sulla
sofferenza e sulla morte di Croce(36). E quando, durante la cattura
nel Getsemani, lo stesso Pietro tenta di difenderlo con la spada,
Cristo gli dice: « Rimetti la spada nel fodero... Ma come allora si
adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?
»(37). Ed inoltre dice: « Non devo forse bere il calice che il
Padre mi ha dato? »(38). Questa risposta — come altre che
ritornano in diversi punti del Vangelo — mostra quanto profondamente
Cristo fosse penetrato dal pensiero che già aveva espresso nel
colloquio con Nicodemo: « Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma
abbia la vita eterna »(39). Cristo s'incammina verso la propria
sofferenza, consapevole della sua forza salvifica, va obbediente al
Padre, ma prima di tutto è unito al Padre in quest'amore, col
quale Egli ha amato il mondo e l'uomo nel mondo. E per questo San
Paolo scriverà di Cristo: « Mi ha amato e ha dato se stesso per me
»(40).
17. Le Scritture dovevano
adempiersi. Erano molti i testi messianici dell'Antico Testamento che
preludevano alle sofferenze del futuro Unto di Dio. Tra tutti
particolarmente toccante è quello che di solito è chiamato il quarto
Carme del Servo di Jahvé, contenuto nel Libro di Isaia. Il
profeta, che giustamente viene chiamato « il quinto evangelista »,
presenta in questo Carme l'immagine delle sofferenze del Servo con un
realismo così acuto quasi le vedesse con i propri occhi: con gli
occhi del corpo e dello spirito. La passione di Cristo diventa, alla
luce dei versetti di Isaia, quasi ancora più espressiva e toccante
che non nelle descrizioni degli stessi evangelisti. Ecco, si presenta
davanti a noi il vero Uomo dei dolori:
« Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi...
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia,
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori,
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l'iniquità di noi tutti »(41).
Il Carme del Servo sofferente
contiene una descrizione nella quale si possono, in un certo senso,
identificare i momenti della passione di Cristo in vari loro
particolari: l'arresto, l'umiliazione, gli schiaffi, gli sputi, il
vilipendio della dignità stessa del prigioniero, l'ingiusto giudizio,
e poi la flagellazione, la coronazione di spine e lo scherno, il
cammino con la croce, la crocifissione, l'agonia.
Più ancora di questa descrizione
della passione ci colpisce nelle parole del profeta la profondità
del sacrificio di Cristo. Ecco, egli, benché innocente, si
addossa le sofferenze di tutti gli uomini, perché si addossa i
peccati di tutti. « Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di
tutti »: tutto il peccato dell'uomo nella sua estensione e profondità
diventa la vera causa della sofferenza del Redentore. Se la sofferenza
« viene misurata » col male sofferto, allora le parole del profeta
ci permettono di comprendere la misura di questo male e di
questa sofferenza, di cui Cristo si è caricato. Si può dire che
questa è sofferenza « sostitutiva »; soprattutto, però, essa è «
redentiva ». L'Uomo dei dolori di quella profezia è veramente quell'«
agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo »(42). Nella sua
sofferenza i peccati vengono cancellati proprio perché egli solo come
Figlio unigenito poté prenderli su di sé, assumerli con quell'amore
verso il Padre che supera il male di ogni peccato; in un certo
senso annienta questo male nello spazio spirituale dei rapporti tra
Dio e l'umanità, e riempie questo spazio col bene.
Tocchiamo qui la dualità di
natura di un unico soggetto personale della sofferenza redentiva.
Colui, che con la sua passione e morte sulla Croce opera la
Redenzione, è il Figlio unigenito che Dio « ha dato ». E nello
stesso tempo questo Figlio consostanziale al Padre soffre come
uomo. La sua sofferenza ha dimensioni umane, ha anche — uniche
nella storia dell'umanità — una profondità ed intensità che, pur
essendo umane, possono essere anche incomparabili profondità ed
intensità di sofferenza, in quanto l'Uomo che soffre è in persona lo
stesso Figlio unigenito: « Dio da Dio ». Dunque, soltanto Lui — il
Figlio unigenito — è capace di abbracciare la misura del male
contenuta nel peccato dell'uomo: in ogni peccato e nel peccato «
totale », secondo le dimensioni dell'esistenza storica dell'umanità
sulla terra.
18. Si può dire che le suddette
considerazioni ci conducono ormai direttamente al Getsemani e sul
Golgota, dove si è adempiuto il Carme del Servo sofferente, contenuto
nel Libro d'Isaia. Ancora prima di andarvi, leggiamo i successivi
versetti del Carme, che dànno un'anticipazione profetica della
passione del Getsemani e del Golgota. Il Servo sofferente — e questo
a sua volta è essenziale per un'analisi della passione di Cristo —
si addossa quelle sofferenze, di cui si è detto, in modo
del tutto volontario:
« Maltrattato, si lasciò
umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza
fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua sorte?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede la sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza,
né vi fosse inganno nella sua bocca »(43).
Cristo soffre volontariamente e
soffre innocentemente. Accoglie
con la sua sofferenza quell'interrogativo, che — posto molte volte
dagli uomini — è stato espresso, in un certo senso, in modo
radicale dal Libro di Giobbe. Cristo, tuttavia, non solo porta con sé
la stessa domanda (e ciò in modo ancor più radicale, poiché egli
non è solo un uomo come Giobbe, ma è l'unigenito Figlio di Dio), ma
porta anche il massimo della possibile risposta a questo
interrogativo. La risposta emerge, si può dire, dalla stessa
materia, di cui è costituita la domanda. Cristo dà la risposta
all'interrogativo sulla sofferenza e sul senso della sofferenza non
soltanto col suo insegnamento, cioè con la Buona Novella, ma prima di
tutto con la propria sofferenza, che con un tale insegnamento della
Buona Novella è integrata in modo organico ed indissolubile. E questa
è l'ultima, sintetica parola di questo insegnamento: «
la parola della Croce », come dirà un giorno San Paolo(44).
Questa « parola della Croce »
riempie di una realtà definitiva l'immagine dell'antica profezia.
Molti luoghi, molti discorsi durante l'insegnamento pubblico di Cristo
testimoniano come egli accetti sin dall'inizio questa sofferenza, che
è la volontà del Padre per la salvezza del mondo. Tuttavia, un punto
definitivo diventa qui la preghiera nel Getsemani. Le parole:
« Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non
come voglio io, ma come vuoi tu! »(45), e in seguito: « Padre mio,
se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia
fatta la tua volontà »(46), hanno una multiforme eloquenza. Esse
provano la verità di quell'amore, che il Figlio unigenito dà al
Padre nella sua obbedienza. Al tempo stesso, attestano la verità
della sua sofferenza. Le parole della preghiera di Cristo al Getsemani
provano la verità dell'amore mediante la verità della sofferenza.
Le parole di Cristo confermano con tutta semplicità questa umana
verità della sofferenza, fino in fondo: la sofferenza è un subire il
male, davanti al quale l'uomo rabbrividisce. Egli dice: « passi da me
», proprio così, come dice Cristo nel Getsemani.
Le sue parole attestano insieme
quest'unica ed incomparabile profondità ed intensità della
sofferenza, che poté sperimentare solamente l'Uomo che è il Figlio
unigenito. Esse attestano quella profondità ed intensità, che
le parole profetiche sopra riportate aiutano, a loro modo, a capire:
non certo fino in fondo (per questo si dovrebbe penetrare il mistero
divino-umano del Soggetto), ma almeno a percepire quella differenza (e
somiglianza insieme) che si verifica tra ogni possibile sofferenza
dell'uomo e quella del Dio-Uomo. Il Getsemani è il luogo, nel quale
appunto questa sofferenza, in tutta la verità espressa dal profeta
circa il male in essa provato, si è rivelata quasi definitivamente
davanti agli occhi dell'anima di Cristo.
Dopo le parole nel Getsemani
vengono le parole pronunciate sul Golgota, che testimoniano questa
profondità — unica nella storia del mondo — del male della
sofferenza che si prova. Quando Cristo dice: « Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato? », le sue parole non sono solo
espressione di quell'abbandono che più volte si faceva sentire
nell'Antico Testamento, specialmente nei Salmi e, in particolare, in
quel Salmo 22 [21], dal quale provengono le parole citate(47). Si può
dire che queste parole sull'abbandono nascono sul piano
dell'inseparabile unione del Figlio col Padre, e nascono perché il
Padre « fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti » (48) è
sulla traccia di ciò che dirà San Paolo: « Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore »(49).
Insieme con questo orribile peso, misurando « l'intero » male di
voltare le spalle a Dio, contenuto nel peccato, Cristo, mediante
la divina profondità dell'unione filiale col Padre, percepisce in
modo umanamente inesprimibile questa sofferenza che è il distacco,
la ripulsa del Padre, la rottura con Dio. Ma proprio
mediante tale sofferenza egli compie la Redenzione, e può dire
spirando: « Tutto è compiuto »(50).
Si può anche dire che si è
adempiuta la Scrittura, che sono state definitivamente attuate nella
realtà le parole di detto Carme del Servo sofferente: « Al Signore
è piaciuto prostrarlo con dolori »(51). L'umana sofferenza ha
raggiunto il suo culmine nella passione di Cristo. E
contemporaneamente essa è entrata in una dimensione completamente
nuova e in un nuovo ordine: è stata legata all'amore, a quell'amore
del quale Cristo parlava a Nicodemo, a quell'amore che crea il bene
ricavandolo anche dal male, ricavandolo per mezzo della sofferenza,
così come il bene supremo della redenzione del mondo è stato tratto
dalla Croce di Cristo, e costantemente prende da essa il suo avvio. La
Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale sgorgano fiumi
d'acqua viva(52). In essa dobbiamo anche riproporre l'interrogativo
sul senso della sofferenza, e leggervi sino alla fine la risposta a
questo interrogativo.
V
PARTECIPI
DELLE SOFFERENZE DI CRISTO
19. Il medesimo Carme del Servo
sofferente nel Libro di Isaia ci conduce, attraverso i versetti
successivi, proprio nella direzione di questo interrogativo e di
questa risposta:
« Quando offrirà se stesso in
espiazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza,
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha consegnato se stesso alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori »(53).
Si può dire che insieme con la
passione di Cristo ogni sofferenza umana si è trovata in una nuova
situazione. Ed è come se Giobbe l'avesse presentita, quando diceva:
« Io so infatti che il mio Redentore vive... »(54), e come se avesse
indirizzato verso di essa la propria sofferenza, la quale senza la
redenzione non avrebbe potuto rivelargli la pienezza del suo
significato. Nella Croce di Cristo non solo si è compiuta la
redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza
umana è stata redenta. Cristo — senza nessuna colpa propria —
si è addossato « il male totale del peccato ». L'esperienza di
questo male determinò l'incomparabile misura della sofferenza di
Cristo, che diventò il prezzo della redenzione. Di questo
parla il Carme del Servo sofferente in Isaia. A loro tempo, di questo
parleranno i testimoni della Nuova Alleanza, stipulata nel sangue di
Cristo. Ecco le parole dell'apostolo Pietro dalla sua prima Lettera:
« Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e
l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri
padri, ma col sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza
difetti e senza macchia »(55). E l'apostolo Paolo nella Lettera ai
Galati dirà: « Ha dato se stesso per i nostri peccati, per
strapparci da questo mondo perverso »(56), e nella prima Lettera ai
Corinzi: « Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo! »(57).
Con queste ed altre simili parole
i testimoni della Nuova Alleanza parlano della grandezza della
redenzione, che si è compiuta mediante la sofferenza di Cristo. Il
Redentore ho sofferto al posto dell'uomo e per l'uomo. Ogni uomo ha una
sua partecipazione alla redenzione. Ognuno è anche chiamato a
partecipare a quella sofferenza, mediante la quale si è compiuta
la redenzione. E' chiamato a partecipare a quella sofferenza, per
mezzo della quale ogni umana sofferenza è stata anche redenta.
Operando la redenzione mediante la sofferenza, Cristo ha elevato insieme
la sofferenza umana a livello di redenzione. Quindi anche ogni
uomo, nella sua sofferenza, può diventare partecipe della sofferenza
redentiva di Cristo.
20. I testi del Nuovo Testamento
esprimono in molti punti questo concetto. Nella seconda Lettera ai
Corinzi l'Apostolo scrive: « Siamo infatti tribolati da ogni parte,
ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati,
ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e
dappertutto nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche
la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi
che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché
anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale...,
convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà
anche noi con Gesù »(58).
San Paolo parla delle diverse
sofferenze e, in particolare, di quelle di cui diventavano partecipi i
primi cristiani « a causa di Gesù ». Queste sofferenze permettono
ai destinatari di quella Lettera di partecipare all'opera della
redenzione, compiuta mediante le sofferenze e la morte del Redentore. L'eloquenza
della Croce e della morte viene tuttavia completata con l'eloquenza
della risurrezione. L'uomo trova nella risurrezione una luce
completamente nuova, che lo aiuta a farsi strada attraverso il fitto
buio delle umiliazioni, dei dubbi, della disperazione e della
persecuzione. Perciò, l'Apostolo scriverà anche nella seconda
Lettera ai Corinzi: « Infatti, come abbondano le sofferenze di
Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra
consolazione »(59).
Altrove egli si rivolge ai suoi
destinatari con parole d'incoraggiamento: « Il Signore diriga i
vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo »(60). E
nella Lettera ai Romani scrive: « Vi esorto dunque, fratelli, per la
misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio: è questo il vostro culto
spirituale »(61).
La partecipazione stessa alla
sofferenza di Cristo trova, in queste espressioni apostoliche, quasi
una duplice dimensione. Se un uomo diventa partecipe delle sofferenze
di Cristo, ciò avviene perché Cristo ha aperto la sua sofferenza
all'uomo, perché egli stesso nella sua sofferenza redentiva è
divenuto, in un certo senso, partecipe di tutte le sofferenze umane.
L'uomo, scoprendo mediante la fede la sofferenza redentrice di Cristo,
insieme scopre in essa le proprie sofferenze, le ritrova, mediante
la fede, arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo
significato.
Questa scoperta dettò a San Paolo
parole particolarmente forti nella Lettera ai Galati: « Sono stato
crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me »(62). La
fede permette all'autore di queste parole di conoscere quell'amore,
che condusse Cristo sulla Croce. E se amò così, soffrendo e morendo,
allora con questa sua sofferenza e morte egli vive in colui che amò
così, egli vive nell'uomo: in Paolo. E vivendo in lui — man
mano che Paolo, consapevole di ciò mediante la fede, risponde con
l'amore al suo amore — Cristo diventa anche in modo particolare unito
all'uomo, a Paolo, mediante la Croce. Quest'unione ha
dettato a Paolo, nella stessa Lettera ai Galati, ancora altre parole,
non meno forti: « Quanto a me invece, non ci sia altro vanto che
nella Croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo »(63).
21. La Croce di Cristo getta in
modo tanto penetrante la luce salvifica sulla vita dell'uomo e, in
particolare, sulla sua sofferenza, perché mediante la fede lo
raggiunge insieme con la risurrezione: il mistero della
passione è racchiuso nel mistero pasquale. I testimoni della passione
di Cristo sono contemporaneamente testimoni della sua risurrezione.
Scrive Paolo: « Perché io possa conoscere lui (Cristo), la potenza
della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze,
diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla
risurrezione dai morti »(64). Veramente, l'Apostolo prima sperimentò
« la potenza della risurrezione » di Cristo sulla via di Damasco, e
solo in seguito, in questa luce pasquale, giunse a quella «
partecipazione alle sue sofferenze », della quale parla, ad esempio,
nella Lettera ai Galati. La via di Paolo è chiaramente pasquale: la
partecipazione alla Croce di Cristo avviene attraverso
l'esperienza del Risorto, dunque mediante una speciale
partecipazione alla risurrezione. Perciò, anche nelle espressioni
dell'Apostolo sul tema della sofferenza appare così spesso il motivo
della gloria, alla quale la Croce di Cristo dà inizio.
I testimoni della Croce e della
risurrezione erano convinti che « è necessario attraversare molte
tribolazioni per entrare nel Regno di Dio »(65). E Paolo, scrivendo
ai Tessalonicesi, dice così: « Possiamo gloriarci di voi ... per la
vostra fermezza e per la vostra fede in tutte le persecuzioni e
tribolazioni che sopportate. Questo è un segno del giusto giudizio di
Dio, che vi proclamerà degni di quel Regno di Dio, per il
quale ora soffrite »(66). Così dunque la partecipazione alle
sofferenze di Cristo è, al tempo stesso, sofferenza per il Regno di
Dio. Agli occhi del Dio giusto, di fronte al suo giudizio, quanti
partecipano alle sofferenze di Cristo diventano degni di questo Regno.
Mediante le loro sofferenze essi, in un certo senso, restituiscono
l'infinito prezzo della passione e della morte di Cristo, che divenne
il prezzo della nostra redenzione: a questo prezzo il Regno di Dio è
stato nuovamente consolidato nella storia dell'uomo, divenendo la
prospettiva definitiva della sua esistenza terrena. Cristo ci ha
introdotti in questo Regno mediante la sua sofferenza. E anche
mediante la sofferenza maturano per esso gli uomini avvolti dal
mistero della redenzione di Cristo.
22. Alla prospettiva del Regno di
Dio è unita la speranza di quella gloria, il cui inizio si trova
nella Croce di Cristo. La risurrezione ha rivelato questa gloria —
la gloria escatologica — che nella Croce di Cristo era completamente
offuscata dall'immensità della sofferenza. Coloro che sono partecipi
delle sofferenze di Cristo sono anche chiamati, mediante le loro
proprie sofferenze, a prender parte alla gloria. Paolo esprime
questo in diversi punti. Scrive ai Romani: « Siamo ... coeredi di
Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare
anche alla sua gloria. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del
momento presente non sono paragonabili alla gloria futura, che dovrà
essere rivelata in noi »(67). Nella seconda Lettera ai Corinzi
leggiamo: « Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra
tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria,
perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle
invisibili »(68). L'apostolo Pietro esprimerà questa verità nelle
seguenti parole della sua prima Lettera: « Nella misura in cui
partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche
nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare »(69).
Il motivo della sofferenza e
della gloria ha la sua caratteristica strettamente evangelica, che
si chiarisce mediante il riferimento alla Croce ed alla risurrezione.
La risurrezione è diventata prima di tutto la manifestazione della
gloria, che corrisponde all'elevazione di Cristo per mezzo della
Croce. Se, infatti, la Croce è stata agli occhi degli uomini lo
spogliamento di Cristo, nello stesso tempo essa è stata agli
occhi di Dio la sua elevazione. Sulla Croce Cristo ha raggiunto
e realizzato in tutta pienezza la sua missione: compiendo la volontà
del Padre, realizzò insieme se stesso. Nella debolezza manifestò la
sua potenza, e nell'umiliazione tutta la sua grandezza
messianica. Non sono forse una prova di questa grandezza tutte le
parole pronunciate durante l'agonia sul Golgota e, specialmente,
quelle riguardanti gli autori della crocifissione: « Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fanno »?(70) A coloro che
sono partecipi delle sofferenze di Cristo queste parole si impongono
con la forza di un supremo esempio. La sofferenza è anche una
chiamata a manifestare la grandezza morale dell'uomo, la sua maturità
spirituale. Di ciò hanno dato la prova, nelle diverse
generazioni, i martiri ed i confessori di Cristo, fedeli alle parole:
« E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l'anima »(71).
La risurrezione di Cristo ha
rivelato « la gloria del secolo futuro » e, contemporaneamente, ha
confermato « il vanto della Croce »: quella gloria che è
contenuta nella sofferenza stessa di Cristo, e quale molte volte
si è rispecchiata e si rispecchia nella sofferenza dell'uomo, come
espressione della sua spirituale grandezza. Bisogna dare testimonianza
di questa gloria non solo ai martiri della fede, ma anche a numerosi
altri uomini, che a volte, pur senza la fede in Cristo, soffrono e
danno la vita per la verità e per una giusta causa. Nelle sofferenze
di tutti costoro viene confermata in modo particolare la grande dignità
dell'uomo.
23. La sofferenza, infatti, è
sempre una prova — a volte una prova alquanto dura —, alla
quale viene sottoposta l'umanità. Dalle pagine delle Lettere di San
Paolo più volte parla a noi quel paradosso evangelico della
debolezza e della forza, sperimentato in modo particolare
dall'Apostolo stesso e che insieme con lui provano tutti coloro che
partecipano alle sofferenze di Cristo. Egli scrive nella seconda
Lettera ai Corinzi: « Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo »(72). Nella
seconda Lettera a Timoteo leggiamo: « E' questa la causa dei mali che
soffro, ma non me ne vergogno: so infatti a chi ho creduto »(73). E
nella Lettera ai Filippesi dirà addirittura: « Tutto posso in
colui che mi dà la forza »(74).
Coloro che sono partecipi delle
sofferenze di Cristo hanno davanti agli occhi il mistero pasquale
della Croce e della risurrezione, nel quale Cristo discende, in una
prima fase, sino agli ultimi confini della debolezza e dell'impotenza
umana: egli, infatti, muore inchiodato sulla Croce. Ma se al tempo
stesso in questa debolezza si compie la sua elevazione, confermata
con la forza della risurrezione, ciò significa che le debolezze di
tutte le sofferenze umane possono essere permeate dalla stessa potenza
di Dio, quale si è manifestata nella Croce di Cristo. In questa
concezione soffrire significa diventare particolarmente suscettibili,
particolarmente aperti all'opera delle forze salvifiche di Dio,
offerte all'umanità in Cristo. In lui Dio ha confermato di voler
agire specialmente per mezzo della sofferenza, che è la debolezza e
lo spogliamento dell'uomo, e di voler proprio in questa debolezza e in
questo spogliamento manifestare la sua potenza. Con ciò si può anche
spiegare la raccomandazione della prima Lettera di Pietro: « Ma se
uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi anzi Dio per
questo nome »(75).
Nella Lettera ai Romani l'apostolo
Paolo si pronuncia ancora più ampiamente sul tema di questo «
nascere della forza nella debolezza », di questo ritemprarsi
spirituale dell'uomo in mezzo alle prove e alle tribolazioni, che
è la speciale vocazione di coloro che sono partecipi delle sofferenze
di Cristo: « Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo
che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e
la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché
l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo, che ci è stato dato »(76). Nella sofferenza è come
contenuta una particolare chiamata alla virtù, che l'uomo deve
esercitare da parte sua. E questa è la virtù della perseveranza nel
sopportare ciò che disturba e fa male. L'uomo, così facendo,
sprigiona la speranza, che mantiene in lui la convinzione che la
sofferenza non prevarrà sopra di lui, non lo priverà della dignità
propria dell'uomo unita alla consapevolezza del senso della vita. Ed
ecco, questo senso si manifesta insieme con l'opera dell'amore di
Dio, che è il dono supremo dello Spirito Santo. Man mano che
partecipa a questo amore, l'uomo si ritrova fino in fondo nella
sofferenza: ritrova « l'anima », che gli sembrava di aver « perduto
»(77) a causa della sofferenza.
24. Tuttavia, le esperienze
dell'Apostolo, partecipe delle sofferenze di Cristo, vanno ancora
oltre. Nella Lettera ai Colossesi leggiamo le parole, che
costituiscono quasi l'ultima tappa dell'itinerario spirituale in
relazione alla sofferenza. San Paolo scrive: « Perciò sono lieto
delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia
carne quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore del
suo corpo che è la Chiesa »(78). Ed egli in un'altra Lettera
interroga i suoi destinatari: « Non sapete che i vostri corpi sono
membra di Cristo? »(79).
Nel mistero pasquale Cristo ha
dato inizio all'unione con l'uomo nella comunità della Chiesa. Il
mistero della Chiesa si esprime in questo: che già all'atto del
Battesimo, che configura a Cristo, e poi mediante il suo Sacrificio
— sacramentalmente mediante l'Eucaristia — la Chiesa di continuo
si edifica spiritualmente come corpo di Cristo. In questo corpo Cristo
vuole essere unito con tutti gli uomini, ed in modo particolare egli
è unito con coloro che soffrono. Le citate parole della Lettera ai
Colossesi attestano l'eccezionale carattere di questa unione. Ecco,
infatti, colui che soffre in unione con Cristo — come in
unione con Cristo sopporta le sue « tribolazioni » l'apostolo Paolo
— non solo attinge da Cristo quella forza, della quale si è parlato
precedentemente, ma anche « completa » con la sua sofferenza «
quello che manca ai patimenti di Cristo ». In questo quadro
evangelico è messa in risalto, in modo particolare, la verità sul
carattere creativo della sofferenza. La sofferenza di Cristo ha
creato il bene della redenzione del mondo. Questo bene in se stesso è
inesauribile ed infinito. Nessun uomo può aggiungervi qualcosa. Allo
stesso tempo, però, nel mistero della Chiesa come suo corpo, Cristo
in un certo senso ha aperto la propria sofferenza redentiva ad ogni
sofferenza dell'uomo. In quanto l'uomo diventa partecipe delle
sofferenze di Cristo — in qualsiasi luogo del mondo e tempo della
storia —, in tanto egli completa a suo modo quella
sofferenza, mediante la quale Cristo ha operato la redenzione del
mondo.
Questo vuol dire, forse, che la
redenzione compiuta da Cristo non è completa? No. Questo significa
solo che la redenzione, operata in forza dell'amore soddisfattorio,
rimane costantemente aperta ad ogni amore che si esprime nell'umana
sofferenza. In questa dimensione — nella dimensione dell'amore
— la redenzione già compiuta fino in fondo, si compie, in un certo
senso, costantemente. Cristo ha operato la redenzione completamente e
sino alla fine; al tempo stesso, però, non l'ha chiusa: in questa
sofferenza redentiva, mediante la quale si è operata la redenzione
del mondo, Cristo si è aperto sin dall'inizio, e costantemente si
apre, ad ogni umana sofferenza. Sì, sembra far parte dell'essenza
stessa della sofferenza redentiva di Cristo il fatto che essa
richieda di essere incessantemente completata.
In questo modo, con una tale
apertura ad ogni umana sofferenza, Cristo ha operato con la propria
sofferenza la redenzione del mondo. Infatti, al tempo stesso, questa
redenzione, anche se compiuta in tutta la pienezza con la sofferenza
di Cristo, vive e si sviluppa a suo modo nella storia dell'uomo. Vive
e si sviluppa come corpo di Cristo, che è la Chiesa, ed in questa
dimensione ogni umana sofferenza, in forza dell'unione nell'amore con
Cristo, completa la sofferenza di Cristo. La completa così come la
Chiesa completa l'opera redentrice di Cristo. Il mistero della
Chiesa — di quel corpo che completa in sé anche il corpo crocifisso
e risorto di Cristo — indica contemporaneamente quello spazio, nel
quale le sofferenze umane completano le sofferenze di Cristo. Solo in
questo raggio e in questa dimensione della Chiesa-corpo di Cristo, che
continuamente si sviluppa nello spazio e nel tempo, si può pensare e
parlare di « ciò che manca » ai patimenti di Cristo. L'Apostolo,
del resto, lo mette chiaramente in rilievo, quando scrive del
completamento di « quello che manca ai patimenti di Cristo, in favore
del suo corpo che è la Chiesa ».
Proprio la Chiesa, che
attinge incessantemente alle infinite risorse della redenzione,
introducendola nella vita dell'umanità, è la dimensione, nella
quale la sofferenza redentrice di Cristo può essere costantemente
completata dalla sofferenza dell'uomo. In ciò vien messa in risalto
anche la natura divino-umana della Chiesa. La sofferenza sembra
partecipare in un qualche modo alle caratteristiche di questa natura.
E perciò essa ha pure un valore speciale davanti alla Chiesa. Essa è
un bene, dinanzi al quale la Chiesa si inchina con venerazione, in
tutta la profondità della sua fede nella redenzione. Si inchina,
insieme, in tutta la profondità di quella fede, con la quale essa
abbraccia in se stessa l'inesprimibile mistero del corpo di Cristo.
VI
IL
VANGELO DELLA SOFFERENZA
25. I testimoni della Croce e
della risurrezione di Cristo hanno trasmesso alla Chiesa e all'umanità
uno specifico Vangelo della sofferenza. Il Redentore stesso ha scritto
questo Vangelo dapprima con la propria sofferenza assunta per amore,
affinché l'uomo « non muoia, ma abbia la vita eterna »(80). Questa
sofferenza, insieme con la viva parola del suo insegnamento, è
diventata una fonte abbondante per tutti coloro che hanno preso parte
alle sofferenze di Gesù nella prima generazione dei suoi discepoli e
confessori, e poi in quelle che si sono succedute nel corso dei
secoli.
E', innanzitutto, consolante —
come è evangelicamente e storicamente esatto — notare che a fianco
di Cristo, in primissima e ben rilevata posizione accanto a lui, c'è
sempre la sua Madre santissima per la testimonianza esemplare, che con
l'intera sua vita rende a questo particolare Vangelo della
sofferenza. In lei le numerose ed intense sofferenze si assommarono in
una tale connessione e concatenazione, che se furono prova della sua
fede incrollabile, furono altresì un contributo alla redenzione di
tutti. In realtà, fin dall'arcano colloquio avuto con l'angelo, Ella
intravide nella sua missione di madre la « destinazione » a
condividere in maniera unica ed irripetibile la missione stessa del
Figlio. E la conferma in proposito le venne assai presto sia dagli
eventi che accompagnarono la nascita di Gesù a Betlemme, sia
dall'annuncio formale del vecchio Simeone che parlò di una spada
tanto acuta da trapassarle l'anima, sia dalle ansie e ristrettezze
della fuga precipitosa in Egitto, provocata dalla crudele decisione di
Erode.
Ed ancora, dopo le vicende della
vita nascosta e pubblica del suo Figlio, da lei indubbiamente
condivise con acuta sensibilità, fu sul Calvario che la sofferenza di
Maria Santissima, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice già
difficilmente immaginabile nella sua altezza dal punto di vista umano,
ma certo misterioso e soprannaturalmente fecondo ai fini
dell'universale salvezza. Quel suo ascendere al Calvario, quel suo «
stare » ai piedi della Croce insieme col discepolo prediletto furono
una partecipazione del tutto speciale alla morte redentrice del
Figlio, come del resto le parole, che poté raccogliere dal suo
labbro, furono quasi la solenne consegna di questo tipico Vangelo da
annunciare all'intera comunità dei credenti.
Testimone della passione del
Figlio con la sua presenza, e di essa partecipe con la sua compassione,
Maria Santissima offrì un singolare apporto al Vangelo della
sofferenza, awerando in anticipo l'espressione paolina, riportata
all'inizio. In effetti, Ella ha titoli specialissimi per poter
asserire di « completare nella sua carne — come già nel suo cuore
— quello che manca ai patimenti di Cristo ».
Nella luce dell'inarrivabile
esempio di Cristo, riflesso con singolare evidenza nella vita della
Madre sua, il Vangelo della sofferenza, mediante l'esperienza e la
parola degli Apostoli, diventa fonte inesauribile per le
generazioni sempre nuove che si avvicendano nella storia della
Chiesa. Il Vangelo della sofferenza significa non solo la presenza
della sofferenza nel Vangelo, come uno dei temi della Buona Novella,
ma la rivelazione, altresì, della forza salvifica e del
significato salvifico della sofferenza nella missione messianica
di Cristo e, in seguito, nella missione e nella vocazione della
Chiesa.
Cristo non nascondeva ai
propri ascoltatori la necessità della sofferenza. Molto
chiaramente diceva: « Se qualcuno vuol venire dietro a me, ... prenda
la sua croce ogni giorno »(81), ed ai suoi discepoli poneva esigenze
di natura morale, la cui realizzazione è possibile solo a condizione
di « rinnegare se stessi »(82). La via che porta al Regno dei cieli
è « stretta ed angusta », e Cristo la contrappone alla via « larga
e spaziosa », che peraltro « conduce alla perdizione »(83). Diverse
volte Cristo diceva anche che i suoi discepoli e confessori avrebbero incontrato
molteplici persecuzioni, ciò che — come si sa — è avvenuto
non solo nei primi secoli della vita della Chiesa sotto l'impero
romano, ma si è avverato e si avvera in diversi periodi della storia
e in differenti luoghi della terra, anche ai nostri tempi.
Ecco alcune frasi di Cristo su
questo tema: « Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a
re e a governatori, a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di
rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare
prima la vostra difesa: io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i
vostri avversari non potranno resistere, né controbattere. Sarete
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici,
e metteranno a morte alcuni di voi; sarete odiati da tutti per
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà.
Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime »(84).
Il Vangelo della sofferenza parla
prima in diversi punti della sofferenza « per Cristo », « a causa
di Cristo », e ciò fa con le parole stesse di Gesù, oppure con le
parole dei suoi Apostoli. Il Maestro non nasconde ai suoi discepoli e
seguaci la prospettiva di una tale sofferenza, anzi la rivela con
tutta franchezza, indicando contemporaneamente le forze
soprannaturali, che li accompagneranno in mezzo alle persecuzioni e
tribolazioni « per il suo nome ». Queste saranno insieme quasi una
speciale verifica della somiglianza a Cristo e dell'unione con
lui. « Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me
...; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo,
per questo il mondo vi odia ... Un servo non è più grande del suo
padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi... Ma
tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono
colui che mi ha mandato »(85). « Vi ho dette queste cose, perché
abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate
fiducia: io ho vinto il mondo! »(86).
Questo primo capitolo del Vangelo
della sofferenza, che parla delle persecuzioni, cioè delle
tribolazioni a motivo di Cristo, contiene in sé una speciale
chiamata al coraggio ed alla fortezza, sostenuta dall'eloquenza
della risurrezione. Cristo ha vinto il mondo definitivamente con la
sua risurrezione; tuttavia, grazie al rapporto di essa con la passione
e la morte, ha vinto al tempo stesso questo mondo con la sua
sofferenza. Si, la sofferenza è stata in modo singolare inserita in
quella vittoria sul mondo, che si è manifestata nella risurrezione.
Cristo conserva nel suo corpo risorto i segni delle ferite della Croce
sulle sue mani, sui piedi e nel costato. Mediante la risurrezione egli
manifesta la forza vittoriosa della sofferenza, e vuole
infondere la convinzione di questa forza nel cuore di coloro che ha
scelto come suoi Apostoli e di coloro che continuamente sceglie ed
invia. L'apostolo Paolo dirà: « Tutti quelli che vogliono vivere
piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati »(87).
26. Se il primo grande capitolo
del Vangelo della sofferenza viene scritto, lungo le generazioni, da
coloro che soffrono persecuzioni per Cristo, di pari passo si svolge
lungo la storia un altro grande capitolo di questo Vangelo. Lo
scrivono tutti coloro che soffrono insieme con Cristo, unendo
le proprie sofferenze umane alla sua sofferenza salvifica. In essi si
compie ciò che i primi testimoni della passione e della risurrezione
hanno detto ed hanno scritto circa la partecipazione alle sofferenze
di Cristo. In essi quindi si compie il Vangelo della sofferenza e, al
tempo stesso, ognuno di essi continua in un certo modo a scriverlo: lo
scrive e lo proclama al mondo, lo annuncia al proprio ambiente ed agli
uomini contemporanei.
Attraverso i secoli e le
generazioni è stato costatato che nella sofferenza si nasconde una
particolare forza che avvicina interiormente l'uomo a
Cristo, una particolare grazia. Ad essa debbono la loro profonda
conversione molti Santi, come ad esempio San Francesco d'Assisi, Sant'Ignazio
di Loyola, ecc. Frutto di una tale conversione non è solo il fatto
che l'uomo scopre il senso salvifico della sofferenza, ma soprattutto
che nella sofferenza diventa un uomo completamente nuovo. Egli trova
quasi una nuova misura di tutta la propria vita e della
propria vocazione. Questa scoperta è una particolare conferma
della grandezza spirituale che nell'uomo supera il corpo in modo del
tutto incomparabile. Allorché questo corpo è profondamente malato,
totalmente inabile e l'uomo è quasi incapace di vivere e di agire,
tanto più si mettono in evidenza l'interiore maturità e grandezza
spirituale, costituendo una commovente lezione per gli uomini sani
e normali.
Questa interiore maturità e
grandezza spirituale nella sofferenza certamente sono frutto di
una particolare conversione e cooperazione con la Grazia del
Redentore crocifisso. E' lui stesso ad agire nel vivo delle umane
sofferenze per mezzo del suo Spirito di verità, per mezzo dello
Spirito Consolatore. E' lui a trasformare, in un certo senso, la
sostanza stessa della vita spirituale, indicando all'uomo sofferente
un posto vicino a sé. E' lui — come Maestro e Guida interiore — ad
insegnare al fratello e alla sorella sofferenti questo mirabile
scambio, posto nel cuore stesso del mistero della redenzione. La
sofferenza è, in se stessa, un provare il male. Ma Cristo ne ha fatto
la più solida base del bene definitivo, cioè del bene della salvezza
eterna. Con la sua sofferenza sulla Croce Cristo ha raggiunto le
radici stesse del male: del peccato e della morte. Egli ha vinto
l'artefice del male, che è Satana, e la sua permanente ribellione
contro il Creatore. Davanti al fratello o alla sorella sofferenti
Cristo dischiude e dispiega gradualmente gli orizzonti del
Regno di Dio: di un mondo convertito al Creatore, di un mondo
liberato dal peccato, che si sta edificando sulla potenza salvifica
dell'amore. E, lentamente ma efficacemente, Cristo introduce in questo
mondo, in questo Regno del Padre l'uomo sofferente, in un certo senso
attraverso il cuore stesso della sua sofferenza. La sofferenza,
infatti, non può essere trasformata e mutata con una grazia
dall'esterno, ma dall'interno. E Cristo mediante la sua propria
sofferenza salvifica si trova quanto mai dentro ad ogni sofferenza
umana, e può agire dall'interno di essa con la potenza del suo
Spirito di verità, del suo Spirito Consolatore.
Non basta: il divin Redentore
vuole penetrare nell'animo di ogni sofferente attraverso il cuore
della sua Madre santissima, primizia e vertice di tutti i redenti.
Quasi a continuazione di quella maternità, che per opera dello
Spirito Santo gli aveva dato la vita, Cristo morente conferì alla
sempre Vergine Maria una maternità nuova — spirituale e
universale — verso tutti gli uomini, affinché ognuno, nella
peregrinazione della fede, gli rimanesse insieme con lei strettamente
unito fino alla Croce e, con la forza di questa Croce, ogni sofferenza
rigenerata diventasse, da debolezza dell'uomo, potenza di Dio.
Non sempre, però, un tale
processo interiore si svolge in modo uguale. Spesso inizia e si
instaura con difficoltà. Già il punto stesso di partenza è diverso:
diversa è la disposizione, che l'uomo porta nella sua sofferenza. Si
può, tuttavia, premettere che quasi sempre ciascuno entra nella
sofferenza con una protesta tipicamente umana e con la
domanda del suo « perché ». Ciascuno si chiede il senso della
sofferenza e cerca una risposta a questa domanda al suo livello umano.
Certamente pone più volte questa domanda anche a Dio, come la pone a
Cristo. Inoltre, egli non può non notare che colui, al quale pone la
sua domanda, soffre lui stesso e vuole rispondergli dalla
Croce, dal centro della sua propria sofferenza. Tuttavia, a
volte c'è bisogno di tempo, persino di un lungo tempo, perché questa
risposta cominci ad essere internamente percepibile. Cristo, infatti,
non risponde direttamente e non risponde in astratto a questo
interrogativo umano circa il senso della sofferenza. L'uomo ode la sua
risposta salvifica man mano che egli stesso diventa partecipe delle
sofferenze di Cristo.
La risposta che giunge mediante
tale partecipazione, lungo la strada dell'incontro interiore col
Maestro, è a sua volta qualcosa di più della sola risposta
astratta all'interrogativo sul senso della sofferenza. Questa è,
infatti, soprattutto una chiamata. E' una vocazione. Cristo non spiega
in astratto le ragioni della sofferenza, ma prima di tutto dice: «
Seguimi! ». Vieni! prendi parte con la tua sofferenza a quest'opera
di salvezza del mondo, che si compie per mezzo della mia sofferenza!
Per mezzo della mia Croce. Man mano che l'uomo prende la sua croce,
unendosi spiritualmente alla Croce di Cristo, si rivela davanti a
lui il senso salvifico della sofferenza. L'uomo non scopre questo
senso al suo livello umano, ma al livello della sofferenza di Cristo.
Al tempo stesso, però, da questo livello di Cristo, quel senso
salvifico della sofferenza scende a livello dell'uomo e
diventa, in qualche modo, la sua risposta personale. E allora l'uomo
trova nella sua sofferenza la pace interiore e perfino la gioia
spirituale.
27. Di tale gioia parla l'Apostolo
nella Lettera ai Colossesi: « Sono lieto delle sofferenze che
sopporto per voi »(88). Fonte di gioia diventa il superamento del
senso d'inutilità della sofferenza, sensazione che a volte è
radicata molto fortemente nell'umana sofferenza. Questa non solo
consuma l'uomo dentro se stesso, ma sembra renderlo un peso per gli
altri. L'uomo si sente condannato a ricevere aiuto ed assistenza dagli
altri e, in pari tempo, sembra a se stesso inutile. La scoperta del
senso salvifico della sofferenza in unione con Cristo trasforma questa
sensazione deprimente. La fede nella partecipazione alle
sofferenze di Cristo porta in sé la certezza interiore che l'uomo
sofferente « completa quello che manca ai patimenti di Cristo »; che
nella dimensione spirituale dell'opera della redenzione serve, come
Cristo, alla salvezza dei suoi fratelli e sorelle. Non solo
quindi è utile agli altri, ma per di più adempie un servizio
insostituibile. Nel corpo di Cristo, che incessantemente cresce dalla
Croce del Redentore, proprio la sofferenza, permeata dallo spirito del
sacrificio di Cristo, è l'insostituibile mediatrice ed autrice dei
beni, indispensabili per la salvezza del mondo. E' essa, più di
ogni altra cosa, a fare strada alla Grazia che trasforma le anime
umane. Essa, più di ogni altra cosa, rende presenti nella storia
dell'umanità le forze della redenzione. In quella lotta « cosmica »
tra le forze spirituali del bene e del male, della quale parla la
Lettera agli Efesini(89), le sofferenze umane, unite con la sofferenza
redentrice di Cristo, costituiscono un particolare sostegno per le
forze del bene, aprendo la strada alla vittoria di queste forze
salvifiche.
E perciò la Chiesa vede in tutti
i fratelli e sorelle di Cristo sofferenti quasi un soggetto
molteplice della sua forza soprannaturale.
Quanto spesso proprio ad essi
ricorrono i pastori della Chiesa, e proprio presso di essi cercano
aiuto ed appoggio! I1 Vangelo della sofferenza viene scritto
incessantemente, ed incessantemente parla con le parole di questo
strano paradosso: le sorgenti della forza divina sgorgano proprio in
mezzo all'umana debolezza. Coloro che partecipano alle sofferenze di
Cristo conservano nelle proprie sofferenze una specialissima particella
dell'infinito tesoro della redenzione del mondo, e possono
condividere questo tesoro con gli altri. Quanto più l'uomo è
minacciato dal peccato, quanto più pesanti sono le strutture del
peccato che porta in sé il mondo d'oggi, tanto più grande è
l'eloquenza che la sofferenza umana in sé possiede. E tanto più la
Chiesa sente il bisogno di ricorrere al valore delle sofferenze umane
per la salvezza del mondo.
VII
IL
BUON SAMARITANO
28. Al Vangelo della sofferenza
appartiene anche — ed in modo organico — la parabola del buon
Samaritano. Mediante questa parabola Cristo volle dare risposta alla
domanda: « chi è il mio prossimo? »(90). Infatti, fra i tre
passanti lungo la via da Gerusalemme a Gerico, dove giaceva per terra
mezzo morto un uomo rapinato e ferito dai briganti, proprio il
Samaritano dimostrò di essere davvero il « prossimo » per
quell'infelice: « prossimo » significa anche colui che adempì il
comandamento dell'amore del prossimo. Altri due uomini percorrevano la
stessa strada: uno era sacerdote, e l'altro levita, ma ciascuno « lo
vide e passò oltre ». Invece, il Samaritano « lo vide e n'ebbe
compassione. Gli si fece vicino, ... gli fasciò le ferite », poi «
lo portò a una locanda e si prese cura di lui »(91). Ed all'atto di
partire, affidò sollecitamente la cura dell'uomo sofferente
all'albergatore, impegnandosi a sostenere le spese occorrenti.
La parabola del buon Samaritano
appartiene al Vangelo della sofferenza. Essa indica, infatti, quale
debba essere il rapporto di ciascuno di noi verso il prossimo
sofferente. Non ci è lecito « passare oltre » con indifferenza, ma
dobbiamo « fermarci » accanto a lui. Buon Samaritano è ogni
uomo, che si ferma accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque
essa sia. Quel fermarsi non significa curiosità, ma disponibilità.
Questa è come l'aprirsi di una certa interiore disposizione del
cuore, che ha anche la sua espressione emotiva. Buon Samaritano è ogni
uomo sensibile alla sofferenza altrui, l'uomo che « si commuove
» per la disgrazia del prossimo. Se Cristo, conoscitore dell'interno
dell'uomo, sottolinea questa commozione, vuol dire che essa è
importante per tutto il nostro atteggiamento di fronte alla sofferenza
altrui. Bisogna, dunque, coltivare in sé questa sensibilità del
cuore, che testimonia la compassione verso un sofferente. A
volte questa compassione rimane l'unica o principale espressione del
nostro amore e della nostra solidarietà con l'uomo sofferente.
Tuttavia, il buon Samaritano della
parabola di Cristo non si ferma alla sola commozione e compassione.
Queste diventano per lui uno stimolo alle azioni che mirano a portare
aiuto all'uomo ferito. Buon Samaritano è, dunque, in definitiva colui
che porta aiuto nella sofferenza, di qualunque natura essa sia.
Aiuto, in quanto possibile, efficace. In esso egli mette il suo cuore,
ma non risparmia neanche i mezzi materiali. Si può dire che dà se
stesso, il suo proprio « io », aprendo quest'« io » all'altro.
Tocchiamo qui uno dei punti-chiave di tutta l'antropologia cristiana.
L'uomo non può « ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono
sincero di sé »(92). Buon Samaritano è l'uomo capace appunto
di tale dono di sé.
29. Seguendo la parabola
evangelica, si potrebbe dire che la sofferenza, presente sotto tante
forme diverse nel nostro mondo umano, vi sia presente anche per sprigionare
nell'uomo l'amore, proprio quel dono disinteressato del proprio «
io » in favore degli altri uomini, degli uomini sofferenti. I1 mondo
dell'umana sofferenza invoca, per così dire, senza sosta un altro
mondo: quello dell'amore umano; e quell'amore disinteressato, che si
desta nel suo cuore e nelle sue opere, l'uomo lo deve in un certo
senso alla sofferenza. Non può l'uomo « prossimo » passare con
indifferenza davanti alla sofferenza altrui in nome della fondamentale
solidarietà umana, né tanto meno in nome dell'amore del prossimo.
Egli deve « fermarsi », « commuoversi », agendo così come il
Samaritano della parabola evangelica. La parabola in sé esprime una
verità profondamente cristiana, ma insieme quanto mai
universalmente umana. Non senza ragione anche nel linguaggio comune
viene chiamata opera « da buon samaritano » ogni attività in favore
degli uomini sofferenti e bisognosi di aiuto.
Quest'attività assume, nel
corso dei secoli, forme istituzionali organizzate e costituisce
un campo di lavoro nelle rispettive professioni. Quanto è «
da buon samaritano » la professione del medico, o dell'infermiera, o
altre simili! In ragione del contenuto « evangelico », racchiuso in
essa, siamo inclini a pensare qui piuttosto ad una vocazione, che non
semplicemente ad una professione. E le istituzioni che, nell'arco
delle generazioni, hanno compiuto un servizio « da samaritano », ai
nostri tempi si sono ancora maggiormente sviluppate e specializzate.
Ciò prova indubbiamente che l'uomo di oggi si ferma con sempre
maggiore attenzione e perspicacia accanto alle sofferenze del
prossimo, cerca di comprenderle e di prevenirle sempre più
esattamente. Egli possiede anche una sempre maggiore capacità e
specializzazione in questo settore. Guardando a tutto questo, possiamo
dire che la parabola del Samaritano del Vangelo è diventata una delle
componenti essenziali della cultura morale e della civiltà
universalmente umana. E pensando a tutti quegli uomini, che con la
loro scienza e la loro capacità rendono molteplici servizi al
prossimo sofferente, non possiamo esimerci dal rivolgere al loro
indirizzo parole di riconoscimento e di gratitudine.
Queste si estendono a tutti
coloro, che svolgono il proprio servizio verso il prossimo sofferente
in maniera disinteressata, impegnandosi volontariamente nell'aiuto
« da buon samaritano », e destinando a tale causa tutto il tempo
e le forze che rimangono a loro disposizione al di fuori del lavoro
professionale. Una tale spontanea attività « da buon samaritano » o
caritativa può essere chiamata attività sociale, può anche essere
definita come apostolato, tutte le volte che viene intrapresa
per motivi schiettamente evangelici, specialmente se ciò avviene in
collegamento con la Chiesà o con un'altra Comunità cristiana. La
volontaria attività « da buon samaritano » si realizza attraverso ambienti
adeguati oppure attraverso organizzazioni create a questo
scopo. L'operare in questa forma ha una grande importanza,
specialmente se si tratta di assumere compiti più grandi, che esigono
la cooperazione e l'uso dei mezzi tecnici. Non meno preziosa è anche
l'attività individuale, specialmente da parte delle persone, che sono
ad essa meglio predisposte riguardo alle varie specie di umana
sofferenza, verso le quali l'aiuto non può essere portato che
individualmente e personalmente. L'aiuto familiare poi
significa sia gli atti d'amore del prossimo, resi alle persone
appartenenti alla stessa famiglia, sia l'aiuto reciproco tra le
famiglie.
E' difficile elencare qui tutti i
tipi ed i diversi àmbiti dell'attività « da samaritano » che
esistono nella Chiesa e nella società. Bisogna riconoscere che essi
sono molto numerosi, ed anche esprimere la gioia perché grazie ad
essi i fondamentali valori morali, quali il valore dell'umana
solidarietà, il valore dell'amore cristiano del prossimo, formano il
quadro della vita sociale e dei rapporti interumani, combattendo su
questo fronte le diverse forme dell'odio, della violenza, della
crudeltà, del disprezzo per l'uomo, oppure della semplice «
insensibilità », cioè dell'indifferenza verso il prossimo e le sue
sofferenze.
Enorme è qui il significato
degli atteggiamenti opportuni da usare nell'educazione. La
famiglia, la scuola, le altre istituzioni educative, anche solo per
motivi umanitari, devono lavorare con perseveranza per il risveglio e
l'affinamento di quella sensibilità verso il prossimo e la sua
sofferenza, di cui è diventata simbolo la figura del Samaritano
evangelico. La Chiesa ovviamente deve far lo stesso, addentrandosi
ancora più profondamente — in quanto possibile — nelle
motivazioni che Cristo ha racchiuso nella sua parabola ed in tutto il
Vangelo. L'eloquenza della parabola del buon Samaritano, come anche di
tutto il Vangelo, è in particolare questa: l'uomo deve sentirsi come
chiamato in prima persona a testimoniare l'amore nella sofferenza.
Le istituzioni sono molto importanti ed indispensabili; tuttavia,
nessuna istituzione può da sola sostituire il cuore umano, la
compassione umana, l'amore umano, l'iniziativa umana, quando si tratti
di farsi incontro alla sofferenza dell'altro. Questo si riferisce alle
sofferenze fisiche, ma vale ancora di più se si tratta delle
molteplici sofferenze morali, e quando, prima di tutto, a soffrire è
l'anima.
30. La parabola del buon
Samaritano, che — come si è detto — appartiene al Vangelo della
sofferenza, cammina insieme con esso lungo la storia della Chiesa e
del cristianesimo, lungo la storia dell'uomo e dell'umanità. Essa
testimonia che la rivelazione da parte di Cristo del senso salvifico
della sofferenza non si identifica in alcun modo con un
atteggiamento di passività. E' tutto il contrario. Il Vangelo è
la negazione della passività di fronte alla sofferenza. Cristo stesso
in questo campo è soprattutto attivo. In questo modo, egli realizza
il programma messianico della sua missione, secondo le parole del
profeta: « Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare
un anno di grazia del Signore »(93). Cristo compie in modo
sovrabbondante questo programma messianico della sua missione:
egli passa « beneficando (94), ed il bene delle sue opere ha assunto
rilievo soprattutto di fronte all'umana sofferenza. La parabola del
buon Samaritano è in profonda armonia col comportamento di Cristo
stesso.
Questa parabola entrerà, infine,
per il suo contenuto essenziale, in quelle sconvolgenti parole sul
giudizio finale, che Matteo ha annotato nel suo Vangelo: « Venite,
benedetti del Padre mio; ricevete in eredità il regno preparato per
voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi »(95). Ai giusti
che chiedono quando mai abbiano fatta proprio a lui tutto questo, il
Figlio dell'Uomo risponderà: « In verità vi dico: ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me » (96). La sentenza opposta toccherà a
coloro che si sono comportati diversamente: « Ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
non l'avete fatto a me »(97).
Si potrebbe certamente allungare
l'elenco delle sofferenze che hanno incontrato la sensibilità umana,
la compassione, l'aiuto, oppure che non le hanno incontrate. La prima
e la seconda parte della dichiarazione di Cristo sul giudizio finale
indicano senza ambiguità come siano essenziali, nella prospettiva
della vita eterna di ogni uomo, il « fermarsi », come fece il buon
Samaritano, accanto alla sofferenza del suo prossimo, l'aver «
compassione » di essa, ed infine il dare aiuto. Nel programma
messianico di Cristo, che è insieme il programma del Regno di Dio,
la sofferenza è presente nel mondo per sprigionare amore, per far
nascere opere di amore verso il prossimo, per trasformare tutta la
civiltà umana nella « civiltà dell'amore ». In questo amore il
significato salvifico della sofferenza si realizza fino in fondo e
raggiunge la sua dimensione definitiva. Le parole di Cristo sul
giudizio finale permettono di comprendere ciò in tutta la semplicità
e perspicacia del Vangelo.
Queste parole sull'amore, sugli
atti di amore, collegati con l'umana sofferenza, ci permettono ancora
una volta di scoprire, alla base di tutte le sofferenze umane, la
stessa sofferenza redentrice di Cristo. Cristo dice: « L'avete
fatto a me ». Egli stesso è colui che in ognuno sperimenta l'amore;
egli stesso è colui che riceve aiuto, quando questo viene reso ad
ogni sofferente senza eccezione. Egli stesso è presente in questo
sofferente, poiché la sua sofferenza salvifica è stata aperta una
volta per sempre ad ogni sofferenza umana. E tutti coloro che soffrono
sono stati chiamati una volta per sempre a diventare partecipi «
delle sofferenze di Cristo »(98). Così come tutti sono stati
chiamati a « completare » con la propria sofferenza « quello che
manca ai patimenti di Cristo »(99). Cristo allo stesso tempo ha
insegnato all'uomo a far del bene con la sofferenza ed a far
del bene a chi soffre. In questo duplice aspetto egli ha svelato
fino in fondo il senso della sofferenza.
VIII
CONCLUSIONE
31. Questo è il senso veramente
soprannaturale ed insieme umano della sofferenza. E'soprannaturale,
perché si radica nel mistero divino della redenzione del mondo,
ed è, altresì, profondamente umano, perché in esso l'uomo
ritrova se stesso, la propria umanità, la propria dignità, la
propria missione.
La sofferenza certamente
appartiene al mistero dell'uomo. Forse essa non è avvolta quanto lui
da questo mistero, che è particolarmente impenetrabile. Il Concilio
Vaticano II ha espresso questa verità che « in realtà, solamente
nel mistero del Verbo Incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo.
Infatti..., Cristo che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il
mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente
l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione »(100).
Se queste parole si riferiscono a tutto ciò che riguarda il mistero
dell'uomo, allora certamente si riferiscono in modo particolarissimo all'umana
sofferenza. Proprio in questo punto lo « svelare l'uomo all'uomo
e fargli nota la sua altissima vocazione » è particolarmente indispensabile.
Succede anche — come prova l'esperienza — che ciò sia
particolarmente drammatico. Quando però si compie fino in
fondo e diventa luce della vita umana, ciò è anche particolarmente beato.
« Per Cristo e in Cristo si illumina l'enigma del dolore e della
morte »(101).
Chiudiamo le presenti
considerazioni sulla sofferenza nell'anno nel quale la Chiesa vive il
giubileo straordinario, collegato all'anniversario della redenzione.
I1 mistero della redenzione del
mondo è in modo sorprendente radicato nella sofferenza, e
questa, a sua volta, trova in esso il suo supremo e più sicuro punto
di riferimento.
Desideriamo vivere quest'Anno
della Redenzione in speciale unione con tutti coloro che soffrono.
Occorre, pertanto, che sotto la Croce del Calvario idealmente
convengano tutti i sofferenti che credono in Cristo e,
particolarmente, coloro che soffrono a causa della loro fede in lui
Crocifisso e Risorto, affinché l'offerta delle loro sofferenze
affretti il compimento della preghiera dello stesso Salvatore per
l'unità di tutti(102). Là pure convengano gli uomini di buona volontà,
perché sulla Croce sta il « Redentore dell'uomo », l'Uomo dei
dolori, che in sé ha assunto le sofferenze fisiche e morali degli
uomini di tutti i tempi, affinché nell'amore possano trovare
il senso salvifico del loro dolore e risposte valide a tutti i loro
interrogativi.
Insieme con Maria, Madre
di Cristo, che stava sotto la Croce (103), ci fermiamo accanto
a tutte le croci dell'uomo d'oggi.
Invochiamo tutti i Santi, che
durante i secoli furono in special modo partecipi delle sofferenze di
Cristo. Chiediamo loro di sostenerci.
E chiediamo a voi tutti, che
soffrite, di sostenerci. Proprio a voi, che siete deboli,
chiediamo che diventiate una sorgente di forza per la Chiesa e
per l'umanità. Nel terribile combattimento tra le forze del bene e
del male, di cui ci offre spettacolo il nostro mondo contemporaneo,
vinca la vostra sofferenza in unione con la Croce di Cristo!
A tutti, Fratelli e Sorelle
carissimi, invio la mia Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso San Pietro,
nella memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes, l'11
febbraio dell'anno 1984, sesto di Pontificato.