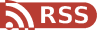LETTERA
APOSTOLICA
TERTIO
MILLENNIO ADVENIENTE
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
ALL'EPISCOPATO, AL CLERO E AI FEDELI
CIRCA LA PREPARAZIONE
DEL GIUBILEO DELL'ANNO 2000
Ai Vescovi
Ai sacerdoti e ai diaconi
Ai religiosi e alle religiose
A tutti i fedeli laici
1. Mentre ormai s'avvicina il
terzo millennio della nuova era, il pensiero va spontaneamente alle
parole dell'apostolo Paolo: « Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna » (Gal 4, 4). La
pienezza del tempo si identifica con il mistero dell'Incarnazione del
Verbo, Figlio consustanziale al Padre e con il mistero della
Redenzione del mondo. San Paolo sottolinea in questo brano che il
Figlio di Dio è nato da donna, nato sotto la Legge, venuto nel mondo
per riscattare quanti erano sotto la Legge, affinché potessero
ricevere l'adozione a figli. Ed aggiunge: « Che voi siete figli ne è
prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio che grida: Abbà, Padre! ». La sua conclusione è davvero
consolante: « Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio,
sei anche erede per volontà di Dio » (Gal 4, 6-7).
Questa presentazione paolina del
mistero della Incarnazione contiene la rivelazione del mistero
trinitario e della continuazione della missione del Figlio nella
missione dello Spirito Santo. L'Incarnazione del Figlio di Dio, il
suo concepimento, la sua nascita sono il presupposto dell'invio dello
Spirito Santo. Il testo di san Paolo lascia così trasparire la
pienezza del mistero dell'Incarnazione redentrice.
I
«
GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, OGGI ... »
(Eb 13, 8)
2. Nel suo Vangelo Luca ci ha
trasmesso una concisa descrizione delle circostanze riguardanti la
nascita di Gesù: « In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra (...). Andavano
tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe,
che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret
e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata
Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era
incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei
i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era
posto per loro nell'albergo » (2, 1.3-7).
Si compiva così quanto l'angelo
Gabriele aveva predetto nell'Annunciazione. Alla Vergine di Nazaret
egli si era rivolto con queste parole: « Ti saluto, o piena di
grazia, il Signore è con te » (1, 28). Queste parole avevano turbato
Maria e per questo il Messaggero divino si era affrettato ad
aggiungere: « Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo (...). Lo Spirito Santo
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio » (1, 30- 32.35). La risposta di Maria all'angelico
messaggio fu univoca: « Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di
me quello che hai detto » (1, 38). Mai nella storia dell'uomo tanto
dipese, come allora, dal consenso dell'umana creatura.(1)
3. Giovanni, nel Prologo del suo
Vangelo, riassume in una sola frase tutta la profondità del mistero
dell'Incarnazione. Egli scrive : « E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità »
(1, 14). Per Giovanni, nel concepimento e nella nascita di Gesù si
attua l'Incarnazione del Verbo eterno, consustanziale al Padre.
L'Evangelista si riferisce al
Verbo che in principio era presso Dio, per mezzo del quale è stato
fatto tutto ciò che esiste; il Verbo nel quale era la vita, vita che
era la luce degli uomini (cf. 1, 1-5). Del Figlio unigenito, Dio da
Dio, l'apostolo Paolo scrive che fu « generato prima di ogni
creatura » (Col 1, 15). Dio crea il mondo per mezzo del
Verbo. Il Verbo è l'eterna Sapienza, il Pensiero e l'Immagine
sostanziale di Dio, « irradiazione della sua gloria e impronta della
sua sostanza » (Eb 1, 3). Egli, generato eternamente ed
eternamente amato dal Padre, come Dio da Dio e Luce da Luce, è il
principio e l'archetipo di tutte le cose da Dio create nel tempo.
Il fatto che il Verbo eterno abbia
assunto nella pienezza dei tempi la condizione di creatura conferisce
all'evento di Betlemme di duemila anni fa un singolare valore
cosmico. Grazie al Verbo, il mondo delle creature si presenta come «
cosmo », cioè come universo ordinato. Ed è ancora il Verbo che,
incarnandosi, rinnova l'ordine cosmico della creazione. La
Lettera agli Efesini parla del disegno che Dio ha prestabilito in
Cristo, « per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè
diricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come
quelle della terra » (1, 10).
4. Cristo, Redentore del mondo, è
l'unico Mediatore tra Dio e gli uomini e non vi è un altro nome
sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati (cf. At 4,
12). Leggiamo nella Lettera agli Efesini: in Lui « abbiamo la
redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo
la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su
di noi con ogni sapienza e intelligenza (...) secondo quanto, nella
sua benevolenza, aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella
pienezza dei tempi » (Ef 1, 7-10). Cristo, Figlio
consustanziale al Padre, è dunque Colui che rivela il disegno di
Dio nei riguardi di tutta la creazione e, in particolare, nei riguardi
dell'uomo. Come afferma in modo suggestivo il Concilio Vaticano II,
Egli « svela ... pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua
altissima vocazione ».(2) Gli mostra questa vocazione rivelando
il mistero del Padre e del suo amore. « Immagine del Dio invisibile
», Cristo è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la
somiglianza con Dio deformata dal peccato. Nella sua natura umana,
immune da ogni peccato ed assunta nella Persona divina del Verbo, la
natura comune ad ogni essere umano viene elevata ad altissima dignità:
« Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad
ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente
d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo.
Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in
tutto simile a noi fuorché nel peccato ».(3)
5. Questo « farsi uno di noi »
del Figlio di Dio è avvenuto nella più grande umiltà, sicché non
meraviglia che la storiografia profana, presa da fatti più clamorosi
e da personaggi maggiormente in vista, non gli abbia dedicato
all'inizio che fuggevoli, anche se significativi, cenni. Riferimenti a
Cristo si trovano, ad esempio, nelle Antichità Giudaiche, opera
redatta a Roma dallo storico Giuseppe Flavio tra il 93 e il 94 (4) e
soprattutto negli Annali di Tacito, composti tra il 115 e il
120; in essi, riferendo dell'incendio di Roma del 64, falsamente
imputato da Nerone ai cristiani, lo storico fa esplicito cenno a
Cristo « suppliziato ad opera del procuratore Ponzio Pilato sotto
l'impero di Tiberio ».(5) Anche Svetonio nella biografia
dell'imperatore Claudio, scritta intorno al 121, ci informa circa
l'espulsione dei Giudei da Roma perché « sotto istigazione di un
certo Cresto suscitavano frequenti tumulti ».(6) Fra gli interpreti
è convinzione diffusa che tale passo si riferisca a Gesù Cristo,
divenuto motivo di contesa all'interno dell'ebraismo romano. Di
rilievo, a riprova della rapida diffusione del cristianesimo, è pure
la testimonianza di Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, il
quale riferisce all'imperatore Traiano, tra il 111 ed il 113, che un
gran numero di persone solevano raccogliersi « in un giorno
stabilito, prima dell'alba, per cantare alternatamente un inno a
Cristo come a un Dio ».(7)
Ma il grande evento, che gli
storici non cristiani si limitano a menzionare, acquista la sua luce
piena negli scritti del Nuovo Testamento che, pur essendo documenti di
fede, non sono meno attendibili, nell'insieme dei loro riferimenti,
anche come testimonianze storiche. Cristo, vero Dio e vero uomo,
Signore del cosmo è anche Signore della storia, di cui è « l'Alfa e
l'Omega » (Ap 1, 8; 21, 6), « il Principio e la Fine » (Ap
21, 6). In Lui il Padre ha detto la parola definitiva sull'uomo e
sulla sua storia. È quanto esprime con efficace sintesi la Lettera
agli Ebrei: « Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte
volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente,
in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio » (1,
1-2).
6. Gesù è nato dal Popolo
eletto, a compimento della promessa fatta ad Abramo e costantemente
ricordata dai profeti. Questi parlavano a nome e in luogo di Dio.
L'economia dell'Antico Testamento, infatti, è essenzialmente ordinata
a preparare e ad annunziare la venuta di Cristo Redentore
dell'universo e del suo Regno messianico. I libri dell'Antica Alleanza
sono così testimoni permanenti di una attenta pedagogia divina.(8) In
Cristo questa pedagogia raggiunge la sua meta: Egli infatti non si
limita a parlare « a nome di Dio » come i profeti, ma è Dio stesso
che parla nel suo Verbo eterno fatto carne. Tocchiamo qui il punto
essenziale per cui il cristianesimo si differenzia dalle altre
religioni, nelle quali s'è espressa sin dall'inizio la ricerca
di Dio da parte dell'uomo. Nel cristianesimo l'avvio è dato
dall'Incarnazione del Verbo. Qui non è soltanto l'uomo a cercare Dio,
ma è Dio che viene in Persona a parlare di sé all'uomo ed a
mostrargli la via sulla quale è possibile raggiungerlo. È quanto
proclama il Prologo del Vangelo di Giovanni: « Dio nessuno l'ha mai
visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo
ha rivelato » (1, 18). Il Verbo Incarnato è dunque il compimento
dell'anelito presente in tutte le religioni dell'umanità: questo
compimento è opera di Dio e va al di là di ogni attesa umana. È
mistero di grazia.
In Cristo la religione non è più
un « cercare Dio come a tentoni » (cf. At 17, 27), ma risposta
di fede a Dio che si rivela: risposta nella quale l'uomo parla a
Dio come al suo Creatore e Padre; risposta resa possibile da quell'Uomo
unico che è al tempo stesso il Verbo consustanziale al Padre, nel
quale Dio parla ad ogni uomo ed ogni uomo è reso capace di rispondere
a Dio. Più ancora, in quest'Uomo risponde a Dio l'intera creazione.
Gesù Cristo è il nuovo inizio di tutto: tutto in lui si ritrova,
viene accolto e restituito al Creatore dal quale ha preso origine. In
tal modo, Cristo è il compimento dell'anelito di tutte le
religioni del mondo e, per ciò stesso, ne è l'unico e definitivo
approdo. Se da una parte Dio in Cristo parla di sé all'umanità,
dall'altra, nello stesso Cristo, l'umanità intera e tutta la
creazione parlano di sé a Dio — anzi, si donano a Dio. Tutto così
ritorna al suo principio. Gesù Cristo è la ricapitolazione di
tutto (cf. Ef 1, 10) e insieme il compimento di ogni cosa
in Dio: compimento che è gloria di Dio. La religione che si fonda in
Gesù Cristo è religione della gloria, è un esistere in novità
di vita a lode della gloria di Dio (cf. Ef 1, 12). Tutta la
creazione, in realtà, è manifestazione della sua gloria; in
particolare l'uomo (vivens homo) è epifania della gloria di
Dio, chiamato a vivere della pienezza della vita in Dio.
7. In Gesù Cristo Dio non
solo parla all'uomo, ma lo cerca. L'Incarnazione del Figlio di
Dio testimonia che Dio cerca l'uomo. Di questa ricerca Gesù parla
come del ricupero di una pecorella smarrita (cf. Lc 15, 1-7).
È una ricerca che nasce nell'intimo di Dio e ha il suo punto
culminante nell'Incarnazione del Verbo. Se Dio va in cerca dell'uomo,
creato ad immagine e somiglianza sua, lo fa perché lo ama eternamente
nel Verbo e in Cristo lo vuole elevare alla dignità di figlio
adottivo. Dio dunque cerca l'uomo, che è sua particolare proprietà,
in maniera diversa di come lo è ogni altra creatura. Egli è
proprietà di Dio in base ad una scelta di amore: Dio cerca l'uomo
spinto dal suo cuore di Padre.
Perché lo cerca? Perché
l'uomo si è da lui allontanato, nascondendosi come Adamo tra gli
alberi del paradiso terrestre (cf. Gn 3, 8-10). L'uomo si è
lasciato sviare dal nemico di Dio (cf. Gn 3, 13). Satana lo
ha ingannato persuadendolo di essere egli stesso dio e di poter
conoscere, come Dio, il bene e il male, governando il mondo a suo
arbitrio senza dover tenere conto della volontà divina (cf. Gn 3,
5). Cercando l'uomo tramite il Figlio, Dio vuole indurlo ad
abbandonare le vie del male, nelle quali tende ad inoltrarsi sempre di
più. « Fargli abbandonare » quelle vie, vuol dire fargli capire che
si trova su strade sbagliate; vuol dire sconfiggere il male diffuso
nella storia umana. Sconfiggere il male: ecco la Redenzione. Essa
si realizza nel sacrificio di Cristo, grazie al quale l'uomo riscatta
il debito del peccato e viene riconciliato con Dio. Il Figlio di Dio
si è fatto uomo, assumendo un corpo e un'anima nel grembo della
Vergine, proprio per questo: per fare di sé il perfetto sacrificio
redentore. La religione dell'Incarnazione è lareligione della
Redenzione del mondo attraverso il sacrificio di Cristo, in cui è
contenuta la vittoria sul male, sul peccato e sulla stessa morte.
Cristo, accettando la morte sulla croce, contemporaneamente manifesta
e dà la vita, poiché risorge e la morte non ha più alcun potere su
di lui.
8. La religione che trae origine
dal mistero della Incarnazione redentiva è la religione del «
rimanere nell'intimo di Dio », del partecipare alla sua stessa
vita. Ne parla san Paolo nel passo riportato all'inizio: « Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà,
Padre! » (Gal 4, 6). L'uomo eleva la sua voce a somiglianza di
Cristo, il quale si rivolgeva « con forti grida e lacrime » (Eb 5,
7) a Dio, specialmente nel Getsemani e sulla croce: l'uomo grida a Dio
come ha gridato Cristo e testimonia così di partecipare alla sua
figliolanza per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che il
Padre ha mandato nel nome del Figlio, fa sì che l'uomo partecipi alla
vita intima di Dio. Fa sì che l'uomo sia anche figlio, a
somiglianza di Cristo, ed erede di quei beni che costituiscono la
parte del Figlio (cf. Gal 4, 7). In questo consiste la
religione del « rimanere nella vita intima di Dio », alla quale
l'Incarnazione del Figlio di Dio dà inizio. Lo Spirito Santo, che
scruta le profondità di Dio (cf. 1 Cor 2, 10), introduce noi
uomini in tali profondità in virtù del sacrificio di Cristo.
II
IL
GIUBILEO DELL'ANNO 2000
9. Parlando della nascita del
Figlio di Dio, san Paolo la situa nella « pienezza del tempo » (cf. Gal
4, 4). Il tempo in realtà si è compiuto per il fatto stesso
che Dio, con l'Incarnazione, si è calato dentro la storia dell'uomo.
L'eternità è entrata nel tempo: quale « compimento » più grande
di questo? Quale altro « compimento » sarebbe possibile? Qualcuno ha
pensato a certi cicli cosmici arcani, nei quali la storia
dell'universo, e in particolare dell'uomo, costantemente si
ripeterebbe. L'uomo sorge dalla terra e alla terra ritorna (cf. Gn 3,
19): questo è il dato di evidenza immediata. Ma nell'uomo vi è
un'insopprimibile aspirazione a vivere per sempre. Come pensare ad una
sua sopravvivenza al di là della morte? Alcuni hanno immaginato varie
forme di reincarnazione: in dipendenza da come egli ha vissuto
nel corso dell'esistenza precedente, si troverebbe a sperimentare una
nuova esistenza più nobile o più umile, fino a raggiungere la piena
purificazione. Questa credenza, molto radicata in alcune religioni
orientali, sta ad indicare, tra l'altro, che l'uomo non intende
rassegnarsi alla irrevocabilità della morte. È convinto della
propria natura essenzialmente spirituale ed immortale.
La rivelazione cristiana esclude
la reincarnazione e parla di un compimento che l'uomo è chiamato a
realizzare nel corso di un'unica esistenza sulla terra. Questo
compimento del proprio destino l'uomo lo raggiunge nel dono sincero di
sé, un dono che è reso possibile soltanto nell'incontro con Dio. È
in Dio, pertanto, che l'uomo trova la piena realizzazione di sé: questa
è la verità rivelata da Cristo. L'uomo compie se stesso in Dio,
che gli è venuto incontro mediante l'eterno suo Figlio. Grazie alla
venuta di Dio sulla terra, il tempo umano, iniziato nella creazione,
ha raggiunto la sua pienezza. « La pienezza del tempo », infatti, è
soltanto l'eternità, anzi Colui che è eterno, cioè Dio.
Entrare nella « pienezza del tempo » significa dunque raggiungere il
termine del tempo ed uscire dai suoi confini, per trovarne il
compimento nell'eternità di Dio.
10. Nel cristianesimo il tempo
ha un'importanza fondamentale. Dentro la sua dimensione viene
creato il mondo, al suo interno si svolge la storia della salvezza,
che ha il suo culmine nella « pienezza del tempo » dell'Incarnazione
e il suo traguardo nel ritorno glorioso del Figlio di Dio alla fine
dei tempi. In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una
dimensione di Dio, che in se stesso è eterno. Con la venuta di
Cristo iniziano gli « ultimi tempi » (cf. Eb 1, 2), l'«
ultima ora » (cf. 1 Gv 2, 18), inizia il tempo della Chiesa
che durerà fino alla Parusia.
Da questo rapporto di Dio col
tempo nasce il dovere di santificarlo. È quanto si fa, ad
esempio, quando si dedicano a Dio singoli tempi, giorni o settimane,
come già avveniva nella religione dell'Antica Alleanza e avviene
ancora, anche se in modo nuovo, nel cristianesimo. Nella liturgia
della Veglia pasquale il celebrante, mentre benedice il cero che
simboleggia il Cristo risorto, proclama: « Il Cristo ieri e oggi,
Principio e Fine, Alfa e Omega. A lui appartengono il tempo e i
secoli. A lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno ».
Egli pronuncia queste parole incidendo sul cero la cifra dell'anno in
corso. Il significato del rito è chiaro: esso mette in evidenza il
fatto che Cristo è il Signore del tempo; è il suo principio e
il suo compimento; ogni anno, ogni giorno ed ogni momento vengono
abbracciati dalla sua Incarnazione e Risurrezione, per ritrovarsi in
questo modo nella « pienezza del tempo ». Per questo anche la Chiesa
vive e celebra la liturgia nello spazio dell'anno. L'anno solare
viene così pervaso dall'anno liturgico, che riproduce in un certo
senso l'intero mistero dell'Incarnazione e della Redenzione, iniziando
dalla prima Domenica d'Avvento e terminando nella solennità di
Cristo, Re e Signore dell'universo e della storia. Ogni domenica
ricorda il giorno della risurrezione del Signore.
11. Su tale sfondo diventa
comprensibile l'usanza dei Giubilei, che ha inizio nell'Antico
Testamento e ritrova la sua continuazione nella storia della Chiesa.
Gesù di Nazaret, recatosi un giorno nella sinagoga della sua città,
si alzò per leggere (cf. Lc 4, 16-30). Gli venne dato il
rotolo del profeta Isaia, nel quale egli lesse il seguente passo: «
Lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha
consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai
poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare
l'anno di misericordia del Signore » (61, 1-2).
Il Profeta parlava del Messia. «
Oggi — aggiunse Gesù — si è adempiuta questa Scrittura che voi
avete udito con i vostri orecchi » (Lc 4, 21), facendo capire
che il Messia annunziato dal Profeta era proprio lui e che in lui
prendeva avvio il « tempo » tanto atteso: era giunto il giorno della
salvezza, la « pienezza del tempo ». Tutti i Giubilei si
riferiscono a questo « tempo » e riguardano la missione messianica
di Cristo, venuto come « consacrato con l'unzione » dello
Spirito Santo, come « mandato dal Padre ». È lui ad annunziare la
buona novella ai poveri. È lui a portare la libertà a coloro che ne
sono privi, a liberare gli oppressi, a restituire la vista ai ciechi (cf.
Mt 11, 4-5; Lc 7, 22). In tal modo egli realizza « un
anno di grazia del Signore », che annunzia non solo con la parola, ma
prima di tutto con le sue opere. Giubileo, cioè « un anno di grazia
del Signore », è la caratteristica dell'attività di Gesù e
non soltanto la definizione cronologica di una certa ricorrenza.
12. Le parole e le opere di Gesù
costituiscono in questo modo il compimento dell'intera tradizione dei
Giubilei dell'Antico Testamento. È noto che il Giubileo era un
tempo dedicato in modo particolare a Dio. Esso cadeva ogni settimo
anno, secondo la Legge di Mosè: era l'« anno sabbatico », durante
il quale si lasciava riposare la terra e venivano liberati gli
schiavi. L'obbligo della liberazione degli schiavi veniva regolato da
prescrizioni dettagliate contenute nel Libro dell'Esodo (23, 10-11),
del Levitico (25, 1-28), del Deuteronomio (15, 1-6) e cioè,
praticamente, in tutta la legislazione biblica, la quale acquista così
questa peculiare dimensione. Nell'anno sabbatico, oltre alla
liberazione degli schiavi, la Legge prevedeva il condono di tutti i
debiti, secondo precise prescrizioni. E tutto ciò doveva essere fatto
in onore di Dio. Quanto riguardava l'anno sabbatico valeva anche per
quello « giubilare », che cadeva ogni cinquant'anni.
Nell'anno giubilare però le usanze di quello sabbatico erano ampliate
e celebrate ancor più solennemente. Leggiamo nel Levitico: «
Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione
nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno
di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia » (25, 10).
Una delle conseguenze più significative dell'anno giubilare era la
generale « emancipazione » di tutti gli abitanti bisognosi di
liberazione. In questa occasione ogni israelita rientrava in
possesso della terra dei suoi padri, se eventualmente l'aveva venduta
o persa cadendo in schiavitù. Non si poteva essere privati in modo
definitivo della terra, poiché essa apparteneva a Dio, né gli
israeliti potevano rimanere per sempre in una situazione di schiavitù,
dato che Dio li aveva « riscattati » per sé come esclusiva proprietà
liberandoli dalla schiavitù in Egitto.
13. Anche se i precetti dell'anno
giubilare restarono in gran parte una prospettiva ideale — più una
speranza che una realizzazione concreta, divenendo peraltro una prophetia
futuri in quanto preannuncio della vera liberazione che sarebbe
stata operata dal Messia venturo — sulla base della normativa
giuridica in essi contenuta si venne delineando una certa dottrina
sociale, che si sviluppò poi più chiaramente a partire dal Nuovo
Testamento. L'anno giubilare doveva restituire l'eguaglianza tra
tutti i figli d'Israele, schiudendo nuove possibilità alle
famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la libertà
personale. Ai ricchi invece l'anno giubilare ricordava che sarebbe
venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente
uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i loro diritti. Si doveva
proclamare, nel tempo previsto dalla Legge, un anno giubilare, venendo
in aiuto ad ogni bisognoso. Questo esigeva un governo giusto. La
giustizia, secondo la Legge di Israele, consisteva soprattutto nella
protezione dei deboli ed un re doveva distinguersi in questo, come
afferma il Salmista: « Egli libererà il povero che invoca e il
misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero e
salverà la vita dei suoi miseri » (Sal 72 1, 12-13). Le
premesse di simile tradizione erano strettamente teologiche, collegate
prima di tutto con la teologia della creazione e con quella della
divina Provvidenza. Era convinzione comune, infatti, che solo a
Dio, come Creatore, spettasse il « dominium altum », cioè la
signoria su tutto il creato e in particolare sulla terra (cf. Lv 25,
23). Se nella sua Provvidenza Dio aveva donato la terra agli uomini,
ciò stava a significare che l'aveva donata a tutti. Perciò le
ricchezze della creazione erano da considerarsi come un bene comune
dell'intera umanità. Chi possedeva questi beni come sua proprietà,
ne era in verità soltanto un amministratore, cioè un ministro tenuto
ad operare in nome di Dio, unico proprietario in senso pieno, essendo
volontà di Dio che i beni creati servissero a tutti in modo giusto. L'anno
giubilare doveva servire proprio al ripristino anche di questa
giustizia sociale. Nella tradizione dell'anno giubilare ha così
una delle sue radici la dottrina sociale della Chiesa, che ha avuto
sempre un suo posto nell'insegnamento ecclesiale e si è
particolarmente sviluppata nell'ultimo secolo, soprattutto a partire
dall'Enciclica Rerum novarum.
14. Occorre sottolineare tuttavia
ciò che Isaia esprime con le parole: « predicare un anno di
grazia del Signore ». Il Giubileo, per la Chiesa, è proprio
questo « anno di grazia »: anno della remissione dei peccati e delle
pene per i peccati, anno della riconciliazione tra i contendenti, anno
di molteplici conversioni e di penitenza sacramentale ed extra-
sacramentale. La tradizione degli anni giubilari è legata alla
concessione di indulgenze in modo più largo che in altri periodi.
Accanto ai Giubilei che ricordano il mistero dell'Incarnazione, al
compiersi dei cento, dei cinquanta e dei venticinque anni, vi sono poi
quelli che commemorano l'evento della Redenzione: la croce di Cristo,
la sua morte sul Golgota e la sua risurrezione. La Chiesa, in queste
circostanze, proclama « un anno di grazia del Signore » e si adopera
affinché di questa grazia possano più ampiamente usufruire tutti i
fedeli. Ecco perché i Giubilei vengono celebrati non soltanto «
in Urbe », ma anche « extra Urbem »: tradizionalmente ciò
avveniva l'anno successivo alla celebrazione « in Urbe ».
15. Nella vita delle singole
persone i Giubilei sono legati solitamente alla data di nascita,
ma si celebrano anche gli anniversari del Battesimo, della Cresima,
della prima Comunione, dell'Ordinazione sacerdotale o episcopale, del
sacramento del Matrimonio. Alcuni di questi anniversari hanno un
riscontro nell'ambito laico, ma i cristiani attribuiscono sempre ad
essi un carattere religioso. Nella visione cristiana, infatti, ogni
Giubileo — quello del 25° di Sacerdozio o di Matrimonio, detto «
d'argento », o quello del 50°, detto « d'oro », o quello del 60°,
detto « di diamante » — costituisce un particolare anno di
grazia per la singola persona che ha ricevuto uno dei Sacramenti
elencati. Quanto abbiamo detto dei Giubilei individuali può essere
pure applicato alle comunità o alle istituzioni. Così dunque
si celebra il centenario, o il millennio di fondazione di una città o
di un comune. Nell'ambito ecclesiale si festeggiano i Giubilei delle
parrocchie e delle diocesi. Tutti questi Giubilei personali o
comunitari rivestono nella vita dei singoli e delle comunità un ruolo
importante e significativo.
Su tale sfondo, i duemila anni
dalla nascita di Cristo (prescindendo dall'esattezza del computo
cronologico) rappresentano un Giubileo straordinariamente grande non
soltanto per i cristiani, ma indirettamente per l'intera umanità,
dato il ruolo di primo piano che il cristianesimo ha esercitato in
questi due millenni. Significativamente il computo del decorso degli
anni si fa quasi dappertutto a partire dalla venuta di Cristo nel
mondo, la quale diventa così il centro anche del calendario
oggi più utilizzato. Non è forse anche questo un segno del
contributo impareggiabile recato alla storia universale dalla nascita
di Gesù di Nazaret?
16. Il termine « Giubileo »
parla di gioia; non soltanto di gioia interiore, ma di un giubilo
che si manifesta all'esterno, poiché la venuta di Dio è un evento
anche esteriore, visibile, udibile e tangibile, come ricorda san
Giovanni (cf. 1 Gv 1, 1). È giusto quindi che ogni
attestazione di gioia per tale venuta abbia una sua manifestazione
esteriore. Essa sta ad indicare che la Chiesa gioisce per la
salvezza. Invita tutti alla gioia e si sforza di creare le
condizioni, affinché le energie salvifiche possano essere comunicate
a ciascuno. Il 2000 segnerà perciò la data del Grande Giubileo.
Quanto al contenuto, questo
Grande Giubileo sarà, in un certo senso, uguale ad ogni altro. Ma
sarà, al tempo stesso, diverso e di ogni altro più grande. La Chiesa
infatti rispetta le misure del tempo: ore, giorni, anni, secoli. Sotto
questo aspetto essa cammina al passo con ogni uomo, rendendo
consapevole ciascuno di come ognuna di queste misure sia intrisa
della presenza di Dio e della sua azione salvifica. In questo
spirito la Chiesa gioisce, rende grazie, chiede perdono, presentando
suppliche al Signore della storia e delle coscienze umane.
Tra le suppliche più ardenti di
questa ora eccezionale, all'avvicinarsi del nuovo Millennio, la Chiesa
implora dal Signore che cresca l'unità tra tutti i cristiani delle
diverse Confessioni fino al raggiungimento della piena comunione.
Esprimo l'auspicio che il Giubileo sia l'occasione propizia di una
fruttuosa collaborazione nella messa in comune delle tante cose che ci
uniscono e che sono certamente di più di quelle che ci dividono.
Quanto gioverebbe in tale prospettiva che, nel rispetto dei programmi
delle singole Chiese e Comunità, si raggiungessero intese ecumeniche
nella preparazione e realizzazione del Giubileo: esso acquisterà così
ancora più forza testimoniando al mondo la decisa volontà di tutti i
discepoli di Cristo di conseguire al più presto la piena unità nella
certezza che « nulla è impossibile a Dio ».
III
LA
PREPARAZIONE DEL GRANDE GIUBILEO
17. Ogni giubileo è preparato
nella storia della Chiesa dalla divina Provvidenza. Ciò vale
anche per il Grande Giubileo dell'Anno 2000. Convinti di ciò, noi
oggi guardiamo con senso di gratitudine non meno che di responsabilità
a quanto è avvenuto nella storia dell'umanità a partire dalla
nascita di Cristo, e soprattutto agli eventi tra il Mille e il
Duemila. Ma in modo tutto particolare ci volgiamo con sguardo di fede
a questo nostro secolo, cercandovi ciò che rende testimonianza non
solo alla storia dell'uomo, ma anche all'intervento divino nelle umane
vicende.
18. In questa prospettiva si può
affermare che il Concilio Vaticano II costituisce un evento
provvidenziale, attraverso il quale la Chiesa ha avviato la
preparazione prossima al Giubileo del secondo Millennio. Si tratta
infatti di un Concilio simile ai precedenti, eppure tanto diverso; un
Concilio concentrato sul mistero di Cristo e della sua Chiesa ed
insieme aperto al mondo. Questa apertura è stata la risposta
evangelica all'evoluzione recente del mondo con le sconvolgenti
esperienze del XX secolo, travagliato da una prima e da una seconda
guerra mondiale, dall'esperienza dei campi di concentramento e da
orrendi eccidi. Quanto è successo mostra più che mai che il mondo ha
bisogno di purificazione; ha bisogno di conversione.
Si ritiene spesso che il Concilio
Vaticano II segni una epoca nuova nella vita della Chiesa. Ciò è
vero, ma allo stesso tempo è difficile non notare che l'Assemblea
conciliare ha attinto molto dalle esperienze e dalle riflessioni del
periodo precedente, specialmente dal patrimonio del pensiero di
Pio XII. Nella storia della Chiesa, « il vecchio » e « il nuovo »
sono sempre profondamente intrecciati tra loro. Il « nuovo » cresce
dal « vecchio », il « vecchio » trova nel « nuovo » una sua più
piena espressione. Così è stato per il Concilio Vaticano II e per
l'attività dei Pontefici legati all'Assemblea conciliare, iniziando
da Giovanni XXIII, proseguendo con Paolo VI e Giovanni Paolo I, fino
al Papa attuale.
Ciò che è stato da essi compiuto
durante e dopo il Concilio, il magistero non meno che l'azione di
ciascuno di loro ha certamente recato un contributo significativo alla
preparazione di quella nuova primavera di vita cristiana che
dovrà essere rivelata dal Grande Giubileo, se i cristiani saranno
docili all'azione dello Spirito Santo.
19. Il Concilio, pur non assumendo
i toni severi di Giovanni Battista, quando sulle rive del Giordano
esortava alla penitenza ed alla conversione (cf. Lc 3, 1-17),
ha manifestato in sé qualcosa dell'antico Profeta, additando con
nuovo vigore agli uomini di oggi il Cristo, l'« Agnello di Dio, colui
che toglie il peccato del mondo » (cf. Gv 1, 29), il Redentore
dell'uomo, il Signore della storia. Nell'Assise conciliare la Chiesa,
proprio per essere pienamente fedele al suo Maestro, si è interrogata
sulla propria identità, riscoprendo la profondità del suo mistero di
Corpo e di Sposa di Cristo. Ponendosi in docile ascolto della Parola
di Dio, ha riaffermato la universale vocazione alla santità; ha
provveduto alla riforma della liturgia, « fonte e culmine » della
sua vita; ha dato impulso al rinnovamento di tanti aspetti della sua
esistenza a livello universale e nelle Chiese locali; si è impegnata
per la promozione delle varie vocazioni cristiane, da quella dei laici
a quella dei religiosi, dal ministero dei diaconi a quello dei
sacerdoti e dei Vescovi; ha riscoperto, in particolare, la collegialità
episcopale, espressione privilegiata del servizio pastorale svolto dai
Vescovi in comunione col Successore di Pietro. Sulla base di questo
profondo rinnovamento, il Concilio si è aperto ai cristiani delle
altre Confessioni, agli aderenti ad altre religioni, a tutti gli
uomini del nostro tempo. In nessun altro Concilio si è parlato con
altrettanta chiarezza dell'unità dei cristiani, del dialogo con le
religioni non cristiane, del significato specifico dell'Antica
Alleanza e di Israele, della dignità della coscienza personale, del
principio della libertà religiosa, delle diverse tradizioni culturali
all'interno delle quali la Chiesa svolge il proprio mandato
missionario, dei mezzi di comunicazione sociale.
20. Un'enorme ricchezza di
contenuti ed un nuovo tono, prima sconosciuto, nella
presentazione conciliare di questi contenuti, costituiscono quasi un
annuncio di tempi nuovi. I Padri conciliari hanno parlato con il
linguaggio del Vangelo, con il linguaggio del Discorso della Montagna
e delle Beatitudini. Nel messaggio conciliare Dio è presentato nella
sua assoluta signoria su tutte le cose, ma anche come garante
dell'autentica autonomia delle realtà temporali.
La miglior preparazione alla
scadenza bimillenaria, pertanto, non potrà che esprimersi nel
rinnovato impegno di applicazione, per quanto possibile fedele,
dell'insegnamento del Vaticano II alla vita di ciascuno e di tutta
la Chiesa. Con il Concilio è stata come inaugurata l'immediata
preparazione al Grande Giubileo del 2000, nel senso più ampio della
parola. Se cerchiamo qualcosa di analogo nella liturgia, si potrebbe
dire che l'annualeliturgia dell'Avvento è il tempo più vicino
allo spirito del Concilio. L'Avvento ci prepara, infatti, all'incontro
con Colui che era, che è e che costantemente viene (cf. Ap 4,
8).
21. Nel cammino di preparazione
all'appuntamento del 2000 si inserisce la serie di Sinodi, iniziata
dopo il Concilio Vaticano II: Sinodi generali e Sinodi continentali,
regionali, nazionali e diocesani. Il tema di fondo è quello
dell'evangelizzazione, anzi della nuova evangelizzazione, le cui
basi sono state poste dall'Esortazione apostolica Evangelii
nuntiandi di Paolo VI, pubblicata nel 1975 dopo la terza Assemblea
Generale del Sinodo dei Vescovi. Questi Sinodi costituiscono già per
se stessi parte della nuova evangelizzazione: nascono dalla visione
del Concilio Vaticano II sulla Chiesa; aprono un ampio spazio alla
partecipazione dei laici, dei quali definiscono la specifica
responsabilità nella Chiesa; sono espressione della forza che Cristo
ha donato a tutto il Popolo di Dio, facendolo partecipe della propria
missione messianica, missione profetica, sacerdotale e regale. Molto
eloquenti sono a tale riguardo le affermazioni del secondo capitolo
della Costituzione dogmatica Lumen gentium. La preparazione al
Giubileo dell'Anno 2000 si attua così, a livello universale e locale,
in tutta la Chiesa, animata da una consapevolezza nuova della
missione salvifica ricevuta da Cristo. Questa consapevolezza si
manifesta con significativa evidenza nelle Esortazioni postsinodali
dedicate alla missione dei laici, alla formazione dei sacerdoti, alla
catechesi, alla famiglia, al valore della penitenza e della
riconciliazione nella vita della Chiesa e dell'umanità e,
prossimamente, alla vita consacrata.
22. Specifici compiti e
responsabilità, in vista del Grande Giubileo dell'Anno 2000, spettano
al ministero del Vescovo di Roma. In qualche modo hanno operato
in questa prospettiva tutti i Pontefici del secolo che sta per
concludersi. Col programma di rinnovare tutto in Cristo, san Pio X
cercò di prevenire i tragici sviluppi che la situazione
internazionale di inizio del secolo andava maturando. La Chiesa era
consapevole di dover agire in modo deciso per favorire e difendere i
beni così fondamentali della pace e della giustizia, di fronte
all'affermarsi nel mondo contemporaneo di tendenze opposte. I
Pontefici del periodo preconciliare si mossero in tal senso con grande
impegno, ciascuno da una propria angolatura particolare: Benedetto XV
si trovò di fronte alla tragedia della prima guerra mondiale; Pio XI
dovette misurarsi con le minacce dei sistemi totalitari o non
rispettosi della libertà umana in Germania, in Russia, in Italia, in
Spagna e, prima ancora, in Messico. Pio XII intervenne nei confronti
della gravissima ingiustizia rappresentata dal totale disprezzo della
dignità umana, quale si ebbe durante la seconda guerra mondiale. Egli
diede luminosi orientamenti anche per la nascita di un nuovo assetto
mondiale dopo la caduta dei sistemi politici antecedenti.
Nel corso del secolo, inoltre,
sulle orme di Leone XIII, i Papi hanno ripreso sistematicamente i temi
della dottrina sociale cattolica, trattando delle caratteristiche di
un giusto sistema nel campo dei rapporti tra lavoro e capitale.
Basti pensare all'Enciclica Quadragesimo anno di Pio XI, ai
numerosi interventi di Pio XII, alla Mater et Magistra e alla Pacem
in terris di Giovanni XXIII, alla Populorum progressio e
alla Lettera Apostolica Octogesima adveniens di Paolo VI.
Sull'argomento sono ritornato ripetutamente io stesso, dedicando
l'Enciclica Laborem exercens in modo specifico all'importanza
del lavoro umano, mentre con la Centesimus annus ho inteso
ribadire, dopo cento anni, la validità della dottrina della Rerum
novarum. Con l'Enciclica Sollicitudo rei socialis avevo
precedentemente riproposto in modo sistematico l'intera dottrina
sociale della Chiesa sullo sfondo del confronto tra i due blocchi
Est-Ovest e del pericolo di una guerra nucleare. I due elementi della
dottrina sociale della Chiesa — la tutela della dignità e dei
diritti della persona nell'ambito di un giusto rapporto tra lavoro
e capitale e la promozione della pace — si sono incontrati in
tale testo e si sono fusi insieme. Alla causa della pace intendono
inoltre servire gli annuali Messaggi pontifici del 1o gennaio,
pubblicati a partire dal 1968, sotto il pontificato di Paolo VI.
23. L'attuale pontificato sin
dal primo documento parla del Grande Giubileo in modo esplicito, invitando
a vivere il periodo di attesa come « un nuovo avvento ».(9) Su
questo tema è ritornato poi molte altre volte, soffermandovisi
ampiamente nell'Enciclica Dominum et vivificantem.(10) Di
fatto, la preparazione dell'Anno 2000 diventa quasi una sua chiave
ermeneutica. Non si vuole certo indulgere ad un nuovo
millenarismo, come da parte di qualcuno si fece allo scadere del primo
millennio; si vuole invece suscitare una particolare sensibilità
per tutto ciò che lo Spirito dice alla Chiesa e alle Chiese (cf. Ap
2, 7 ss.), come pure alle singole persone attraverso i carismi al
servizio dell'intera comunità. Si intende sottolineare ciò che lo
Spirito suggerisce alle varie comunità, dalle più piccole, come la
famiglia, sino alle più grandi come le nazioni e le organizzazioni
internazionali, senza trascurare le culture, le civiltà e le sane
tradizioni. L'umanità, nonostante le apparenze, continua ad attendere
la rivelazione dei figli di Dio e vive di tale speranza come nel
travaglio del parto, secondo l'immagine utilizzata con tanta forza da
san Paolo nella Lettera ai Romani (cf. 8, 19-22).
24. I pellegrinaggi del Papa sono
divenuti un elemento importante nell'impegno di realizzazione del
Concilio Vaticano II. Iniziati da Giovanni XXIII, nell'imminenza
dell'inaugurazione del Concilio, con un pellegrinaggio significativo a
Loreto e ad Assisi (1962), hanno avuto un cospicuo incremento con
Paolo VI, il quale, dopo essersi recato anzitutto in Terra Santa
(1964), compì altri nove grandi viaggi apostolici che lo portarono a
diretto contatto con le popolazioni dei vari continenti.
Il pontificato attuale ha ampliato
ancor più tale programma, cominciando dal Messico, in occasione della
III Conferenza Generale dell'Episcopato Latino Americano, tenutasi a
Puebla nel 1979. Vi è stato poi, in quello stesso anno, il
pellegrinaggio in Polonia durante il Giubileo per il 900o anniversario
della morte di santo Stanislao vescovo e martire.
Le successive tappe di questo
peregrinare sono conosciute. I pellegrinaggi sono diventati
sistematici, raggiungendo le Chiese particolari in tutti i continenti,
con una cura attenta per lo sviluppo dei rapporti ecumenici con
i cristiani delle diverse confessioni. Sotto quest'ultimo profilo
rivestono un rilievo particolare le visite in Turchia (1979), in
Germania (1980), in Inghilterra e Galles e in Scozia (1982), in
Svizzera (1984), nei Paesi Scandinavi (1989) ed ultimamente nei Paesi
Baltici (1993).
Al momento presente, tra le mete
di pellegrinaggio vivamente desiderate, vi è, oltre a Sarajevo in
Bosnia ed Erzegovina, il Medio Oriente: il Libano, Gerusalemme e la
Terra Santa. Sarebbe molto eloquente se, in occasione dell'Anno 2000,
fosse possibile visitare tutti quei luoghi che si trovano sul
cammino del Popolo di Dio dell'Antica Alleanza, a partire dai
luoghi di Abramo e di Mosè, attraverso l'Egitto e il Monte Sinai,
fino a Damasco, città che fu testimone della conversione di san
Paolo.
25. Nella preparazione dell'Anno
2000 hanno un proprio ruolo da svolgere le singole Chiese, che
con i loro Giubilei celebrano tappe significative nella storia della
salvezza dei diversi popoli. Tra questi Giubilei locali o
regionali, eventi di somma grandezza sono stati il millennio del
Battesimo della Rus' nel 1988,(11) come pure i cinquecento anni
dall'inizio della evangelizzazione nel continente americano (1492).
Accanto ad eventi di così vasto raggio, anche se non di portata
universale, occorre ricordarne altri non meno significativi: per
esempio, il millennio del Battesimo della Polonia nel 1966 e del
Battesimo dell'Ungheria nel 1968, insieme con i seicento anni del
Battesimo della Lituania nel 1987. Ricorreranno inoltre prossimamente
il 1500° anniversario del Battesimo di Clodoveo re dei Franchi (496),
e il 1400° anniversario dell'arrivo di sant'Agostino a Canterbury
(597), inizio dell'evangelizzazione del mondo anglosassone.
Per quanto riguarda l'Asia, il
Giubileo riporterà il pensiero all'apostolo Tommaso, che già
all'inizio dell'era cristiana, secondo la tradizione, recò l'annuncio
evangelico in India, dove intorno al 1500 sarebbero poi giunti i
missionari dal Portogallo. Cade quest'anno il settimo centenario
dell'evangelizzazione della Cina (1294) e ci apprestiamo a fare
memoria della diffusione dell'opera missionaria nelle Filippine con la
costituzione della sede metropolitana di Manila (1595), come del
quarto centenario dei primi martiri in Giappone (1597).
In Africa, dove pure il primo
annuncio risale all'epoca apostolica, insieme ai 1650 anni della
consacrazione episcopale del primo Vescovo degli Etiopi, san Frumenzio
(c. 340) e ai cinquecento anni dall'inizio dell'evangelizzazione
dell'Angola nell'antico regno del Congo (1491), nazioni quali il
Camerun, la Costa d'Avorio, la Repubblica Centroafricana, il Burundi,
il Burkina-Faso stanno celebrando i rispettivi centenari dell'arrivo
dei primi missionari nei loro territori. Altre nazioni africane lo
hanno celebrato da poco.
Come tacere poi delle Chiese
d'Oriente, i cui antichi Patriarcati si richiamano così da vicino
all'eredità apostolica e le cui venerande tradizioni teologiche,
liturgiche e spirituali costituiscono un'enorme ricchezza, che è
patrimonio comune di tutta la cristianità? Le molteplici ricorrenze
giubilari di queste Chiese e delle Comunità che in esse riconoscono
l'origine della loro apostolicità evocano il cammino di Cristo nei
secoli e approdano anch'esse al grande Giubileo della fine del secondo
millennio.
Vista in questa luce, tutta la
storia cristiana ci appare come un unico fiume, al quale molti
affluenti recano le loro acque. L'Anno 2000 ci invita ad incontrarci
con rinnovata fedeltà e con approfondita comunione sulle sponde di
questo grande fiume: il fiume della Rivelazione, del cristianesimo
e della Chiesa, che scorre attraverso la storia dell'umanità a
partire dall'evento accaduto a Nazaret, e poi a Betlemme duemila anni
fa. È veramente il « fiume » che con i suoi « ruscelli », secondo
l'espressione del Salmo, « rallegra la città di Dio » (cf. Sal 46
1, 5).
26. Nella prospettiva della
preparazione dell'Anno 2000 si situano anche gli Anni Santi dell'ultimo
scorcio di questo secolo. È ancora fresco nella memoria l'Anno
Santo che il Papa Paolo VI indisse nel 1975; nella stessa
linea è stato celebrato successivamente il 1983 come Anno della
Redenzione. Un'eco forse ancora maggiore ha avuto l'Anno
Mariano 1987-88, molto atteso e vissuto profondamente nelle
singole Chiese locali, specialmente nei santuari mariani del mondo
intero. L'Enciclica Redemptoris Mater, allora pubblicata, ha
posto in evidenza l'insegnamento conciliare sulla presenza della Madre
di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa: il Figlio di Dio duemila
anni fa si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato
dall'Immacolata Vergine Maria. L'Anno Mariano è stato quasi una
anticipazione del Giubileo, contenendo in sé molto di quanto dovrà
esprimersi pienamente nell'Anno 2000.
27. È difficile non rilevare che
l'Anno Mariano ha preceduto da vicino gli eventi del 1989. Sono
eventi che non possono non sorprendere per la loro vastità e
specialmente per il loro rapido svolgimento. Gli anni ottanta si erano
andati caricando di un pericolo crescente, sulla scia della « guerra
fredda »; il 1989 ha portato con sé una soluzione pacifica, che ha
avuto quasi la forma di uno sviluppo « organico ». Alla sua luce ci
si sente indotti a riconoscere un significato addirittura profetico
all'Enciclica Rerum novarum: quanto il Papa Leone XIII vi
scrive sul tema del comunismo trova in questi eventi una puntuale
verifica, come ho sottolineato nell'Enciclica Centesimus annus.(12)
Si poteva del resto percepire che, nella trama di quanto accaduto, era
all'opera con premura materna la mano invisibile della Provvidenza: «
Si dimentica for se una donna del suo bambino...? » (Is 49,
15).
Dopo il 1989 sono emersi, però, nuovi
pericoli e nuove minacce. Nei Paesi dell'ex blocco orientale, dopo
la caduta del comunismo, è apparso il grave rischio dei nazionalismi,
come mostrano purtroppo le vicende dei Balcani e di altre aree vicine.
Ciò costringe le nazioni europee ad un serio esame di coscienza, nel
riconoscimento di colpe ed errori storicamente commessi, in campo
economico e politico, nei riguardi di nazioni i cui diritti sono stati
sistematicamente violati dagli imperialismi sia del secolo scorso che
del presente.
28. Attualmente, sulla scia
dell'Anno Mariano, stiamo vivendo, in analoga prospettiva, l'Anno
della Famiglia, il cui contenuto si collega strettamente col
mistero dell'Incarnazione e con la storia stessa dell'uomo. Si può
dunque nutrire la speranza che l'Anno della Famiglia, inaugurato a
Nazaret, diventi, come l'Anno Mariano, una ulteriore, significativa
tappa della preparazione al Grande Giubileo.
In tale prospettiva ho indirizzato
una Lettera alle Famiglie, nella quale ho inteso riproporre la
sostanza dell'insegnamento ecclesiale sulla famiglia portandolo, per
così dire, all'interno di ogni focolare domestico. Nel Concilio
Vaticano II la Chiesa ha riconosciuto come uno dei suoi compiti quello
di valorizzare la dignità del Matrimonio e della famiglia.(13) L'Anno
della Famiglia intende contribuire all'attuazione del Concilio in
questa dimensione. È perciò necessario che la preparazione al
Grande Giubileo passi, in un certo senso, attraverso ogni famiglia. Non
è stato forse attraverso una famiglia, quella di Nazaret, che il
Figlio di Dio ha voluto entrare nella storia dell'uomo?
IV
LA
PREPARAZIONE IMMEDIATA
29. Sullo sfondo di questo vasto
panorama sorge la domanda: si può ipotizzare uno specifico
programma di iniziative per la preparazione immediata del
Grande Giubileo? Per la verità, quanto sopra si è detto già
presenta alcuni elementi di un tale programma.
Una previsione più dettagliata di
iniziative « ad hoc », per non essere artificiale e di difficile
applicazione nelle singole Chiese, che vivono in condizioni così
diversificate, deve risultare da una consultazione allargata.
Consapevole di ciò, ho voluto interpellare al riguardo i Presidenti
delle Conferenze Episcopali e, in particolare, i Padri Cardinali.
Sono riconoscente ai venerati
Membri del Collegio Cardinalizio che, riuniti in Concistoro
Straordinario il 13 e 14 giugno 1994, hanno elaborato in merito
numerose proposte ed hanno indicato utili orientamenti. Ugualmente
ringrazio i Fratelli nell'Episcopato, i quali in vario modo non hanno
mancato di farmi pervenire apprezzati suggerimenti, che ho ben tenuto
presenti nello stendere questa mia Lettera Apostolica.
30. Una prima indicazione, emersa
con chiarezza dalla consultazione, è quella relativa ai tempi
della preparazione. Al 2000 mancano ormai pochi anni: è sembrato
opportuno articolare questo periodo in due fasi riservando la
fase propriamente preparatoria agli ultimi tre anni. Si è
ritenuto infatti che un periodo più lungo avrebbe finito per
accumulare eccessivi contenuti, attenuando la tensione spirituale.
Si è giudicato pertanto
conveniente avvicinarsi alla storica data con una prima fase di
sensibilizzazione dei fedeli su tematiche più generali, per poi
concentrare la preparazione diretta e immediata in una seconda
fase, quella appunto di un triennio, tutta orientata alla
celebrazione del mistero di Cristo Salvatore.
a) Prima fase
31. La prima fase avrà
dunque carattere antepreparatorio: dovrà servire a ravvivare
nel popolo cristiano la coscienza del valore e del significato che il
Giubileo del 2000 riveste nella storia umana. Recando con sé
la memoria della nascita di Cristo, esso è intrinsecamente segnato
da una connotazione cristologica.
Conformemente all'articolazione
della fede cristiana in parola e sacramento, sembra importante unire
insieme, anche in questa singolare ricorrenza, la struttura della memoria
con quella dellacelebrazione, non limitandosi a ricordare
l'evento solo concettualmente, ma rendendone presente il valore
salvifico mediante l'attualizzazione sacramentale. La ricorrenza
giubilare dovrà confermare nei cristiani di oggi la fede in
Dio rivelatosi in Cristo, sostenerne la speranza protesa
nell'aspettativa della vita eterna, ravvivarne la carità, operosamente
impegnata nel servizio ai fratelli.
Nel corso della prima fase (dal
1994 al 1996) la Santa Sede, grazie anche alla creazione di un
apposito Comitato, non mancherà di suggerire alcune linee di
riflessione e di azione a livello universale, mentre un analogo
impegno di sensibilizzazione sarà svolto, in maniera più capillare,
da Commissioni simili nelle Chiese locali. Si tratta, in
qualche modo, di continuare quanto realizzato nella preparazione
remota e, contemporaneamente, di approfondire gli aspetti più
caratteristici dell'evento giubilare.
32. Il Giubileo è sempre un tempo
di particolare grazia, « un giorno benedetto dal Signore »: come
tale, esso ha — lo si è già rilevato — un carattere gioioso. Il
Giubileo dell'Anno 2000 vuol essere una grande preghiera di lode e
di ringraziamento soprattutto per il dono dell'Incarnazione del
Figlio di Dio e della Redenzione da Lui operata. Nell'anno
giubilare i cristiani si porranno con rinnovato stupore di fede di
fronte all'amore del Padre, che ha dato il suo Figlio, « perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna » (Gv 3,
16). Essi eleveranno inoltre con intima partecipazione il loro
ringraziamento per il dono della Chiesa, fondata da Cristo come
« sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e
dell'unità di tutto il genere umano ».(14) Il loro ringraziamento si
estenderà infine ai frutti di santità maturati nella vita di
tanti uomini e donne che in ogni generazione ed in ogni epoca storica
hanno saputo accogliere senza riserve il dono della Redenzione.
Tuttavia la gioia di ogni Giubileo
è in particolare modo unagioia per la remissione delle colpe, la
gioia della conversione. Sembra perciò opportuno mettere
nuovamente in primo piano ciò che costituì il tema del Sinodo dei
Vescovi nel 1984, cioè la penitenza e la riconciliazione.(15)
Quel Sinodo fu un evento estremamente significativo nella storia della
Chiesa postconciliare. Esso riprese la questione sempre attuale della
conversione (« metanoia »), che è la condizione preliminare per la
riconciliazione con Dio tanto delle singole persone quanto delle
comunità.
33. È giusto pertanto che, mentre
il secondo Millennio del cristianesimo volge al termine, la Chiesa si
faccia carico con più viva consapevolezza del peccato dei suoi figli
nel ricordo di tutte quelle circostanze in cui, nell'arco della
storia, essi si sono allontanati dallo spirito di Cristo e del suo
Vangelo, offrendo al mondo, anziché la testimonianza di una vita
ispirata ai valori della fede, lo spettacolo di modi di pensare e di
agire che erano vere forme di antitestimonianza e di scandalo.
La Chiesa, pur essendo santa per
la sua incorporazione a Cristo, non si stanca di fare penitenza: essa riconosce
sempre come propri, davanti a Dio e davanti agli uomini, i
figli peccatori. Afferma al riguardo la Lumen gentium: «
La Chiesa che comprende nel suo seno i peccatori, santa insieme e
sempre bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla
penitenza e al suo rinnovamento ».(16)
La Porta Santa del Giubileo del
2000 dovrà essere simbolicamente più grande delle precedenti, perché
l'umanità, giunta a quel traguardo, si lascerà alle spalle non
soltanto un secolo, ma un millennio. È bene che la Chiesa imbocchi
questo passaggio con la chiara coscienza di ciò che ha vissuto nel
corso degli ultimi dieci secoli. Essa non può varcare la soglia del
nuovo millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi, nel
pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze, ritardi. Riconoscere i
cedimenti di ieri è atto di lealtà e di coraggio che ci aiuta a
rafforzare la nostra fede, rendendoci avvertiti e pronti ad affrontare
le tentazioni e le difficoltà dell'oggi.
34. Tra i peccati che esigono un
maggiore impegno di penitenza e di conversione devono essere
annoverati certamente quelli che hanno pregiudicato l'unità voluta
da Dio per il suo Popolo. Nel corso dei mille anni che si stanno
concludendo, ancor più che nel primo millennio, la comunione
ecclesiale, « talora non senza colpa di uomini d'entrambe le parti »,(17)
ha conosciuto dolorose lacerazioni che contraddicono apertamente alla
volontà di Cristo e sono di scandalo al mondo.(18) Tali peccati del
passato fanno sentire ancora, purtroppo, il loro peso e permangono
come altrettante tentazioni anche nel presente. È necessario farne
ammenda, invocando con forza il perdono di Cristo.
In quest'ultimo scorcio di
millennio, la Chiesa deve rivolgersi con più accorata supplica allo
Spirito Santo implorando da Lui la grazia dell'unità dei
cristiani. È questo un problema cruciale per la testimonianza
evangelica nel mondo. Soprattutto dopo il Concilio Vaticano II sono
state molte le iniziative ecumeniche intraprese con generosità ed
impegno: si può dire che tutta l'attività delle Chiese locali e
della Sede Apostolica abbia assunto in questi anni un respiro
ecumenico. Il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità
dei Cristiani è divenuto uno dei principali centri propulsori del
processo verso la piena unità.
Siamo però tutti consapevoli che
il raggiungimento di questo traguardo non può essere solo frutto di
sforzi umani, pur indispensabili. L'unità, in definitiva, è dono
dello Spirito Santo. A noi è chiesto di assecondare questo dono
senza indulgere a leggerezze e reticenze nella testimonianza della
verità, ma mettendo in atto generosamente le direttive tracciate dal
Concilio e dai successivi documenti della Santa Sede, apprezzati anche
da molti tra i cristiani non in piena comunione con la Chiesa
cattolica.
Ecco, dunque, uno dei compiti dei
cristiani incamminati verso l'anno 2000. L'avvicinarsi della fine del
secondo millennio sollecita tutti ad un esame di coscienza e ad
opportune iniziative ecumeniche, così che al Grande Giubileo ci si
possa presentare, se non del tutto uniti, almeno molto più
prossimi a superare le divisioni del secondo millennio. È
necessario al riguardo — ognuno lo vede — uno sforzo enorme.
Bisogna proseguire nel dialogo dottrinale, ma soprattutto impegnarsi
di più nellapreghiera ecumenica. Essa s'è molto intensificata
dopo il Concilio, ma deve crescere ancora coinvolgendo sempre più i
cristiani, in sintonia con la grande invocazione di Cristo, prima
della Passione: « Padre ... siano anch'essi in noi una cosa sola » (Gv
17, 21).
35. Un altro capitolo doloroso,
sul quale i figli della Chiesa non possono non tornare con animo
aperto al pentimento, è costituito dall'acquiescenza manifestata,
specie in alcuni secoli, a metodi di intolleranza e persino di
violenza nel servizio alla verità.
È vero che un corretto giudizio
storico non può prescindere da un'attenta considerazione dei
condizionamenti culturali del momento, sotto il cui influsso molti
possono aver ritenuto in buona fede che un'autentica testimonianza
alla verità comportasse il soffocamento dell'altrui opinione o almeno
la sua emarginazione. Molteplici motivi spesso convergevano nel creare
premesse di intolleranza, alimentando un'atmosfera passionale alla
quale solo grandi spiriti veramente liberi e pieni di Dio riuscivano
in qualche modo a sottrarsi. Ma la considerazione delle circostanze
attenuanti non esonera la Chiesa dal dovere di rammaricarsi
profondamente per le debolezze di tanti suoi figli, che ne hanno
deturpato il volto, impedendole di riflettere pienamente l'immagine
del suo Signore crocifisso, testimone insuperabile di amore paziente e
di umile mitezza. Da quei tratti dolorosi del passato emerge una
lezione per il futuro, che deve indurre ogni cristiano a tenersi ben
saldo all'aureo principio dettato dal Concilio: « La verità non si
impone che in forza della stessa verità, la quale penetra nelle menti
soavemente e insieme con vigore ».(19)
36. Un serio esame di coscienza è
stato auspicato da numerosi Cardinali e Vescovi soprattutto per la
Chiesa del presente. Alle soglie del nuovo Millennio i cristiani
devono porsi umilmente davanti al Signore per interrogarsi sulle
responsabilità che anch'essi hanno nei confronti dei mali del nostro
tempo. L'epoca attuale, infatti, accanto a molte luci, presenta
anche non poche ombre.
Come tacere, ad esempio, dell'indifferenza
religiosa, che porta molti uomini di oggi a vivere come se Dio non
ci fosse o ad accontentarsi di una religiosità vaga, incapace di
misurarsi con il problema della verità e con il dovere della
coerenza? A ciò sono da collegare anche la diffusa perdita del senso
trascendente dell'esistenza umana e lo smarrimento in campo etico,
persino nei valori fondamentali del rispetto della vita e della
famiglia. Una verifica si impone pure ai figli della Chiesa: quanto
sono anch'essi toccati dall'atmosfera di secolarismo e relativismo
etico? E quanta parte di responsabilità devono anch'essi riconoscere,
di fronte alla dilagante irreligiosità, per non aver manifestato il
genuino volto di Dio, a causa dei « difetti della propria vita
religiosa, morale e sociale »? (20)
Non si può infatti negare che la
vita spirituale attraversi, in molti cristiani, un momento di
incertezza che coinvolge non solo la vita morale, ma anche la
preghiera e la stessa rettitudine teologale della fede. Questa,
già messa alla prova dal confronto col nostro tempo, è talvolta
disorientata da indirizzi teologici erronei, che si diffondono anche a
causa della crisi di obbedienza nei confronti del Magistero della
Chiesa.
E quanto alla testimonianza della
Chiesa nel nostro tempo, come non provare dolore per il mancato
discernimento, diventato talvolta persino acquiescenza, di non
pochi cristiani di fronte alla violazione di fondamentali diritti
umani da parte di regimi totalitari? E non è forse da lamentare, tra
le ombre del presente, la corresponsabilità di tanti cristiani in
gravi forme di ingiustizia e di emarginazione sociale? C'è da
chiedersi quanti, tra essi, conoscano a fondo e pratichino
coerentemente le direttive della dottrina sociale della Chiesa.
L'esame di coscienza non può non
riguardare anche la ricezione del Concilio, questo grande dono
dello Spirito alla Chiesa sul finire del secondo millennio. In che
misura la Parola di Dio è divenuta più pienamente anima della
teologia e ispiratrice di tutta l'esistenza cristiana, come chiedeva
la Dei Verbum? È vissuta la liturgia come « fonte e culmine
» della vita ecclesiale, secondo l'insegnamento della Sacrosanctum
Concilium? Si consolida, nella Chiesa universale e in quelle
particolari, l'ecclesiologia di comunione della Lumen gentium, dando
spazio ai carismi, ai ministeri, alle varie forme di partecipazione
del Popolo di Dio, pur senza indulgere a un democraticismo e a un
sociologismo che non rispecchiano la visione cattolica della Chiesa e
l'autentico spirito del Vaticano II? Una domanda vitale deve
riguardare anche lo stile dei rapporti tra Chiesa e mondo. Le
direttive conciliari — offerte nella Gaudium et spes e in
altri documenti — di un dialogo aperto, rispettoso e cordiale,
accompagnato tuttavia da un attento discernimento e dalla coraggiosa
testimonianza della verità, restano valide e ci chiamano a un impegno
ulteriore.
37. La Chiesa del primo millennio
nacque dal sangue dei martiri: «Sanguis martyrum - semen
christianorum ».(21) Gli eventi storici legati alla figura di
Costantino il Grande non avrebbero mai potuto garantire uno sviluppo
della Chiesa quale si verificò nel primo millennio, se non fosse
stato per quella seminagione di martiri e per quel patrimonio di
santità che caratterizzarono le prime generazioni cristiane. Al
termine del secondo millennio, la Chiesa è diventata nuovamente
Chiesa di martiri. Le persecuzioni nei riguardi dei credenti —
sacerdoti, religiosi e laici — hanno operato una grande semina di
martiri in varie parti del mondo. La testimonianza resa a Cristo sino
allo spargimento del sangue è divenuta patrimonio comune di
cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti, come rilevava già
Paolo VI nella omelia per la canonizzazione dei martiri ugandesi.(22)
È una testimonianza da non
dimenticare. La Chiesa dei
primi secoli, pur incontrando notevoli difficoltà organizzative, si
è adoperata per fissare in appositi martirologi la testimonianza dei
martiri. Tali martirologi sono stati aggiornati costantemente
attraverso i secoli, e nell'albo dei santi e dei beati della Chiesa
sono entrati non soltanto coloro che hanno versato il sangue per
Cristo, ma anche maestri della fede, missionari, confessori, vescovi,
presbiteri, vergini, coniugi, vedove, figli.
Nel nostro secolo sono
ritornati i martiri, spesso
sconosciuti, quasi « militi ignoti » della grande causa di Dio. Per
quanto è possibile non devono andare perdute nella Chiesa le loro
testimonianze. Come è stato suggerito nel Concistoro, occorre che
le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria
di quanti hanno subito il martirio, raccogliendo la necessaria
documentazione. Ciò non potrà non avere anche un respiro ed una
eloquenza ecumenica. L'ecumenismo dei santi, dei martiri, è
forse il più convincente. La communio sanctorum parla con voce
più alta dei fattori di divisione. Il martyrologium dei primi
secoli costituì la base del culto dei santi. Proclamando e venerando
la santità dei suoi figli e figlie, la Chiesa rendeva sommo onore a
Dio stesso; nei martiri venerava il Cristo, che era all'origine del
loro martirio e della loro santità. Si è sviluppata successivamente
la prassi della canonizzazione, che tuttora perdura nella Chiesa
cattolica e in quelle ortodosse. In questi anni si sono moltiplicate
le canonizzazioni e le beatificazioni. Esse manifestano la vivacità
delle Chiese locali, molto più numerose oggi che nei primi secoli
e nel primo millennio. Il più grande omaggio, che tutte le Chiese
renderanno a Cristo alla soglia del terzo millennio, sarà la
dimostrazione dell'onnipotente presenza del Redentore mediante i
frutti di fede, di speranza e di carità in uomini e donne di tante
lingue e razze, che hanno seguito Cristo nelle varie forme della
vocazione cristiana.
Sarà compito della Sede
Apostolica, nella prospettiva del terzo Millennio, aggiornare i
martirologi per la Chiesa universale, prestando grande attenzione
alla santità di quanti anche nel nostro tempo sono vissuti
pienamente nella verità di Cristo. In special modo ci si dovrà
adoperare per il riconoscimento dell'eroicità delle virtù di uomini
e donne che hanno realizzato la loro vocazione cristiana nel
Matrimonio: convinti come siamo che anche in tale stato non
mancano frutti di santità, sentiamo il bisogno di trovare le vie più
opportune per verificarli e proporli a tutta la Chiesa a modello e
sprone degli altri sposi cristiani.
38. Un'ulteriore esigenza
sottolineata dai Cardinali e dai Vescovi è quella di Sinodi a
carattere continentale, sulla scia di quelli già celebrati per
l'Europa e per l'Africa. L'ultima Conferenza Generale dell'Episcopato
Latino-americano ha accolto, in sintonia con l'Episcopato
Nord-americano, la proposta di un Sinodo per le Americhe sulle
problematiche della nuova evangelizzazione in due parti dello stesso
continente tanto diverse tra loro per origine e storia, e sulle
tematiche della giustizia e dei rapporti economici internazionali,
tenendo conto dell'enorme divario tra il Nord e il Sud.
Un Sinodo a carattere continentale
sembra opportuno per l'Asia, dove più marcata è la questione
dell'incontro del cristianesimo con le antichissime culture e
religioni locali. Una grande sfida, questa, per l'evangelizzazione,
dato che sistemi religiosi come il buddismo o l'induismo si propongono
con un chiaro carattere soteriologico. Esiste allora l'urgente bisogno
che, in occasione del Grande Giubileo, si illustri e approfondisca la
verità su Cristo come unico Mediatore tra Dio e gli uomini e unico
Redentore del mondo, ben distinguendolo dai fondatori di altre grandi
religioni, nelle quali pur si trovano elementi di verità, che la
Chiesa considera con sincero rispetto, vedendovi un riflesso della
Verità che illumina tutti gli uomini.(23) Nel 2000 dovrà risuonare
con forza rinnovata la proclamazione della verità: « Ecce natus est
nobis Salvator mundi ».
Anche per l'Oceania potrebbe
essere utile un Sinodo regionale. In questo Continente esiste, tra
l'altro, il dato di popolazioni aborigene, che evocano in modo
singolare alcuni aspetti della preistoria del genere umano. In tale
Sinodo, dunque, un tema da non trascurare, insieme con altri problemi
del Continente, dovrebbe essere l'incontro del cristianesimo con
quelle antichissime forme di religiosità, significativamente
caratterizzate da un orientamento monoteistico.
b) Seconda fase
39. Sulla base di questa vasta
azione sensibilizzatrice sarà poi possibile affrontare la seconda
fase, quella propriamente preparatoria. Essa si svilupperà
nell'arco di tre anni, dal 1997 al 1999. La struttura ideale
per tale triennio, centrato su Cristo, Figlio di Dio fatto
uomo, non può che essere teologica, cioè trinitaria.
I anno: Gesù Cristo
40. Il primo anno, 1997,
sarà pertanto dedicato alla riflessione su Cristo, Verbo del
Padre, fattosi uomo per opera dello Spirito Santo. Occorre infatti
porre in luce il carattere spiccatamente cristologico del Giubileo,
che celebrerà l'Incarnazione del Figlio di Dio, mistero di
salvezza per tutto il genere umano. Il tema generale, proposto per
questo anno da molti Cardinali e Vescovi, è: «Gesù Cristo, unico
Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre » (cf. Eb 13, 8).
Tra i contenuti cristologici
prospettati nel Concistoro emergono i seguenti: la riscoperta di
Cristo Salvatore ed Evangelizzatore, con particolare riferimento al
capitolo quarto del Vangelo di Luca, dove il tema del Cristo mandato
ad evangelizzare e quello del Giubileo si intrecciano;
l'approfondimento del mistero della sua Incarnazione e della sua
nascita dal grembo verginale di Maria; la necessità della fede in Lui
per la salvezza. Per conoscere la vera identità di Cristo, occorre
che i cristiani, soprattutto nel corso di questo anno, tornino con
rinnovato interesse alla Bibbia, « sia per mezzo della sacra
liturgia ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per
mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi ».(24)
Nel testo rivelato, infatti, è lo stesso Padre celeste che ci si fa
incontro amorevolmente e si intrattiene con noi manifestandoci la
natura del Figlio unigenito e il suo disegno di salvezza per l'umanità.(25)
41. L'impegno di attualizzazione
sacramentale sopra accennato potrà far leva, nel corso dell'anno,
sulla riscoperta del Battesimo come fondamento dell'esistenza
cristiana, secondo la parola dell'Apostolo: « Quanti siete stati
battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo » (Gal 3,
27). Il Catechismo della Chiesa Cattolica, da parte sua,
ricorda che il Battesimo costituisce « il fondamento della comunione
tra tutti i cristiani, anche con quanti non sono ancora nella piena
comunione con la Chiesa cattolica ».(26) Proprio sotto il profilo
ecumenico, questo sarà un anno molto importante per volgere
insieme lo sguardo a Cristo unico Signore, nell'impegno di diventare
in Lui una cosa sola, secondo la sua preghiera al Padre. La
sottolineatura della centralità di Cristo, della Parola di Dio e
della fede non dovrebbe mancare di suscitare nei cristiani di altre
Confessioni interesse e favorevole accoglienza.
42. Tutto dovrà mirare
all'obiettivo prioritario del Giubileo che è il rinvigorimento
della fede e della testimonianza dei cristiani. È necessario,
pertanto, suscitare in ogni fedele un vero anelito alla santità, un
desiderio forte di conversione e di rinnovamento personale in un clima
di sempre più intensa preghiera e di solidale accoglienza del
prossimo, specialmente quello più bisognoso.
Il primo anno sarà, dunque, il
momento favorevole per la riscoperta della catechesi nel suo
significato e valore originario di « insegnamento degli Apostoli » (At
2, 42) circa la persona di Gesù Cristo ed il suo mistero di
salvezza. Di grande utilità, a questo scopo, si rivelerà
l'approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica, che
presenta « con fedeltà ed in modo organico l'insegnamento della
Sacra Scrittura, della Tradizione vivente nella Chiesa e nel Magistero
autentico, come pure l'eredità spirituale dei Padri, dei santi e
delle sante della Chiesa, per permettere di conoscere meglio il
mistero cristiano e di ravvivare la fede del popolo di Dio ».(27) Per
essere realisti, non si dovrà trascurare di illuminare la coscienza
dei fedeli sugli errori riguardo alla persona di Cristo, mettendo
nella giusta luce le opposizioni contro di Lui e contro la Chiesa.
43. La Vergine Santa, che
sarà presente in modo per così dire « trasversale » lungo tutta la
fase preparatoria, verrà contemplata in questo primo anno soprattutto
nel mistero della sua divina Maternità. È nel suo grembo che il
Verbo si è fatto carne! L'affermazione della centralità di Cristo
non può essere dunque disgiunta dal riconoscimento del ruolo svolto
dalla sua Santissima Madre. Il suo culto, se ben illuminato, in nessun
modo può portare detrimento « alla dignità e all'efficacia di
Cristo, unico Mediatore ».(28) Maria infatti addita perennemente il
suo Figlio divino e si propone a tutti i credenti come modello di
fede vissuta. « La Chiesa, pensando a Lei piamente e
contemplandola alla luce del Verbo fatto uomo, penetra con venerazione
e più profondamente nell'altissimo mistero dell'Incarnazione e si va
ognor più conformando al suo Sposo ».(29)
II anno: lo Spirito Santo
44. Il 1998, secondo anno della
fase preparatoria, sarà dedicato in modo particolare allo Spirito
Santo ed alla sua presenza santificatrice all'interno della
Comunità dei discepoli di Cristo. « Il grande Giubileo, conclusivo
del secondo Millennio — scrivevo nell'Enciclica Dominum et
vivificantem — (...) ha unprofilo pneumatologico, poiché
il mistero dell'incarnazione si è compiuto "per opera dello
Spirito Santo". L'ha "operato" quello Spirito che —
consostanziale al Padre e al Figlio — è, nell'assoluto mistero di
Dio uno e trino, la Persona-amore, il dono increato, che è fonte
eterna di ogni elargizione proveniente da Dio nell'ordine della
creazione, il principio diretto e, in certo senso, il soggetto dell'autocomunicazione
di Dio nell'ordine della grazia. Di questa elargizione, di questa
divina autocomunicazione il mistero dell'Incarnazione costituisce
il culmine ».(30)
La Chiesa non può prepararsi alla
scadenza bimillenaria « in nessun altro modo, se non nello Spirito
Santo. Ciò che "nella pienezza del tempo" si è compiuto
per opera dello Spirito Santo, solo per opera sua può ora emergere
dalla memoria della Chiesa ».(31)
Lo Spirito, infatti, attualizza
nella Chiesa di tutti i tempi e di tutti i luoghi l'unica Rivelazione
portata da Cristo agli uomini, rendendola viva ed efficace nell'animo
di ciascuno: « Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto » (Gv 14, 26).
45. Rientra pertanto negli impegni
primari della preparazione al Giubileo la riscoperta della presenza
e dell'azione dello Spirito, che agisce nella Chiesa sia
sacramentalmente, soprattutto mediante la Confermazione, sia
attraverso molteplici carismi, compiti e ministeri da Lui suscitati
per il bene di essa: « Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità
della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza
proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf. 1
Cor 12, 1-11). Fra questi doni viene al primo posto la grazia
degli Apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche
i carismatici (cf. 1 Cor 14). Ed è ancora lo Spirito stesso
che, con la sua forza e mediante l'intima connessione delle membra,
produce e stimola la carità tra i fedeli ».(32)
Lo Spirito è anche per la nostra
epoca l'agente principale della nuova evangelizzazione. Sarà
dunque importante riscoprire lo Spirito come Colui che costruisce il
Regno di Dio nel corso della storia e prepara la sua piena
manifestazione in Gesù Cristo, animando gli uomini nell'intimo e
facendo germogliare all'interno del vissuto umano i semi della
salvezza definitiva che avverrà alla fine dei tempi.
46. In questa prospettiva
escatologica, i credenti saranno chiamati a riscoprire la virtù
teologale della speranza, di cui hanno « già udito l'annunzio
dalla parola di verità del Vangelo » (Col 1, 5). Il
fondamentale atteggiamento della speranza, da una parte, spinge il
cristiano a non perdere di vista la meta finale che dà senso e valore
all'intera sua esistenza e, dall'altra, gli offre motivazioni solide e
profonde per l'impegno quotidiano nella trasformazione della realtà
per renderla conforme al progetto di Dio.
Come ricorda l'apostolo Paolo: «
Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad
oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Poiché nella
speranza noi siamo stati salvati » (Rm 8, 22-24). I cristiani
sono chiamati a prepararsi al Grande Giubileo dell'inizio del terzo
millennio rinnovando la loro speranza nell'avvento definitivo del
Regno di Dio, preparandolo giorno dopo giorno nel loro intimo,
nella Comunità cristiana a cui appartengono, nel contesto sociale in
cui sono inseriti e così anche nella storia del mondo.
È necessario inoltre che siano
valorizzati ed approfonditi i segni di speranza presenti in questo
ultimo scorcio di secolo, nonostante le ombre che spesso li
nascondono ai nostri occhi: in campo civile, i progressi
realizzati dalla scienza, dalla tecnica e soprattutto dalla medicina a
servizio della vita umana, il più vivo senso di responsabilità nei
confronti dell'ambiente, gli sforzi per ristabilire la pace e la
giustizia ovunque siano state violate, la volontà di riconciliazione
e di solidarietà fra i diversi popoli, in particolare nei complessi
rapporti fra il Nord ed il Sud del mondo ...; in campo ecclesiale, il
più attento ascolto della voce dello Spirito attraverso l'accoglienza
dei carismi e la promozione del laicato, l'intensa dedizione alla
causa dell'unità di tutti i cristiani, lo spazio dato al dialogo con
le religioni e con la cultura contemporanea ...
47. La riflessione dei fedeli nel
secondo anno di preparazione dovrà convergere con sollecitudine
particolare sul valore dell'unità all'interno della Chiesa, a
cui tendono i vari doni e carismi suscitati in essa dallo Spirito. A
questo proposito si potrà opportunamente approfondire l'insegnamento
ecclesiologico del Concilio Vaticano II contenuto soprattutto nella
Costituzione dogmatica Lumen gentium. Questo importante
documento ha espressamente sottolineato che l'unità del Corpo di
Cristo èfondata sull'azione dello Spirito, è garantita dal
ministero apostolico ed è sostenuta dall'amore vicendevole (cf. 1
Cor 13, 1-8). Tale approfondimento catechetico della fede non potrà
non portare i membri del Popolo di Dio ad una più matura coscienza
delle proprie responsabilità, come pure ad un più vivo senso del
valore dell'obbedienza ecclesiale.(33)
48. Maria, che concepì il
Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo e che poi in tutta la
propria esistenza si lasciò guidare dalla sua azione interiore, sarà
contemplata e imitata nel corso di quest'anno soprattutto come la
donna docile alla voce dello Spirito, donna del silenzio e
dell'ascolto, donna di speranza, che seppe accogliere come Abramo la
volontà di Dio « sperando contro ogni speranza » (Rm 4, 18).
Ella ha portato a piena espressione l'anelito dei poveri di Jahvé,
risplendendo come modello per quanti si affidano con tutto il cuore
alle promesse di Dio.
III anno: Dio Padre
49. Il 1999, terzo ed ultimo
anno preparatorio, avrà la funzione di dilatare gli orizzonti del
credente secondo la prospettiva stessa di Cristo: la prospettiva
del « Padre che è nei cieli » (cf. Mt 5, 45), dal quale
è stato mandato ed al quale è ritornato (cf. Gv 16, 28).
« Questa è la vita eterna: che
conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo
» (Gv 17, 3). Tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio
verso la casa del Padre, di cui si riscopre ogni giorno l'amore
incondizionato per ogni creatura umana, ed in particolare per il «
figlio perduto » (cf. Lc 15, 11-32). Tale pellegrinaggio
coinvolge l'intimo della persona allargandosi poi alla comunità
credente per raggiungere l'intera umanità.
Il Giubileo, centrato sulla figura
di Cristo, diventa così un grande atto di lode al Padre: «
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui
ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi ed
immacolati al suo cospetto nella carità » (Ef 1, 3-4).
50. In questo terzo anno il senso
del « cammino verso il Padre » dovrà spingere tutti a
intraprendere, nell'adesione a Cristo Redentore dell'uomo, un cammino
di autentica conversione, che comprende sia un aspetto «
negativo » di liberazione dal peccato sia un aspetto « positivo »
di scelta del bene, espresso dai valori etici contenuti nella legge
naturale, confermata e approfondita dal Vangelo. È questo il contesto
adatto per la riscoperta e la intensa celebrazione del sacramento
della Penitenza nel suo significato più profondo. L'annuncio
della conversione come imprescindibile esigenza dell'amore cristiano
è particolarmente importante nella società attuale, in cui spesso
sembrano smarriti gli stessi fondamenti di una visione etica
dell'esistenza umana.
Sarà pertanto opportuno,
specialmente in questo anno, mettere in risalto la virtù teologale
della carità, ricordando la sintetica e pregnante affermazione
della prima Lettera di Giovanni: « Dio è amore » (4, 8.16). La
carità, nel suo duplice volto di amore per Dio e per i fratelli, è
la sintesi della vita morale del credente. Essa ha in Dio la sua
scaturigine e il suo approdo.
51. In questa prospettiva,
ricordando che Gesù è venuto ad « evangelizzare i poveri » (Mt 11,
5; Lc 7, 22), come non sottolineare più decisamente l'opzione
preferenziale della Chiesa per i poveri e gli emarginati? Si deve
anzi dire che l'impegno per la giustizia e per la pace in un mondo
come il nostro, segnato da tanti conflitti e da intollerabili
disuguaglianze sociali ed economiche, è un aspetto qualificante della
preparazione e della celebrazione del Giubileo. Così, nello spirito
del Libro del Levitico (25, 8-28), i cristiani dovranno farsi voce di
tutti i poveri del mondo, proponendo il Giubileo come un tempo
opportuno per pensare, tra l'altro, ad una consistente riduzione, se
non proprio al totale condono, del debito internazionale, che pesa sul
destino di molte Nazioni. Il Giubileo potrà pure offrire l'opportunità
di meditare su altre sfide del momento quali, ad esempio, le difficoltà
di dialogo fra culture diverse e le problematiche connesse con il
rispetto dei diritti della donna e con la promozione della famiglia e
del Matrimonio.
52. Ricordando, inoltre, che «
Cristo (...) proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore
svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima
vocazione »,(34) due impegni saranno ineludibili specialmente nel
corso del terzo anno preparatorio: quello del confronto con il sec
larismo e quello del dialogo con le grandi religioni.
Quanto al primo, sarà opportuno
affrontare la vasta tematica della crisi di civiltà, quale è
venuta manifestandosi soprattutto nell'Occidente tecnologicamente più
sviluppato, ma interiormente impoverito dalla dimenticanza o
dall'emarginazione di Dio. Alla crisi di civiltà occorre rispondere
con la civiltà dell'amore, fondata sui valori universali di
pace, solidarietà, giustizia e libertà, che trovano in Cristo la
loro piena attuazione.
53. Per quanto riguarda invece
l'orizzonte della coscienza religiosa, la vigilia del Duemila sarà
una grande occasione, anche alla luce degli avvenimenti di questi
ultimi decenni, per il dialogo interreligioso, secondo le
chiare indicazioni date dal Concilio Vaticano II nella Dichiarazione Nostra
aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non
cristiane.
In tale dialogo dovranno avere un
posto preminente gli ebrei e i musulmani. Voglia Dio che a sigillo di
tali intenzioni si possano realizzare anche incontri comuni in
luoghi significativi per le grandi religioni monoteiste.
Si studia, in proposito, come
predisporre sia storici appuntamenti a Betlemme, Gerusalemme e sul
Sinai, luoghi di grande valenza simbolica, per intensificare il
dialogo con gli ebrei e i fedeli dell'Islam, sia incontri con
rappresentanti delle grandi religioni del mondo in altre città.
Sempre tuttavia si dovrà far attenzione a non ingenerare pericolosi
malintesi, ben vigilando sul rischio del sincretismo e di un facile e
ingannevole irenismo.
54. In tutto questo ampio
orizzonte di impegni, Maria Santissima, figlia prescelta del
Padre, sarà presente allo sguardo dei credenti come esempio perfetto
di amore, sia verso Dio che verso il prossimo. Come Ella stessa
afferma nel cantico del Magnificat, grandi cose ha fatto in lei
l'Onnipotente, il cui nome è Santo (cf. Lc 1, 49). Il Padre ha
scelto Maria per una missione unica nella storia della
salvezza: quella di essere Madre dell'atteso Salvatore. La Vergine ha
risposto alla chiamata di Dio con una piena disponibilità: « Eccomi,
sono la serva del Signore » (Lc 1, 38). La sua maternità,
iniziata a Nazaret e vissuta sommamente a Gerusalemme sotto la Croce,
sarà sentita in quest'anno come affettuoso e pressante invito rivolto
a tutti i figli di Dio, perché facciano ritorno alla casa del Padre
ascoltando la sua voce materna: « Fate quello che Cristo vi dirà »
(cf. Gv 2, 5).
c) In vista della
celebrazione
55. Un capitolo a sé è
costituito dalla celebrazione stessa del Grande Giubileo, che
avverrà contemporaneamente in Terra Santa, a Roma e nelle Chiese
locali del mondo intero. Soprattutto in questa fase, la fase
celebrativa, l'obiettivo sarà la glorificazione della Trinità,
dalla quale tutto viene e alla quale tutto si dirige, nel mondo e
nella storia. A questo mistero guardano i tre anni di preparazione
immediata: da Cristo e per Cristo, nello Spirito Santo, al Padre. In
questo senso la celebrazione giubilare attualizza ed insieme anticipa
la meta e il compimento della vita del cristiano e della Chiesa in Dio
uno e trino.
Essendo però Cristo l'unica via
di accesso al Padre, per sottolinearne la presenza viva e salvifica
nella Chiesa e nel mondo, si terrà a Roma, in occasione del Grande
Giubileo, il Congresso eucaristico internazionale. Il Duemila
sarà un anno intensamente eucaristico: nel sacramento
dell'Eucaristia il Salvatore, incarnatosi nel grembo di Maria
venti secoli fa, continua ad offrirsi all'umanità come sorgente di
vita divina.
La dimensione ecumenica ed
universale del Sacro Giubileo, potrà opportunamente essere
evidenziata da un significativo incontro pancristiano. Si
tratta di un gesto di grande valore e per questo, ad evitare equivoci,
esso va proposto correttamente e preparato con cura, in atteggiamento
di fraterna collaborazione con i cristiani di altre Confessioni e
tradizioni, nonché di grata apertura a quelle religioni i cui
rappresentanti volessero esprimere la loro attenzione alla gioia
comune di tutti i discepoli di Cristo.
Una cosa è certa: ciascuno è
invitato a fare quanto è in suo potere, perché non venga trascurata
la grande sfida dell'Anno 2000, a cui è sicuramente connessa una
particolare grazia del Signore per la Chiesa e per l'intera umanità.
V
«
GESÙ CRISTO È LO STESSO (...) SEMPRE »
(Eb 13, 8)
56. La Chiesa perdura da 2000
anni. Come l'evangelico granello di senapa, essa cresce fino a
diventare un grande albero, capace di coprire con le sue fronde
l'intera umanità (cf. Mt 13, 31-32). Il Concilio Vaticano II
nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, considerando la questione dell'appartenenza
alla Chiesa e della ordinazione al Popolo di Dio, così si
esprime: « Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica
unità del Popolo di Dio (...) alla quale in vario modo appartengono o
sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in
Cristo, sia, infine, tutti gli uomini, che dalla grazia di Dio sono
chiamati alla salvezza ».(35) Paolo VI, da parte sua, nell'Enciclica Ecclesiam
suam illustra l'universale coinvolgimento degli uomini nel disegno
di Dio, sottolineando i vari cerchi del dialogo della salvezza.(36)
Alla luce di tale impostazione si
può comprendere meglio anche la parabola evangelica del lievito (cf. Mt
13, 33): Cristo, come lievito divino, penetra sempre più
profondamente nel presente della vita dell'umanità diffondendo
l'opera della salvezza da Lui compiuta nel Mistero pasquale. Egli
avvolge inoltre nel suo dominio salvifico anche tutto il passato del
genere umano, cominciando dal primo Adamo.(37) A lui appartiene il futuro:
« Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre » (Eb 13,
8). La Chiesa da parte sua « mira a questo solo: a continuare, sotto
la guida dello Spirito Paraclito, l'opera stessa di Cristo, il quale
è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e
non a condannare, a servire e non ad essere servito ».(38)
57. E perciò, sin dai tempi
apostolici, continua senza interruzione la missione della Chiesa all'interno
della universale famiglia umana. La prima evangelizzazione interessò
soprattutto la regione del Mediterraneo. Nel corso del primo millennio
le missioni, partendo da Roma e da Costantinopoli, portarono il
cristianesimo nell'intero continente europeo.
Contemporaneamente esse si diressero verso il cuore dell'Asia,
fino all'India ed alla Cina. La fine del XV secolo, insieme con la
scoperta dell'America, segnò l'inizio dell'evangelizzazione in
quel grande continente, al sud e al nord. Nello stesso tempo, mentre
le coste sub-sahariane dell'Africa accoglievano la luce di
Cristo, san Francesco Saverio, patrono delle missioni, giungeva fino
al Giappone. A cavallo dei secoli XVIII e XIX, un laico, Andrea Kim,
recò il cristianesimo in Corea; in quella stessa epoca l'annuncio
evangelico raggiunse la Penisola indocinese, come pure l'Australia
e le isole del Pacifico.
Il XIX secolo ha registrato una
grande attività missionaria tra i popoli dell'Africa. Tutte
queste opere hanno dato frutti che perdurano fino ad oggi. Il Concilio
Vaticano II ne dà conto nel Decreto Ad Gentes sull'attività
missionaria. Dopo il Concilio la questione missionaria è stata
trattata nell'Enciclica Redemptoris missio, relativa ai
problemi delle missioni in quest'ultima parte del nostro secolo. La
Chiesa anche in futuro continuerà ad essere missionaria: la
missionarietà infatti fa parte della sua natura. Con la caduta di
grandi sistemi anticristiani nel continente europeo, del nazismo prima
e poi del comunismo, si impone il compito urgente di offrire
nuovamente agli uomini e alle donne dell'Europa il messaggio liberante
del Vangelo.(39) Inoltre, come afferma l'Enciclica Redemptoris
missio, si ripete nel mondo la situazione dell'Areopago di
Atene, dove parlò san Paolo.(40) Oggi sono molti gli « areopaghi
», e assai diversi: sono i vasti campi della civiltà contemporanea e
della cultura, della politica e dell'economia. Più l'Occidente si
stacca dalle sue radici cristiane, più diventa terreno di missione, nella
forma di svariati « areopaghi ».
58. Il futuro del mondo e della
Chiesa appartiene alle giovani generazioni che, nate in questo
secolo, saranno mature nel prossimo, il primo del nuovo millennio. Cristo
attende i giovani, come attendeva il giovane che gli pose la
domanda: « Che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?
» (Mt 19, 16). Alla stupenda risposta che Gesù gli diede ho
fatto riferimento nella recente Enciclica Veritatis splendor, come,
in precedenza, nella Lettera ai giovani di tutto il mondo del
1985. I giovani, in ogni situazione, in ogni regione della terra non
cessano di porre domande a Cristo: lo incontrano e lo cercano per
interrogarlo ulteriormente. Se sapranno seguire il cammino che
Egli indica, avranno la gioia di recare il proprio contributo alla sua
presenza nel prossimo secolo e in quelli successivi, sino al
compimento dei tempi. « Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre ».
59. In conclusione, tornano
opportune le parole della Costituzione pastorale Gaudium et spes: «
La Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà all'uomo,
mediante il suo Spirito, luce e forza perché l'uomo possa rispondere
alla suprema sua vocazione; né è dato in terra un altro nome agli
uomini, in cui possano salvarsi. Crede ugualmente di trovare nel
suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine dell'uomo nonché
di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che al di
sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano;
esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo
stesso: ieri, oggi e nei secoli. Così nella luce di Cristo, immagine
del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature, il Concilio
intende rivolgersi a tutti per illustrare il mistero dell'uomo e per
cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del
nostro tempo ».(41)
Mentre invito i fedeli ad elevare
al Signore insistenti preghiere per ottenere i lumi e gli aiuti
necessari nella preparazione e nella celebrazione del Giubileo ormai
prossimo, esorto i Venerati Fratelli nell'Episcopato e le Comunità
ecclesiali a loro affidate ad aprire il cuore ai suggerimenti dello
Spirito. Egli non mancherà di muovere gli animi perché si dispongano
a celebrare con fede rinnovata e generosa partecipazione il grande
evento giubilare.
Affido questo impegno di tutta la
Chiesa alla celeste intercessione di Maria, Madre del Redentore. Ella,
la Madre del bell'amore, sarà per i cristiani incamminati verso il
grande Giubileo del terzo millennio la Stella che ne guida con
sicurezza i passi incontro al Signore. L'umile Fanciulla di Nazaret,
che duemila anni fa offerse al mondo il Verbo incarnato, orienti
l'umanità del nuovo millennio verso Colui che è « la luce vera,
quella che illumina ogni uomo » (Gv 1, 9).
Con questi sentimenti a tutti
imparto la mia Benedizione.
Dal Vaticano, il 10 novembre
dell'anno 1994, diciassettesimo di Pontificato.